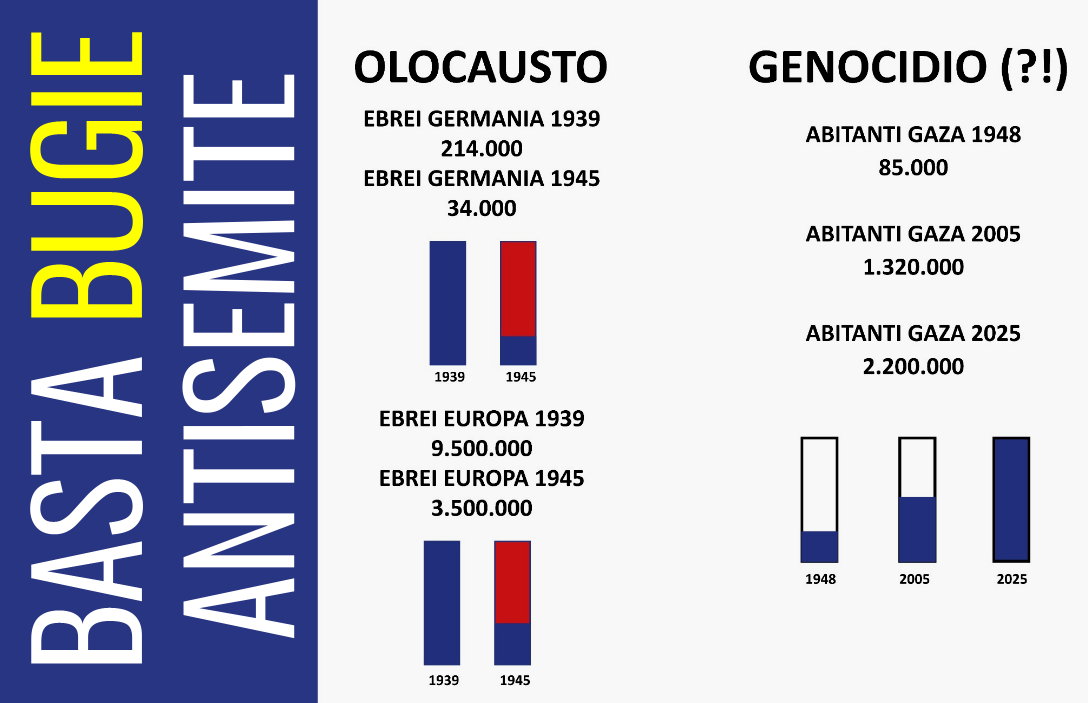L’attacco statunitense in Nigeria non può essere considerato un fulmine a ciel sereno, né un gesto impulsivo di un dottor Stranamore ma è semmai il risultato di una somma di fattori che Washington tiene insieme da tempo, e che negli ultimi mesi hanno superato una soglia di tollerabilità. Terrorismo regionale, interessi strategici, instabilità cronica e un vuoto di potere che altri attori globali sono pronti a riempire. Gli Stati Uniti hanno deciso di intervenire perché la Nigeria, oggi, è diventata un nodo critico che riguarda molto più dell’Africa occidentale.
Il primo livello è quello della sicurezza. La Nigeria è da anni il principale teatro operativo di Boko Haram e delle sue ramificazioni, gruppi jihadisti che hanno giurato fedeltà allo Stato islamico e che operano con una crescente capacità transfrontaliera. Le aree del Borno, dello Yobe e dell’Adamawa sono diventate un santuario instabile da cui partono attacchi contro civili, infrastrutture e forze di sicurezza locali. Per Washington non è più solo un problema nigeriano: è un bacino di reclutamento e addestramento che rischia di saldarsi con altre reti jihadiste attive nel Sahel.
Ma c’è anche un secondo livello che è quello che riguarda la protezione di interessi diretti. In Nigeria operano infatti molte aziende occidentali, tra cui statunitensi, legate soprattutto al settore energetico. Stiamo parlando di oleodotti, terminali, piattaforme offshore e snodi logistici sono stati più volte colpiti o minacciati. In un contesto globale già segnato da crisi energetiche, instabilità in Medio Oriente e tensioni nel Mar Rosso, Washington non può permettersi che un altro grande produttore di petrolio e gas vada fuori controllo. L’attacco, nelle intenzioni dell’amministrazione americana, serve anche a ristabilire una linea rossa che affermi che alcune infrastrutture non sono negoziabili.
Va considerarto anche il fattore politico-militare interno alla Nigeria. L’esercito nigeriano è numeroso, ma afflitto da problemi strutturali come la corruzione, le carenze operative, le rivalità interne e un rapporto spesso conflittuale con le popolazioni locali. Gli Stati Uniti hanno per anni investito in addestramento e cooperazione con risultati però discontinui. L’operazione americana sembra voler mandare un messaggio chiaro anche ad Abuja, che è la capitale e la sede del potere centrale nigeriano. Il messaggio trumpiano riafferma che l’alleanza esiste, ma non è incondizionata. Se lo Stato non riesce a controllare porzioni decisive del proprio territorio, qualcun altro interverrà.
C’è infine una dimensione geopolitica perché la Nigeria è un obiettivo che è entrato nel mirino di Cina e Russia. Pechino investe infatti in infrastrutture, telecomunicazioni e miniere e Mosca, da parte sua, offre armi, contractor e sostegno politico senza fare troppe domande. Per Washington, lasciare campo libero significherebbe perdere la propria influenza in un paese che è demograficamente destinato a diventare uno dei giganti del XXI secolo. L’attacco è dunque anche un segnale preventivo: l’Africa occidentale non è una zona franca per la competizione tra potenze.
Per questo l’azione americana è stata rapida, circoscritta e comunicata il minimo indispensabile. Non si tratta di un episodio bellico vero e proprio né di un cambio di regime, ma semmai di una dimostrazione di forza selettiva. Il messaggio finale è duplice. Il primo, destinato ai gruppi jihadisti e che dice che non esistono retrovie sicure. Il secondo è invece diretto agli alleati e ai rivali: gli Stati Uniti usano e useranno la forza quando i loro interessi vitali vengono minacciati da chicchessia. Sempre che qualcosa non sfugga di mano, che qualche elemento si intrometta nell’ingranaggio fermando la macchina e facendo saltare i motori. Cosa che nessuno si augura ma che non pochi temono.
Washington attacca la Nigeria
Washington attacca la Nigeria