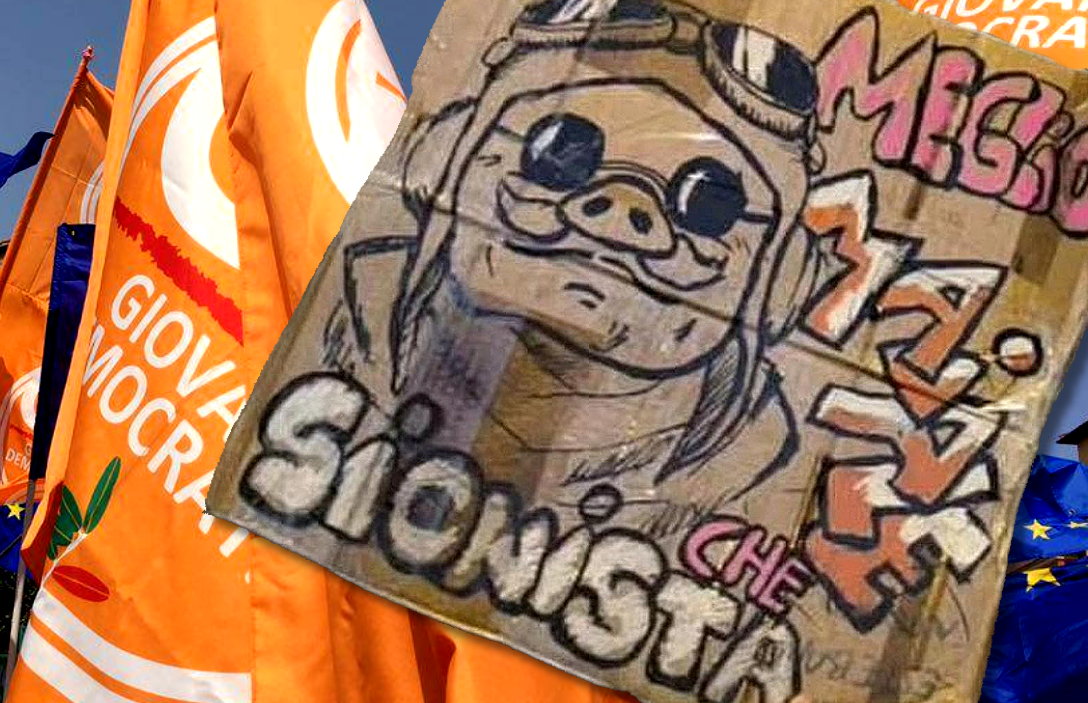Le dimissioni di Wafik Safa segnano un passaggio che, per chi osserva Hezbollah da vicino, ha il sapore dell’eccezionalità. Non capita spesso che un uomo così centrale lasci l’organizzazione, soprattutto quando per anni ha incarnato il volto operativo, opaco e temuto del movimento sciita libanese. Safa non era un semplice funzionario, ma uno dei più stretti collaboratori di Hassan Nasrallah, il suo negoziatore informale, l’uomo incaricato di parlare con lo Stato libanese quando serviva e di far capire, senza troppe parole, quali fossero le linee rosse da non oltrepassare.
Secondo le informazioni diffuse da Reuters e confermate da più fonti regionali, Hezbollah ha accettato le dimissioni di Safa dopo settimane di tensioni interne legate alla volontà del nuovo segretario generale, Naim Qassem, di ridisegnare gli equilibri dell’organizzazione. Non si tratta di un cambio cosmetico, ma di un tentativo più ampio di ristrutturazione che punta a ridurre il peso di figure troppo esposte, compromesse o legate a una stagione che oggi appare meno sostenibile, soprattutto alla luce delle pressioni internazionali e delle difficoltà economiche e militari che il gruppo sta attraversando.
Safa, che secondo diversi resoconti sarebbe sopravvissuto a tentativi di eliminazione durante la guerra, aveva visto progressivamente restringersi il suo raggio d’azione. Qassem avrebbe chiesto che il suo ruolo fosse limitato alle questioni di sicurezza, togliendogli voce nelle dichiarazioni politiche e nei contatti esterni, fino a spingerlo di fatto verso l’uscita. Una scelta che rompe con la tradizione di continuità interna di Hezbollah, storicamente restio a esporre pubblicamente fratture o dissensi.
Il nome di Safa è legato ad alcune delle pagine più cupe del confronto con Israele. Fu parte del comitato che gestì nel 2000 il rapimento dei soldati israeliani sul Monte Dov e partecipò ai negoziati per la restituzione dei corpi di Ehud Goldwasser ed Eldad Regev dopo la Seconda guerra del Libano. In quell’occasione, il suo rifiuto di fornire informazioni fino all’ultimo momento lasciò le famiglie e l’opinione pubblica israeliana sospese in un’attesa crudele, diventando uno dei simboli della strategia psicologica di Hezbollah.
Al di là del passato, ciò che conta oggi è il segnale politico. Le dimissioni di Safa indicano che Hezbollah sta tentando di adattarsi a una fase nuova, in cui il linguaggio della minaccia permanente e dell’esibizione muscolare rischia di essere controproducente. Le indiscrezioni parlano di una possibile redistribuzione delle sue competenze tra figure considerate più presentabili nei rapporti con lo Stato libanese e con l’estero, come Ahmed Mahna o Hussein Abdullah, anche se la mappa finale del potere resta fluida.
Questo passaggio avviene mentre Beirut è attraversata da pressioni crescenti per il disarmo di Hezbollah e mentre il confronto regionale tra Iran e Stati Uniti continua a condizionare ogni mossa del partito armato. In questo quadro, la leadership sembra voler guadagnare tempo e credibilità, cercando di mostrare una capacità di autocorrezione che in passato era impensabile.
Non va sopravvalutata la portata immediata dell’evento. Hezbollah resta una macchina organizzativa solida, con catene di comando e risorse che non dipendono da un singolo uomo. Tuttavia, sottovalutare questa uscita sarebbe un errore. Quando un’organizzazione come Hezbollah accetta di sacrificare una figura storica, significa che qualcosa si sta muovendo sotto la superficie, e che il mito dell’immutabilità interna comincia a mostrare le sue prime, significative crepe.
Una crepa nel cuore di Hezbollah