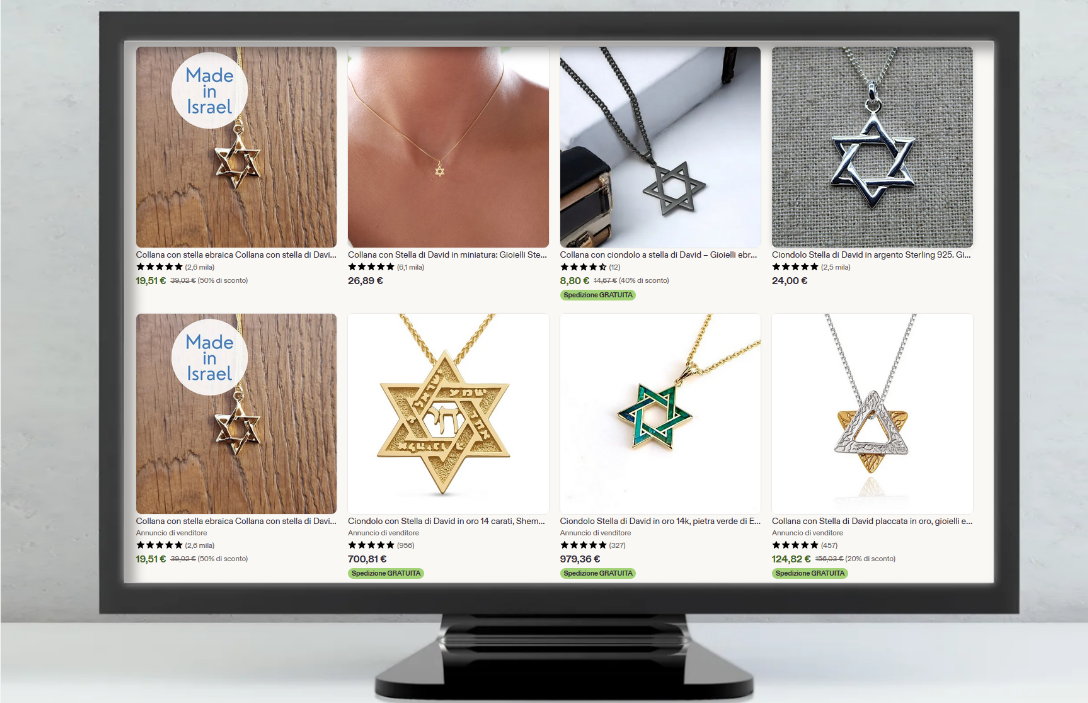L’incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu pare essere servito a definire alcuni punti fermi nella trattativa tra Stati Uniti e Iran: essenzialmente una (abbastanza) chiara risolutezza nel contrastare qualsiasi tipo di arricchimento dell’uranio da parte di Teheran e l’apertura di un confronto sui missili balistici. Rimane in ombra la questione del rapporto tra ayatollah e i vari soci terroristi (Hezbollah, Hamas e Houthi). Ma dopo i colloqui tenuti sotto la minaccia della “armata” americana, si aprirà un confronto sulle sanzioni e questa volta è improbabile che le eventuali risorse recuperate da Teheran possano tornare a finanziare formazioni jihadiste.
Non manca una qualche delusione nell’opinione pubblica democratica globale che sperava in un’accelerata liquidazione dell’omicida dittatura teocratica. Va considerato però che un eventuale accordo tra Teheran e Washington costituirà comunque un altro elemento di delegittimazione del regime. Né va scordato lo scenario nel quale gli eventi, di cui si scrive, avvengono.
Non va sottovalutata la preoccupazione di Riyad che una mossa disperata iraniana possa colpire, come avvenuto nel 2019, impianti di estrazione petrolifera, in una fase in cui, tra l’altro, i piani di modernizzazione annunciati da Mohammad bin Salman stanno rallentando. Né va trascurato il nuovo rapporto che la crisi di Teheran ha favorito tra sauditi e Recep Erdogan, con annesso un Pakistan che offre ai sauditi una copertura nucleare preziosa in caso non si riuscisse a fermare la bomba atomica degli ayatollah: l’asse turchi-sauditi rappresenta una novità con aspetti positivi (aggregare forze che contribuiscano alla distensione è indispensabile) a fattori da valutare nel tempo (l’esprimersi di certe pulsioni egemonistiche possono provocare nuove tensioni: dai curdi agli emiratini).
C’è chi si chiede, in questo senso, se la politica estera americana non sia talvolta troppo personalistica, con inadeguate prospettive strategiche.
Resta il fatto che nonostante tutto la tregua di Gaza tiene ancora, che nel “Board of peace”, in via di decollo per ricostruire la Striscia, c’è una straordinaria rappresentanza del mondo islamico che convive con la presenza di Israele. E, a parte, va notato anche come la Francia sia passata dal riconoscimento immediato dello Stato palestinese alla richiesta all’Onu di licenziare Francesca Albanese.
Va poi preso atto di un’altra decisiva novità: gli accordi tra India e Unione Europea e le nuove intese (non ancora del tutto definite) tra Nuova Delhi e Washington. Una novità molto rilevante, se si riflette su come i feroci attentati di Hamas dell’ottobre del 2023 siano, dai più qualificati osservatori, collegati al fatto che Stati Uniti, Unione europea e Arabia saudita si fossero accordati, esattamente un mese prima, nel lanciare il corridoio economico India-Medio Oriente-Mediterraneo (il cosiddetto Imec) particolarmente osteggiato da Pechino. Tra l’altro, poi, i recenti accordi occidentali prima citati, con Narendra Modi, ci ricordano anche come le intese tra India, Egitto e Grecia costituiscano un altro elemento assai positivo all’interno di uno scenario a lungo così burrascoso come quello su cui scriviamo.
Naturalmente sono molti i fattori che incideranno nel prossimo futuro: per quel che riguarda l’Unione europea il tempo delle attese e delle scelte propagandistiche dei Macron e dei Sanchez, mi pare esaurito. L’Europa responsabile dei Rutte, dei Merz e delle Meloni anche se non si aderirà al Board of Peace, dovrebbe rapidamente esercitare un ruolo nel cuore della vicenda Gaza, trovando il modo di orientare risorse (della Ue? della Nato?) per contribuire alla smilitarizzazione di Hamas e alla denazificazione (cioè l’estirpazione -come nella Germania del dopo 1945- delle predicazioni antisemitiche) della Striscia. Finora l’unico Stato che ha annunciato l’invio di militari con questo obiettivo, è l’Indonesia. Una scelta molto significativa ma evidentemente non risolutiva.
Spagna, l’antisemitismo che cresce nel silenzio
Trump e Netanyahu si sono incontrati a Washington