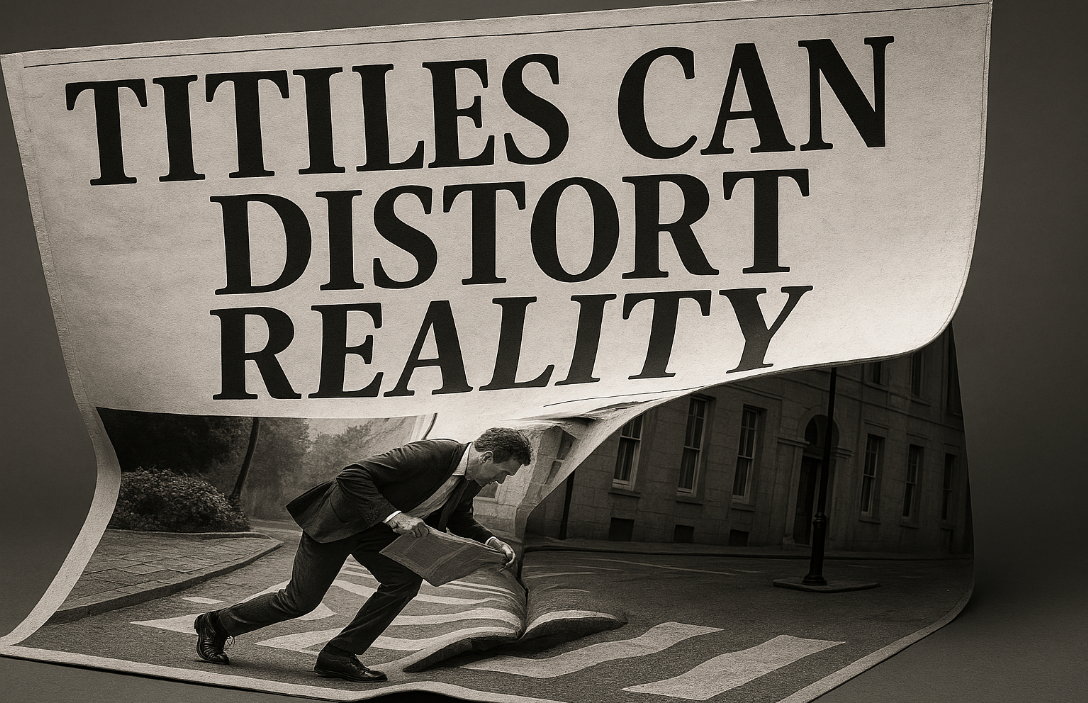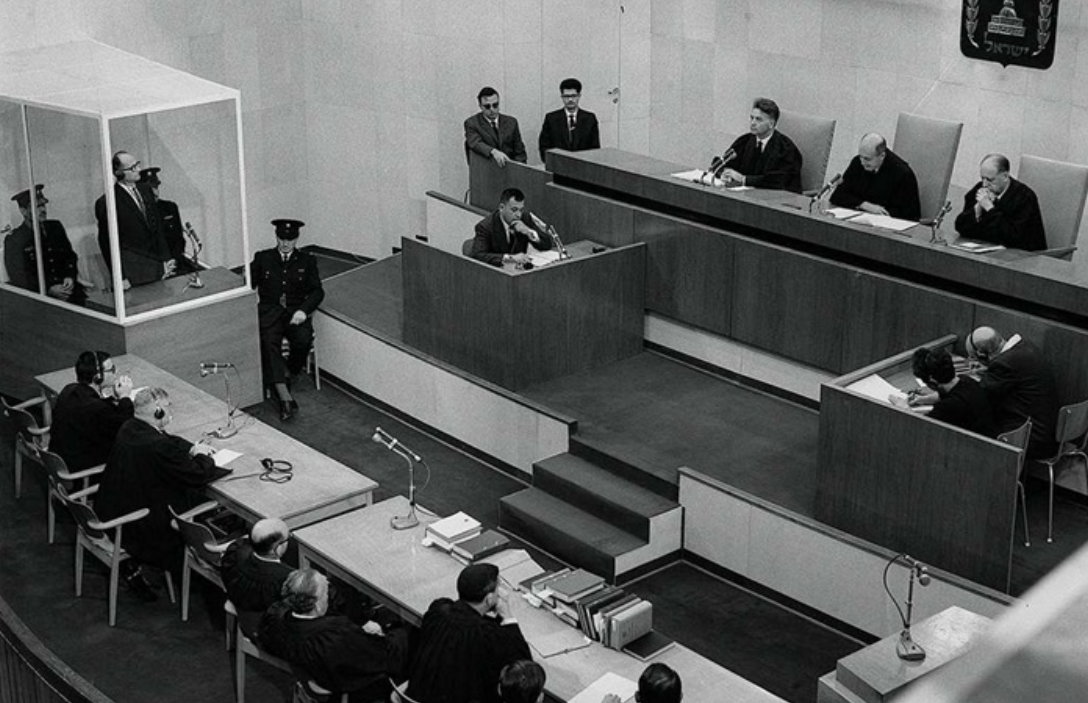Dopo il disastro dell’incontro in Alaska, nel quale Trump si è fatto beffare da Putin — che ha incassato il rilancio nella comunità internazionale — il Presidente degli Stati Uniti, dopo essersi leccato le ferite, ha adottato per Gaza una linea completamente diversa. In sostanza, ha cominciato a fare politica.
Il primo passo è stato ricostruire lo schieramento del Patto di Abramo, che l’Iran aveva fatto saltare attraverso l’operazione del 7 ottobre condotta da Hamas. Trump, dopo aver ricomposto l’asse con i Paesi arabi moderati e trovato un punto di intesa anche con il Qatar — da sempre al centro delle operazioni più ambigue, compreso il finanziamento a Hamas — è intervenuto con una forza politica inaspettata, mettendo con le spalle al muro sia Netanyahu sia Hamas.
Di suo, Netanyahu non solo aveva esagerato nella risposta militare dopo il 7 ottobre, ma aveva anche oltrepassato i limiti della diplomazia tentando di far fuori la delegazione di Hamas durante i colloqui in Qatar. A quel punto Trump lo ha bloccato, costringendolo ad accettare il terreno di una trattativa di pace fondata su 20 punti che avvantaggiano Israele, sia nell’immediato sia in prospettiva.
Contemporaneamente, Trump ha minacciato Hamas: o accettava i termini dell’accordo o avrebbe subito un’offensiva militare raddoppiata. Hamas ha ceduto e compiuto due atti decisivi. Il primo, immediato: la restituzione degli ostaggi israeliani superstiti, perdendo così il principale strumento di ricatto. Il secondo, di medio periodo: l’accettazione di un disarmo sostanziale. Su questo punto si apriranno inevitabilmente giochi e tensioni interne, ma è chiaro che Hamas, priva del potere di deterrenza, rischia di essere annientata sul piano militare.
In definitiva, sulla vicenda di Gaza Trump ha ottenuto un risultato politico di grande rilievo, consentendo a Israele di conseguire anche una vittoria militare. Non è certo un pacificatore seriale — in Ucraina i suoi tentativi restano inconcludenti — ma a Gaza ha registrato un successo che rafforza l’intero campo occidentale.
Da questa prospettiva possiamo anche valutare le dinamiche italiane. Chi scrive non è schierato a favore di questo governo, ma è indubbio che Giorgia Meloni si sia collocata nel verso giusto della Storia: la sua posizione è stata chiara, coerente e allineata alla logica di una pace fondata sul disarmo di Hamas e sul riconoscimento di due popoli, due Stati.
È un’ipotesi difficile, certo, ma realizzabile a due condizioni: la restituzione degli ostaggi — già avvenuta — e il disarmo dell’organizzazione terrorista, partita ancora aperta ma oggi più concreta che mai.
L’altra faccia della medaglia è rappresentata dalle posizioni paradossali della sinistra italiana, che mostra di non gradire l’accordo in via di definizione e finisce così fuori dal perimetro della politica internazionale realistica. Università, collettivi e perfino la Cgil continuano a contestare, come se la pace non fosse un obiettivo ma un pretesto ideologico.
Questa galassia antagonista sembra in sintonia non con la parte di Hamas che ha accettato il disarmo, ma con i suoi residui terroristi irriducibili. È una deriva pericolosa, che riporta alla memoria tempi bui e smarrimenti morali.
Vedere oggi Landini in piazza su queste posizioni induce a una riflessione amara: viene spontaneo rimpiangere la grande Cgil di Giuseppe Di Vittorio, Luciano Lama, Fernando Santi, Bruno Trentin — e persino quella più radicale di Sergio Garavini.
Trump costringe Hamas alla resa. E l’Italia ritrova il verso giusto della Storia
Trump costringe Hamas alla resa. E l’Italia ritrova il verso giusto della Storia