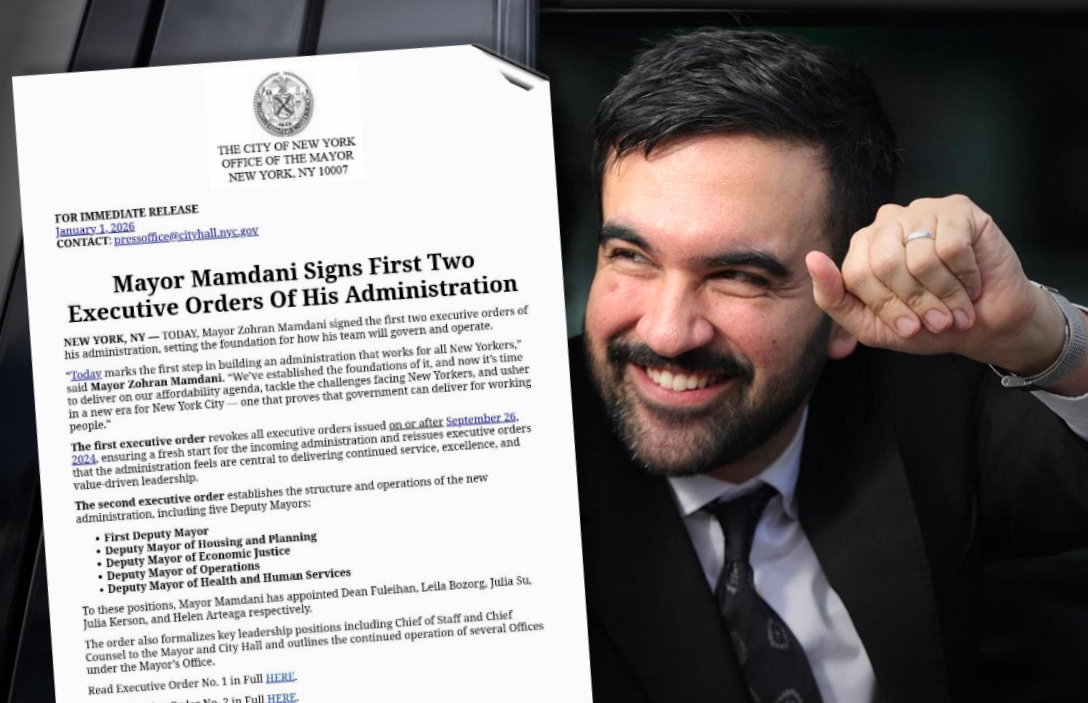Ci risiamo: tribunali morali, liste di proscrizione, petizioni come bandiere rosse. Oggi il bersaglio è Charlotte Gainsbourg, “colpevole” di recitare Gisèle Halimi senza prima giurare fedeltà alla linea. Un’attrice diventa imputata perché ha firmato un testo semplice e umano: riconoscere la Palestina solo dopo la liberazione degli ostaggi e lo smantellamento dei terroristi. In qualunque democrazia seria sarebbe un punto di buon senso. Nel nostro presente ideologico, è un delitto d’opinione.
La tesi dei censori è grottesca e lucidamente autoritaria: per interpretare un personaggio devi coincidere con lui, aderirne al catechismo, recitare non un ruolo ma la dottrina. È la morte del teatro, del cinema e della letteratura. È la morale dell’attore-soldato: allineato, coperto, incolonnato. Si chiamava realismo socialista quando lo facevano gli apparatčik; oggi si chiama “coerenza” o “accountability” quando lo chiedono gli attivisti di timeline. Cambia il lessico, non la sostanza: arte ridotta a ufficio stampa della causa del giorno.
La campagna contro la Gainsbourg confonde deliberatamente l’attrice con il personaggio e pretende il controllo politico sul casting. È un ricatto: o ripeti il nostro slogan, o non lavori. Non interessa Halimi, non interessa la verità storica, non interessa la qualità di un film. Interessa verificare l’ortodossia. E guarda caso l’ortodossia si invoca con più foga quando la “colpevole” è ebrea: allora spunta il sospetto, l’allusione, il processo di piazza. È qui che l’aria si fa davvero irrespirabile.
C’è una bugia antica in questa pulsione. Si finge di difendere la memoria di Halimi, si usa la sua biografia come manganello, ma si cancella la cosa più elementare che Halimi ha insegnato: l’indipendenza di giudizio. Una donna che difese diritti, processi, contraddizioni, non il conformismo. Trasformarla nell’icona di un comitato di censura postmoderno è un insulto alla sua intelligenza.
Il paradosso supremo: si agita il nome “Palestina” per chiedere più silenzio, meno libertà, meno dialogo. Si brandisce la “giustizia” per zittire chi chiede la liberazione degli ostaggi. È la logica dei regimi: il fine nobilita la museruola. Ma la cultura libera non accetta museruole. L’attore che interpreta l’assassino non è un assassino; l’attrice che interpreta Halimi non deve farsi adottare da un partito. L’arte non è un tribunale rivoluzionario, è il luogo dove esploriamo l’ambiguità, il conflitto, gli errori, i chiaroscuri. Dove si prova, si fallisce, si riesce. Dove si pensa.
Il boicottaggio come metodo è la stampella dei deboli di idee. La petizione, il linciaggio digitale, l’insulto di gruppo: strumenti poveri per chi ha paura di discutere sul merito. Se il film sarà brutto, lo diremo. Se sarà bello, lo diremo. Il resto è inquisizione.
Non è un caso francese. È un vento che soffia ovunque: sugli scaffali delle librerie, sulle scene dei teatri, nei festival, nelle università. Si annulla, si interdice, si purifica. Una società che pretende attori senza fratture genera cittadini senza spina dorsale. È l’anticamera del conformismo autoritario, quella zona grigia in cui la paura di sbagliare vale più del coraggio di capire.
La risposta non è un’altra lista di buoni e cattivi. È una regola minima, liberale, igienica: nessun test ideologico per salire su un palcoscenico. Nessun comitato di virtù per distribuire ruoli. Giù le mani dal casting, giù le mani dai libri, giù le mani dalle coscienze. Chi vuole imporre la lezione di partito all’arte ci porta dritti al realismo delle caserme: propaganda travestita da cultura.
Difendere Charlotte Gainsbourg oggi non è tifare per una star. È tutelare il diritto di tutti a raccontare storie senza chiedere permesso ai guardiani della purezza. È dire, senza giri: da qui la nuova censura non passa. Perché se passa, domani non resterà in piedi nessun palco. E, con esso, si spegnerà quel poco di libertà che ancora ci ostiniamo a chiamare cultura.
Teatro dell’assurdo: quando l’arte deve inchinarsi all’ideologia
Teatro dell’assurdo: quando l’arte deve inchinarsi all’ideologia