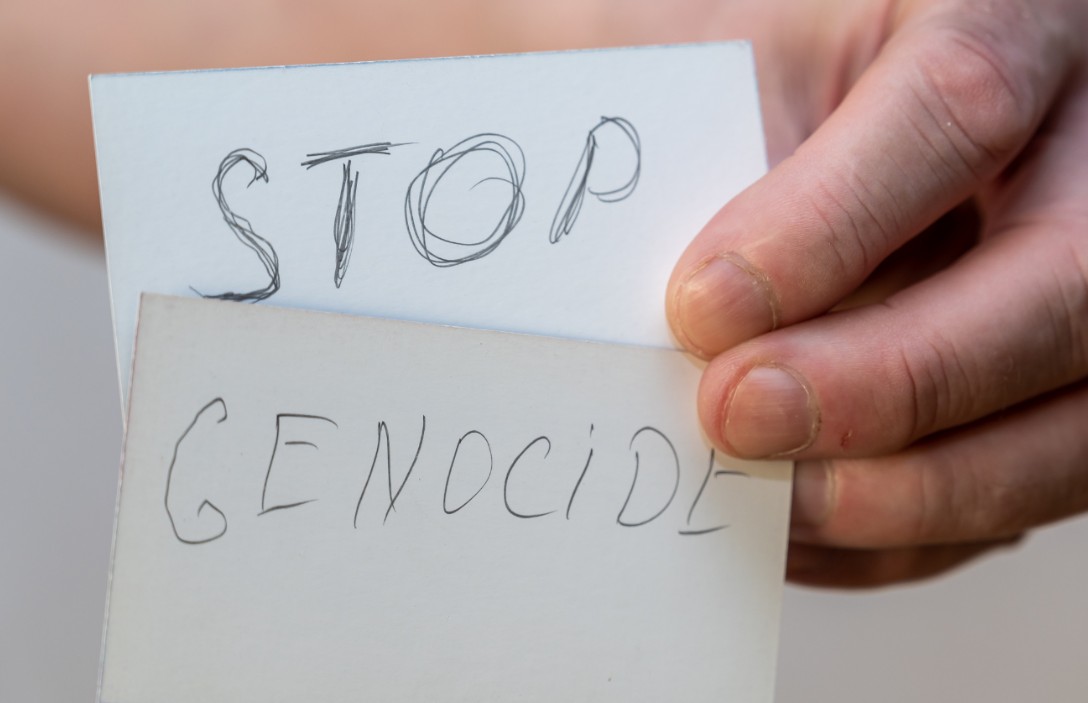C’è una parola che negli ultimi anni ha conosciuto una fortuna tanto rapida quanto sospetta, una parola che viene evocata con disinvoltura crescente nei talk show, nelle piazze militanti, nei campus universitari e nei social network, fino a diventare una specie di grimaldello morale buono per ogni conflitto che si voglia semplificare e caricare di un’aura assoluta. È la parola “genocidio”, termine che nasce in un contesto preciso, con un significato giuridico rigoroso e una storia tragicamente definita, e che oggi viene invece usato come clava politica, slogan identitario, scorciatoia emotiva.
Vale la pena tornare all’origine, perché le parole non sono neutre e nemmeno elastiche all’infinito. “Genocidio” è un neologismo coniato nel 1944 dal giurista Raphael Lemkin, ebreo polacco fuggito dal nazismo, che cercava un termine capace di descrivere ciò che stava accadendo agli ebrei d’Europa e ad altri gruppi perseguitati dal regime hitleriano. Lemkin non parlava genericamente di stragi o di massacri, ma di un progetto sistematico di distruzione di un gruppo umano in quanto tale, fondato sull’intenzione deliberata di eliminarlo fisicamente, culturalmente, biologicamente. Da qui, nel 1948, la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, che stabilisce criteri stringenti: l’intenzione specifica, il bersaglio collettivo, l’apparato organizzato, la volontà di annientamento.
Questo impianto giuridico non è un dettaglio da addetti ai lavori, ma il cuore stesso del concetto. Senza quell’intenzione dimostrabile, senza quella finalità distruttiva rivolta a un gruppo definito per origine, religione o identità, il genocidio semplicemente non c’è, anche quando la guerra è brutale, anche quando i civili muoiono, anche quando le immagini sono insopportabili. Confondere tutto questo non è solo un errore analitico, è un atto di disonestà intellettuale che produce conseguenze pesanti.
L’uso politico del termine, infatti, segue una logica precisa. Dire “genocidio” non serve a capire un conflitto, ma a chiuderlo, perché trasforma una realtà complessa in una favola morale con carnefici assoluti e vittime senza storia. È una parola che assolve chi la pronuncia da ogni sforzo di analisi, perché se c’è un genocidio in corso allora ogni distinzione salta, ogni contesto diventa irrilevante, ogni responsabilità si polarizza. Non è un caso che venga usata come parola d’ordine nei movimenti più ideologizzati, dove la precisione lessicale è vista come un fastidio e non come un dovere.
Ma il danno più grave non è nemmeno politico, è storico. L’inflazione del termine “genocidio” finisce per svuotare di significato proprio i genocidi reali, quelli che rispondono a quella definizione e che dovrebbero continuare a interrogarci come eventi limite della storia umana. Se tutto diventa genocidio, allora la Shoah, il genocidio armeno, il Ruanda, la Cambogia dei Khmer Rossi smettono di essere ciò che sono stati, cioè progetti di sterminio pianificato, e scivolano in un indistinto mare di tragedie equivalenti. È una forma di amnesia travestita da indignazione, una perdita di memoria che si consuma nel nome di una presunta sensibilità morale.
Smontare questo abuso non significa minimizzare le sofferenze reali né negare la brutalità delle guerre contemporanee. Significa, al contrario, restituire alle parole il loro peso, perché solo così possono aiutarci a capire e non solo a schierarci. Difendere il significato di “genocidio” non è un esercizio accademico, ma un atto di responsabilità verso la storia e verso le vittime vere di quel crimine. Quando una parola così grave viene usata a sproposito, non si colpisce solo il bersaglio del giorno, si indebolisce il linguaggio stesso con cui dovremmo riconoscere l’orrore quando davvero si presenta.
Smontaggi – La parola “genocidio” e il suo logoramento
Smontaggi – La parola “genocidio” e il suo logoramento