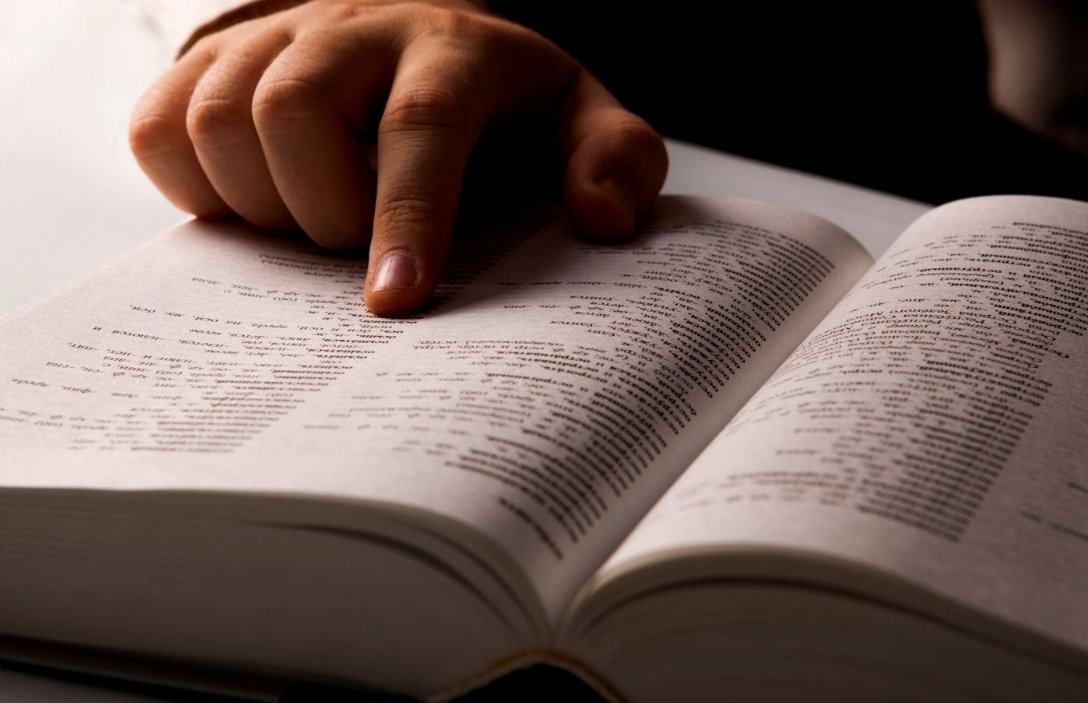Le guerre moderne non cominciano con le sirene ma con tre parole esplosive – genocidio, apartheid, resistenza – dal peso giuridico enorme, trasformate in slogan da corteo e usate come clava morale. Come risultato, l’analisi si spegne e l’eco rimbomba. E quando la parola sostituisce la prova, la verità diventa un accessorio di cui si può tranquillamente fare a meno.
La parola “genocidio” è il vertice del male ed è definita dal diritto con una soglia altissima: non basta contare i morti, serve dimostrare l’intento specifico di distruggere un gruppo in quanto tale. Non “uccidere molti”, ma “annientare quel gruppo perché è quel gruppo”. Una prova che richiede documenti, catene di comando, ordini, coerenza temporale e causale. Eppure la parola viene agitata come una bandiera, tanto che appare nei cartelli, rimbalza nei talk show, scivola nei report che citano altri report. Funziona perché è definitiva: se dici genocidio, vuol dire che hai già giudicato. E un’accusa massima senza il massimo degli standard probatori è propaganda, non certo giustizia.
Apartheid: parola pesantissima, nata per descrivere un sistema codificato di dominazione razziale, con leggi esplicite, registri etnici, diritti separati per principio. Trasportarla altrove richiede un’operazione chirurgica che dovrebbe verificare se esista davvero un regime legale che divide i cittadini per etnia o origine, che nega loro rappresentanza politica, proprietà, mobilità, giustizia. Se le differenze derivano da status giuridico, ostilità armata, frontiere contese, misure di sicurezza o conflitto irrisolto, siamo in un altro campo semantico. Chiamare tutto apartheid serve a produrre un verdetto morale senza passare dal processo della realtà. È comodo ma, piaccia o meno, è completamente falso.
Resistenza, soprattutto per noi italiani antifascisti, è una parola nobile che viene sempre più sporcata dall’uso strumentale. Nel lessico di guerra ha confini: un combattente legittimo si distingue dai civili, mira a obiettivi militari, accetta la reciprocità del diritto. Puntare deliberatamente su civili, scuole, autobus, concerti non è resistenza ma terrorismo. L’idea che “resistenza” santifichi qualsiasi mezzo è un colpo di spugna sul diritto umanitario. È il vecchio trucco del lessico: ribattezzi l’atto e credi di averlo purificato.
Il meccanismo è ricorrente. Si alza il volume delle parole e si abbassa il livello delle prove. L’algoritmo ci mette del suo: termini detonanti generano clic, condivisi in loop fino a sembrare veri per mera esistenza mediatica. Le parole, così, non servono più a descrivere i fatti ma a fabbricarli.
C’è poi l’effetto collaterale più tossico, che è l’inflazione morale. Quando tutto è genocidio, nulla lo è più. Quando tutto è apartheid, la parola perde il potere di nominare l’unico orrore che doveva descrivere. E quando tutto è resistenza, la distinzione tra guerra e massacro si scioglie nel linguaggio. A rimetterci sono le vittime reali, quelle che avrebbero diritto a una verità nitida e non a una retorica urlata.
L’uso politico del vocabolario non è un incidente, ma una vera e propria strategia per spostare l’onere della prova, intimidire il dissenso, ottenere sanzioni e condanne. Se ti opponi, sei “negazionista”; se chiedi standard, “relativista”; se invochi metodo, “complice”. È la logica del tribunale su un social come X: sentenza prima, atti dopo, o magari mai.
Forse servirebbe ripristinare l’igiene del linguaggio: chiedere definizioni operative, cronologie verificabili, catene di responsabilità, confronto fra dataset. Distinguere tra perdita civile tragica e crimine intenzionale contro civili; tra disparità di fatto e regime legale di dominazione; tra legittima difesa e violenza indiscriminata. Accettare che non tutte le tragedie hanno lo stesso nome, e che proprio la dignità del dolore impone precisione.
La guerra delle parole è il fronte dove si decide la memoria. Ciò che oggi chiamiamo in un modo, domani diventa programma, legge e sanzione. Se lasciamo che le parole sostituiscano le prove, la politica si traveste da diritto e la storia si scrive a colpi di etichette. La cura è semplice, anche se impopolare: definizioni chiare, metodo, possibilità di smentita. Chi le rifiuta non sta cercando giustizia ma solo una parola che gli dia ragione.
Smontaggi – La guerra delle parole: genocidio, apartheid, resistenza
Smontaggi – La guerra delle parole: genocidio, apartheid, resistenza