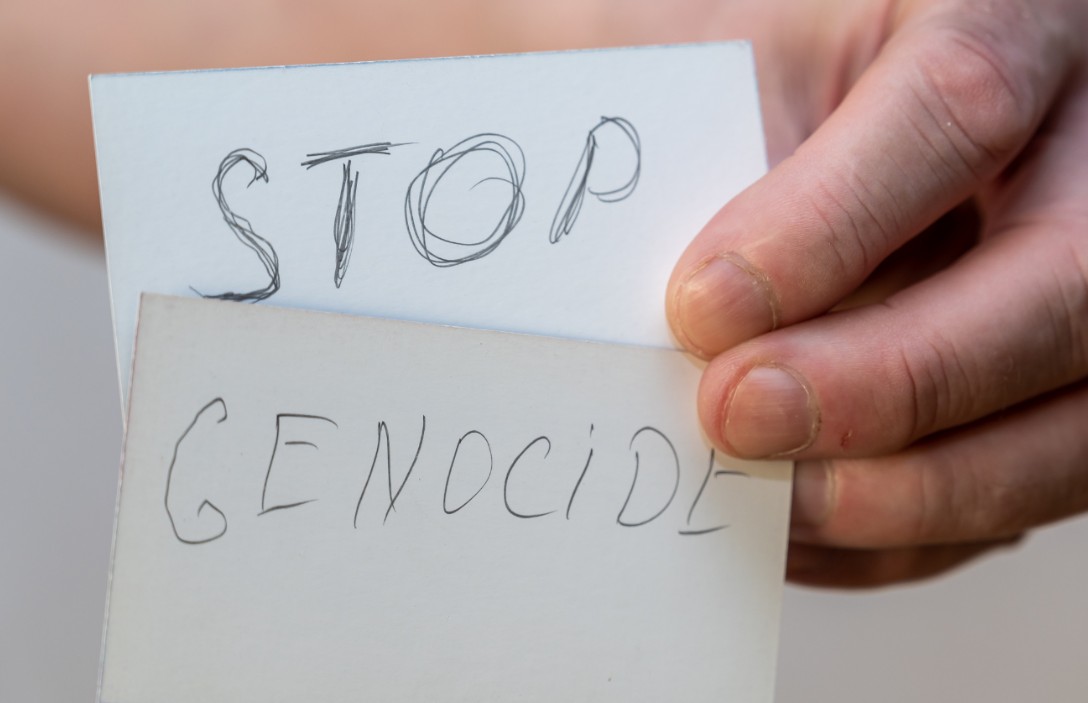Ogni volta che in Occidente si discute dei “palestinesi”, l’immaginario si ferma a Gaza o alla Cisgiordania, come se lì si esaurisse l’intera storia. Eppure, dentro Israele vive un quinto della popolazione che si definisce araba o palestinese, con cittadinanza israeliana piena. Esiste, respira, vota, studia, protesta, e soprattutto sfugge tanto ai cliché filo-israeliani quanto a quelli propal. È una realtà più ostinata delle narrazioni prefabbricate, e per questo viene ignorata.
Il dato di partenza è semplice: i cittadini arabi israeliani godono dei diritti civili e politici di qualunque altro cittadino dello Stato. Possono eleggere e farsi eleggere, dirigere ospedali, università, tribunali; possono diventare medici, deputati, giudici della Corte Suprema. Circa metà degli studenti di medicina sono arabi, così come una parte crescente del personale sanitario, dei docenti universitari e perfino degli imprenditori high-tech. Non è un’eccezione: è il risultato di un’integrazione lenta, incompleta, a tratti dolorosa, ma comunque reale.
Ed è proprio questa realtà a creare l’effetto più disturbante per chi preferisce vedere Israele come un blocco monolitico oppressore: la complessità. Perché accanto ai diritti esistono le contraddizioni, e ignorarle sarebbe ingenuo. Le discriminazioni ci sono, soprattutto in termini di risorse municipali, accesso alla terra, sviluppo infrastrutturale. Esiste una diffidenza reciproca che si tramanda da generazioni, eredità delle guerre, dei sospetti di lealtà divisa. E c’è un dibattito interno alle stesse comunità arabe, spesso dilaniate tra identità nazionale, desiderio di integrazione e la tentazione, talvolta, di radicalizzarsi per marcare una distanza percepita come dignità.
Le contraddizioni si sentono tutte, soprattutto nei momenti di crisi. Il 7 ottobre ha lasciato cicatrici anche qui: famiglie arabe israeliane uccise da Hamas, cittadini arabi rapiti, sindaci arabi che hanno condannato l’attacco senza esitazioni mentre alcuni leader politici preferivano contorcersi in ambiguità ideologiche. Mentre in Europa sfilavano cortei pro-Hamas, nelle città miste di Israele i residenti arabi ebrei cercavano faticosamente di evitare che la violenza li travolgesse. Al netto degli slogan, la convivenza quotidiana è un esercizio molto più concreto e molto meno fotogenico.
C’è però un altro aspetto che merita di essere smontato: l’idea che i palestinesi cittadini israeliani siano “oppressi che non possono parlare”. È falso. Parlano, eccome. Dirigono giornali locali, sono presenti nei media nazionali, siedono in Parlamento, dirigono ONG e manifestazioni. A volte le loro posizioni sono scomode per l’establishment israeliano, altre volte risultano indigeste ai militanti propal che pretendono da loro un’unica identità valida: quella della vittima totale e impotente. In realtà la loro identità è plurale, stratificata, e spesso rifiuta di essere incasellata.
E qui sta il punto critico: questa pluralità non piace a nessuno. Non piace ai sostenitori ossessivi dell’assimilazione forzata, perché sfugge al controllo; non piace ai professionisti della causa palestinese, perché rompe la leggenda della segregazione totale; non piace al pubblico occidentale, che preferisce storie semplici. Ma la vita reale non è semplice, e gli arabi israeliani sono la dimostrazione vivente che il Medio Oriente non è una favola morale in bianco e nero.
Forse è il momento di guardare finalmente a questa comunità per quello che è: una minoranza che vive dentro una democrazia imperfetta ma funzionante, con diritti ampi, contraddizioni profonde e un futuro possibile che passa proprio da ciò che nessuno vuole ascoltare. Le loro voci.
Smontaggi. I palestinesi cittadini israeliani: diritti, contraddizioni, voci ignorate
Smontaggi. I palestinesi cittadini israeliani: diritti, contraddizioni, voci ignorate