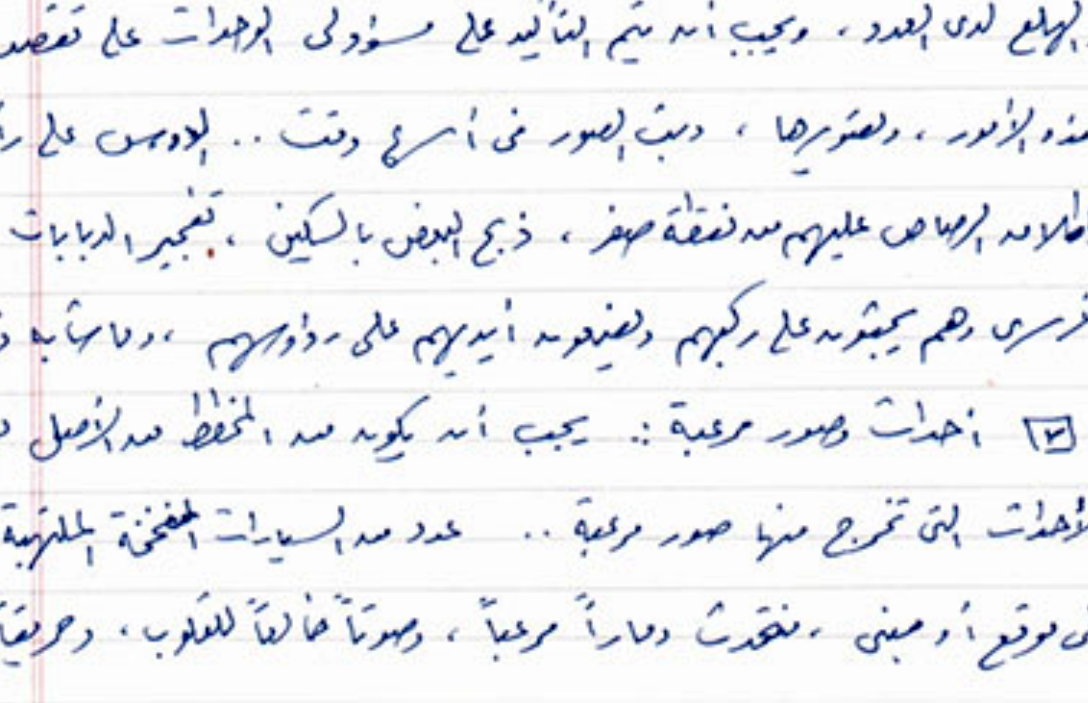Sette ottobre, giorno primo. Non del calendario ebraico, né di quello islamico o cristiano. Ma l’inizio di una frattura. Il giorno in cui la realtà ha strappato via la maschera della finzione e ci ha mostrato – nuda, lacerata, insopportabile – la verità: l’ebraicidio non è memoria, ma progetto. Non è passato, ma presente. Non è finito: ha solo cambiato lingua, strumenti, bandiere.
Sono trascorsi 670 giorni da quel sabato nero, quando i terroristi di Hamas hanno invaso il sud di Israele con la gioia feroce del massacro rituale. Bambini giustiziati, donne stuprate, intere famiglie bruciate vive. Non una guerra, ma una festa dell’odio. E da allora? Silenzio, rimozione, riformulazione. La storia ha corso, ma molti l’hanno fatta correre nella direzione sbagliata. I carnefici sono diventati martiri. Gli ebrei, ancora una volta, messi sotto accusa per il solo fatto di volersi difendere. «Se l’ebreo si difende, diventa colpevole», scriveva Meir Shalev con il tono amaro di chi sapeva leggere l’aria. Oggi, quell’aria è tornata pesante.
In 670 giorni, Israele ha seppellito i suoi morti, ma il mondo ha seppellito la memoria. Si è parlato di Gaza, mai di Nir Oz. Di raid, mai di ostaggi. Di bombe, mai di bambini israeliani trascinati nei tunnel. Le università d’Europa si sono scoperte pronte a boicottare Israele, nonostante da Tel Aviv escano scoperte mediche, intelligenza tecnologica e pluralismo parlamentare. Il mondo accademico ha deciso che l’unico Stato ebraico al mondo debba essere l’unico a non meritare una cattedra, né un partner, né una difesa.
«La pace non si fa con i nemici. Si fa con chi vuole la pace», diceva Shimon Peres. Ma chi oggi invoca la pace, lo fa spesso per zittire l’ebreo che piange, per chiedergli di non lamentarsi mentre viene circondato. In questi 670 giorni, Israele è stato costretto a riscoprire una lezione antica: il diritto alla vita non è garantito, nemmeno dopo la Shoah. Non basta Auschwitz per ottenere empatia. Occorre morire in silenzio, possibilmente senza disturbare la coscienza occidentale.
Eppure Israele è ancora lì, vivo, contraddittorio, armato, democratico. È l’unico luogo dove un ebreo può vivere senza doversi spiegare. Il solo luogo dove «la sicurezza non è un’illusione ma un diritto da costruire ogni giorno», come ricordava Golda Meir. Non un Paese perfetto. Ma un Paese reale, che chiede una sola cosa: non amore, ma rispetto. Non indulgenza, ma equità.
Perché in questi 670 giorni, mentre gli ebrei d’Europa venivano aggrediti nelle strade, nei campus e nei vagoni della metropolitana, l’idea che Israele potesse essere superfluo si è dissolta. Israele non è solo uno Stato: è un’esigenza. È l’assicurazione minima per un popolo che la storia ha già tentato di cancellare troppe volte.
Come osserva Yuval Noah Harari, le società si tengono insieme attraverso narrazioni condivise. E quando la narrazione dominante è che Israele sia il problema e non la soluzione, non ci si deve sorprendere se i crimini contro gli ebrei tornano a essere tollerati. Chi controlla la storia, controlla anche l’empatia.
Lo psicologo Daniel Kahneman ci ha insegnato che la mente umana è predisposta a scorciatoie cognitive, che preferiamo narrazioni semplici, simmetriche, dove tutti hanno torto e nessuno ha ragione. Ma la verità – in Medio Oriente come altrove – non è equidistante. Non lo è quando un gruppo stermina civili e l’altro cerca di liberare ostaggi. Non lo è quando uno Stato difende la propria esistenza e il mondo gli chiede di «non esagerare».
Sette ottobre, giorno primo. Il resto – questi 670 giorni – sono storia ancora in corso. Ma una cosa è certa: chi credeva che Israele sarebbe crollato sotto i colpi del terrorismo, dell’isolamento, del boicottaggio e dell’odio, ha sbagliato i conti. Perché Israele – come il popolo ebraico – non si chiede mai se vivere. Si chiede solo come farlo, e con quanta dignità.
Sette ottobre, giorno primo. E gli altri seicentosettanta Sette ottobre, giorno primo. E gli altri seicentosettanta Sette ottobre, giorno primo. E gli altri seicentosettanta