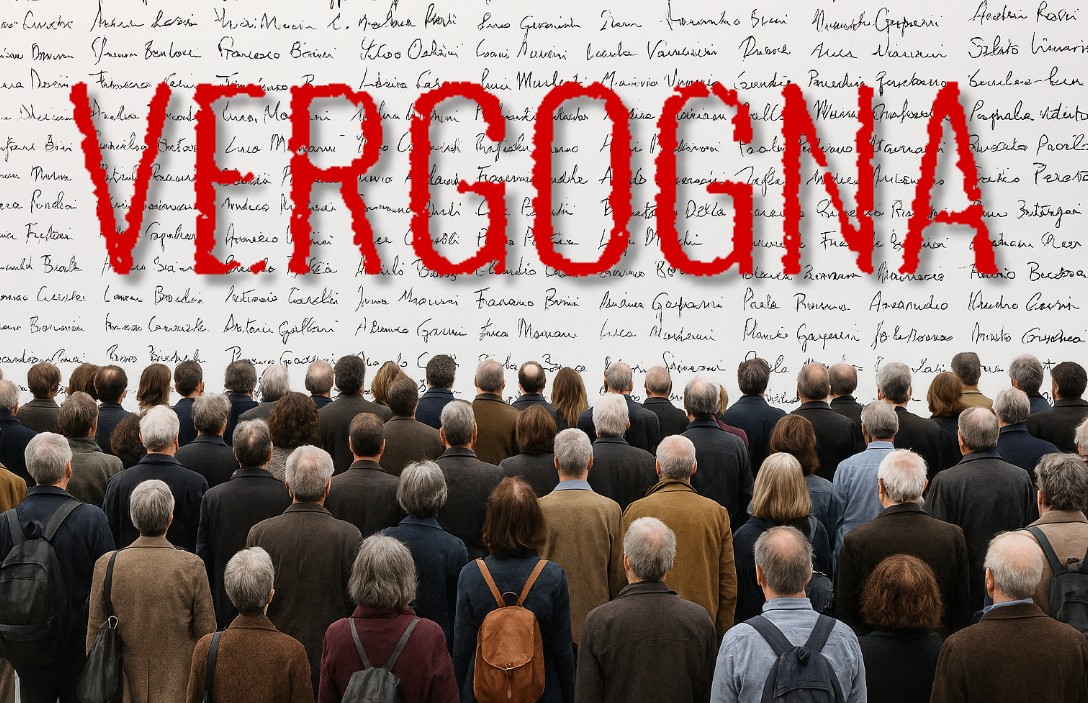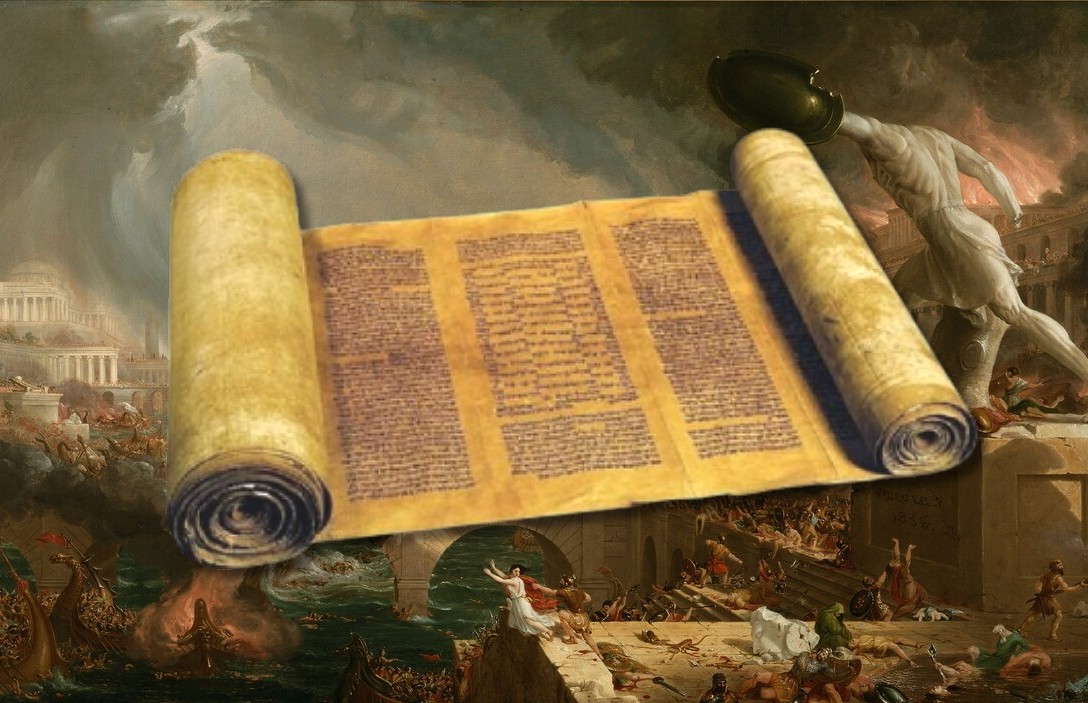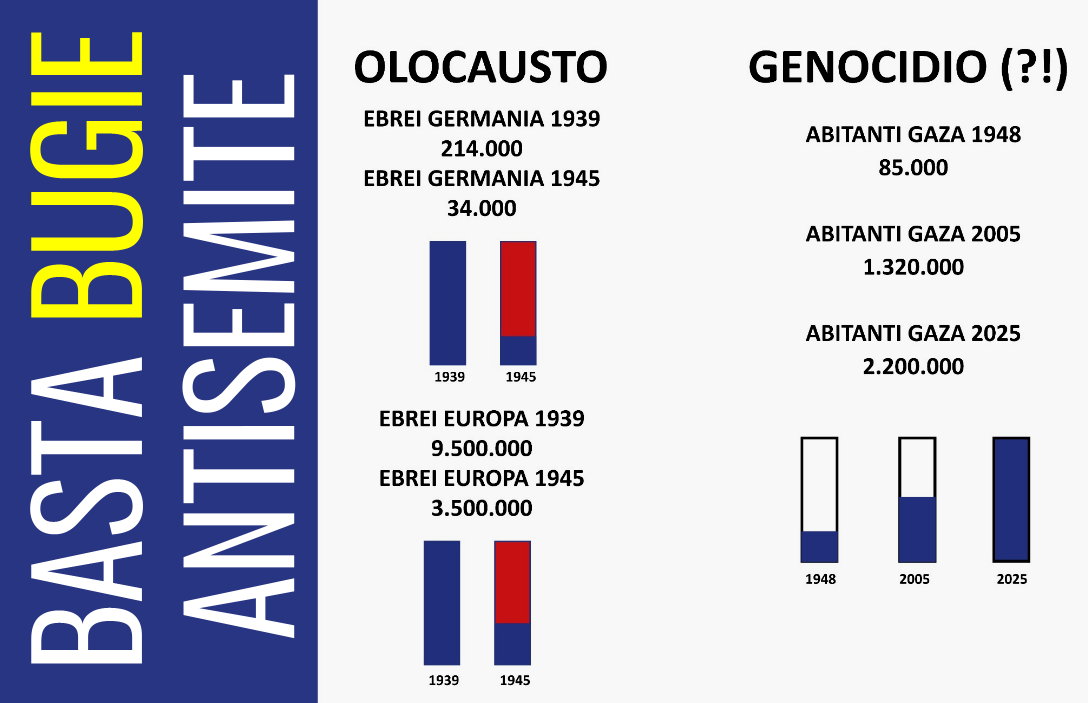Chi è Samir Halila e perché il suo nome incendia Ramallah? Economista sessantottenne, figura di confine tra pubblico e privato: già segretario generale del governo palestinese, poi ai vertici di PADICO (Palestine Development and Investment Company, una delle principali holding d’investimento palestinesi) e della Borsa di Ramallah. Legato al blocco imprenditoriale cittadino e alla città-progetto di Rawabi, Halila è più manager di sistema che politico di partito: l’uomo dei dossier e dei numeri, non dei comizi.
Nell’estate 2025 il suo nome comincia a circolare come possibile “governatore” di Gaza per il giorno dopo la guerra. Un incarico tecnico, sotto l’ombrello della Lega Araba e accettabile a Washington e a Israele, con il compito di ristabilire l’ordine, neutralizzare i residui armati e coordinare una ricostruzione da decine di miliardi. La candidatura corre anche su canali di lobbying internazionale: segnale che il dossier Gaza viene concepito come grande cantiere multilivello e non come feudo di partito.
Halila si dice disponibile, ma precisa che l’ultima parola spetta all’Autorità Nazionale Palestinese e ai donatori. Prova a tenere insieme tre cornici: filo-occidentale, copertura araba, legittimazione interna. È qui che scatta il corto circuito. L’ANP di Mahmoud Abbas vive una successione sospesa e un equilibrio fragile tra apparati che si sorvegliano a vicenda: l’intelligence generale di Majed Faraj, il Ministero dell’Interno con la Sicurezza Preventiva, i governatorati, le correnti di Fatah. Un “commissario” per Gaza scelto fuori dalla filiera tradizionale viene percepito come un bypass dell’unità di comando. Il messaggio della Presidenza è netto: la linea su Gaza non si scrive fuori da Ramallah.
La conferma arriva con i fatti. Il 10 settembre, rientrato da Amman, Halila viene prelevato in un ristorante di Ramallah da squadre della Sicurezza Preventiva. Il tempismo è eloquente: dopo settimane di interviste e contatti sul progetto per Gaza, la sua presenza pubblica è giudicata ingombrante. L’arresto vale più di un comunicato: chi prova a costruire il “giorno dopo” senza passare per i cancelli dell’ANP mette in discussione catene di comando e di rendita, e ne paga il prezzo.
Perché Halila fa paura? Non per il carisma personale. Fa semmai paura l’idea che porta con sé: il “giorno dopo” come grande cantiere di ricostruzione finanziato dal Golfo e garantito dagli Stati Uniti, con valichi aperti, appalti regolati, una governance “accettabile” per Israele. È la versione tecnocratica di un potere alternativo: meno partito, più project management. Per Hamas significherebbe la fine di un’egemonia; per i notabili di Fatah e gli apparati, la perdita di controllo sui rubinetti; per Washington e Gerusalemme, un ordine di fatto senza proclami.
Resta il nodo della legittimazione. Chi nomina chi, con quale mandato e davanti a quale pubblico? Se l’origine della proposta appare in parte esogena e il consenso interno è opaco, Halila finisce schiacciato tra il sospetto di collaborazionismo e l’utilità del suo profilo tecnico. La reprimenda politica ha chiarito l’ambiguità: o il progetto passa dentro l’ANP, o non passa affatto. E se passa dentro, difficilmente lo guiderà chi è arrivato da canali paralleli.
Che cosa racconta il caso Halila del dopo-Gaza? Primo: non verrà da un nome solo, ma da un incastro di apparati di Ramallah, sponsor arabi e garanzie americane, con Israele a fissare i limiti di sicurezza. Secondo: chi salta una casella incontra l’ostilità delle altre. Terzo: la ricostruzione è già l’architrave politica, anche solo come narrazione; chi controlla valichi, flussi e fondi controlla il futuro. In questo quadro Halila è stato un test di laboratorio: ha mostrato che il “giorno dopo” non è un appalto, ma una dote di potere. E quella, a Ramallah, non si esternalizza.
Samir Halila, il tecnocrate che inquieta Ramallah Samir Halila, il tecnocrate che inquieta Ramallah Samir Halila, il tecnocrate che inquieta Ramallah