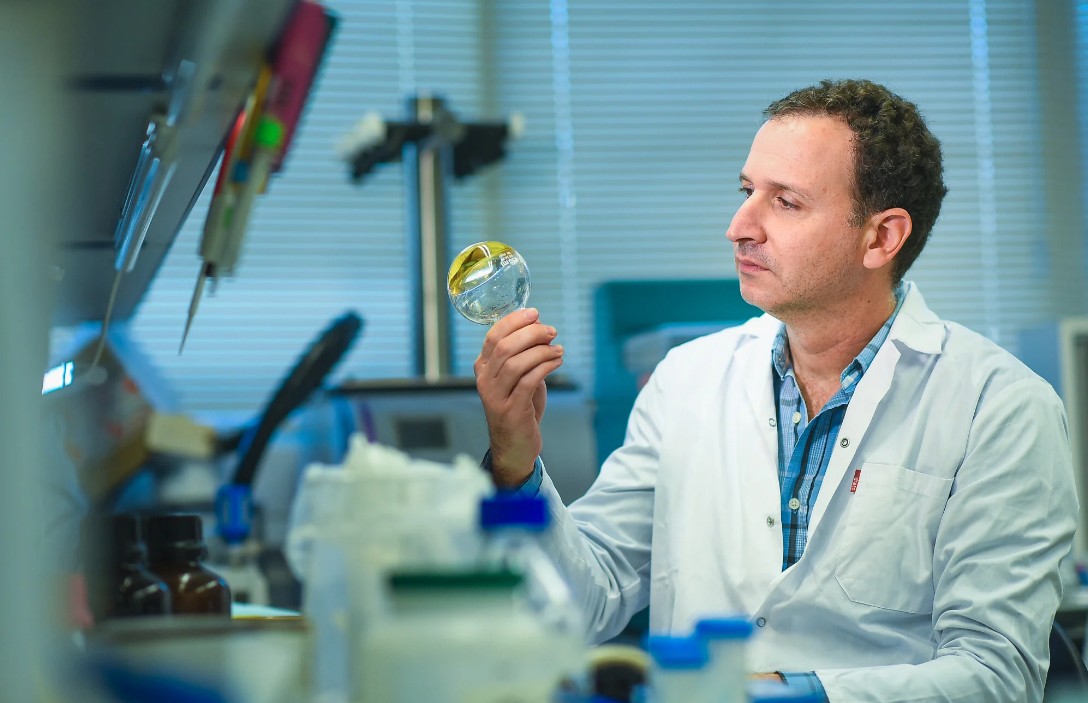La rivelazione è arrivata da un luogo inatteso e da una voce che, nel suo contesto politico, resta minoritaria. Gayton McKenzie, ministro della Cultura, dello Sport e delle Arti del Sudafrica, ha denunciato pubblicamente un tentativo di interferenza straniera all’interno del padiglione sudafricano della Biennale di Venezia, il più importante appuntamento globale per l’arte contemporanea. Un’operazione studiata per rafforzare, in uno spazio simbolico e altamente visibile, l’accusa di “genocidio a Gaza” contro Israele. Dietro quell’azione, secondo fonti politiche sudafricane, ci sarebbe il Qatar.
Il punto non è l’esistenza di opere politicamente impegnate, che da sempre abitano la Biennale, ma il metodo. McKenzie ha parlato di un meccanismo preciso, costruito fuori scena, che avrebbe previsto l’acquisto delle opere sudafricane al termine della mostra da parte di un soggetto estero, creando così un incentivo economico capace di orientare il contenuto artistico verso una specifica agenda. Non uno sponsor ufficiale, non una presa di posizione dichiarata, bensì una pressione indiretta, tanto più efficace quanto meno visibile.
L’opera destinata al padiglione sudafricano affronta temi reali e drammatici come lutto, memoria e riparazione, collegando crimini coloniali in Namibia, violenze contro la comunità LGBT in Sudafrica e la guerra a Gaza, con un omaggio alla poetessa palestinese Heba Abu-Nada, uccisa durante il conflitto. Un intreccio potente, che però, nelle parole del ministro, rischiava di trasformare il Sudafrica in un veicolo per la politica estera di un altro Stato. Una funzione che McKenzie ha rifiutato, arrivando ad annullare il contratto con l’ente produttore della mostra.
La presa di posizione è tanto più significativa perché arriva da un governo che, nel suo complesso, mantiene atteggiamenti apertamente ostili verso Israele, al punto da aver promosso un’azione legale contro lo Stato ebraico davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. McKenzie, ex detenuto per rapina divenuto negli anni un oratore carismatico e una figura politica emergente, rappresenta un’eccezione. È stato l’unico ministro sudafricano a incontrare un rappresentante israeliano dopo il 7 ottobre e ha più volte criticato i tentativi di boicottaggio culturale e sportivo contro Israele.
La vicenda veneziana mette a nudo un aspetto spesso rimosso del confronto internazionale contemporaneo, ovvero l’uso sistematico della cultura come campo di battaglia. Mostre, festival, premi e residenze artistiche diventano spazi nei quali si esercita influenza, si legittimano parole d’ordine e si costruiscono cornici morali. Non servono proclami ufficiali, basta agire sui margini, sui finanziamenti, sulle opportunità di visibilità.
Secondo ambienti diplomatici israeliani, il caso conferma come il Qatar operi da tempo anche sul piano culturale per rafforzare una lettura del conflitto che isola Israele e lo delegittima sul piano simbolico prima ancora che politico. Non a caso, al ministero degli Esteri israeliano si parla sempre più apertamente di una “guerra per la coscienza”, nella quale l’informazione tradizionale non basta più e occorre muoversi nei mondi dell’influenza, dell’arte e della comunicazione.
La domanda sollevata da McKenzie resta sul tavolo ed è difficile da eludere. Se uno Stato dispone di risorse e di una propria linea politica, perché non affermarla apertamente, invece di utilizzare il padiglione di un altro Paese come cassa di risonanza? Alla Biennale di Venezia, tempio dell’ambiguità creativa e della libertà espressiva, questa domanda suona come una nota stonata, ma necessaria. Perché quando la politica entra in galleria senza dichiararsi, non è più solo arte. E non è nemmeno più solo diplomazia.