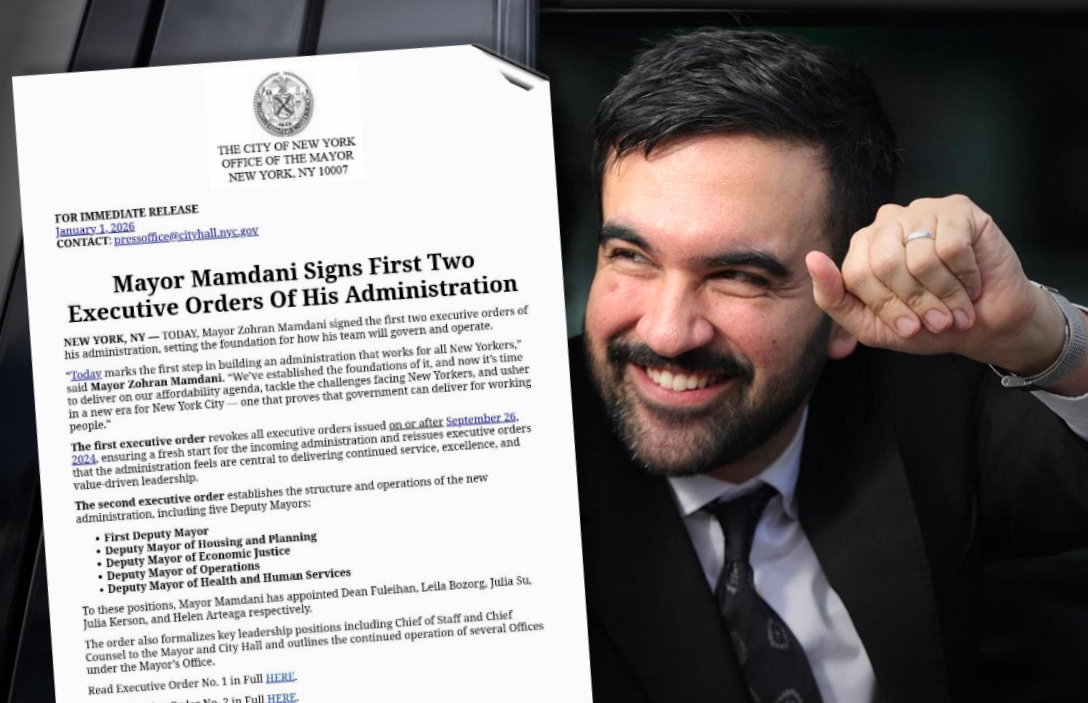Che ora nessuno ci venga a dire che non se l’aspettava. Che nessuno ricorra al frusto, inutile cliché giornalistico del «segnale inquietante», del «si è passato il limite», del «sì, vabbè, ma Gaza?». Questo non è un segnale. È una realtà che è sempre stata lì, sotto gli occhi di tutti. Solo che ora trova nuove, più ripugnanti incarnazioni ed esplode con tutta la brutalità possibile.
Un gruppo di adolescenti ebrei francesi viene fatto scendere da un aereo. Gli si ordina di consegnare i cellulari (non sia mai che qualche video possa compromettere la reputazione di qualcuno), vengono separati dagli accompagnatori (una delle quali, ventunenne, ammanettata), abbandonati in aeroporto, trattati come un problema di ordine pubblico. La colpa? Aver intonato una canzone in ebraico. Aver cantato insieme. Aver mostrato un’identità. Nient’altro.
Siamo a Valencia, nel cuore dell’Europa. Siamo nel 2025. Basta una melodia, una lingua, un simbolo perché l’ebreo diventi «disturbatore», «pericolo», «elemento da contenere». È successo a dei ragazzi. Minorenni. Trattati con un sospetto e una violenza che sanno di secoli antichi e che oggi riaffiorano con naturalezza, quasi con indifferenza.
Non è normale. Non lo sarà mai.
Possiamo smettere di chiamarlo sospetto perché è una certezza. Quella certezza che fino a poco tempo fa qualcuno ancora considerava una paranoia, una distorsione visiva, un’interpretazione iperbolica. Invece era tutto già visibile: l’antisemitismo non è scomparso, ha solo imparato a travestirsi meglio, e adesso si manifesta impunito in aule scolastiche e università, tra forze dell’ordine e amministrazioni, tra politici, ONG, pulpiti religiosi ed esercizi commerciali. Si è costruito una rete di scolo solida, trasversale, compiaciuta.
Chiamiamolo col suo nome: è antisemitismo. Non morto, non dormiente, ma attivo, consapevole, rilegittimato. Rivestito di termini burocratici come «sicurezza», «protocollo», «procedura». Ma il meccanismo è sempre lo stesso: l’ebreo visibile è un problema. Ora sappiamo anche che se è giovane, felice e canta, lo è ancora di più.
Qui non c’è stato alcun fraintendimento. Nessuna emergenza. Nessun motivo reale. Solo una punizione collettiva per il fatto stesso di esistere come gruppo, come identità viva. E chi ha agito – compagnia aerea, autorità aeroportuali, personale di bordo – non può cavarsela con un comunicato svuotato di senso o con una formula anodina.
Non si è trattato di un errore. Si è trattato di un sintomo. Non uno di quelli «inquietanti» evocati da commenti pensosi e prudenti, ma di uno già in metastasi. Un veleno che da mesi circola nel nostro spazio pubblico, intossica il pensiero, altera il linguaggio, annulla la nostra stessa dignità di esseri umani.
Siamo arrivati al punto in cui l’aggressione verso ciò che è ebraico, visibile, fiero non è solo tollerata: è difesa e ammirata. È diventata segno di adesione a un’identità «giusta», «dalla parte giusta», «contro l’occupante», «con i deboli». Tutta questa idolatria delle cause si è fatta complice della menzogna. E della violenza. E del silenzio. E dell’indifferenza.
C’è un punto oltre il quale indignarsi non basta più. Non è più né lecito né tollerabile offrire balsami morali alle coscienze sporche. Bisogna chiamare le cose col loro nome. Questo è un abuso. È una discriminazione. È un’umiliazione inammissibile inflitta a ragazzi inermi. E non riguarda solo loro. Riguarda tutti noi.
Perché se oggi un gruppo di adolescenti ebrei può essere trattato così, domani toccherà ad altri. Quando l’identità diventa colpa, nessuno è al sicuro. Quando la diversità fa paura, la società si droga, si eccita, corre ubriaca fino a schiantarsi.
Chi ha responsabilità deve rispondere. Chi ha scelto di tacere deve spiegare. E noi dobbiamo farci sentire. Per quei ragazzi. Per i loro genitori. Per chi ogni giorno si sente osservato, giudicato, tollerato a fatica.
Non è il momento della moderazione. Non è il momento delle parole tiepide. È il momento di dire che questa Europa, così come si è mostrata in quell’aeroporto, non solo non ci rappresenta ma ci ripugna.
Difendere la libertà di essere se stessi non è un dettaglio. È la linea di confine tra civiltà e degrado. Ora, più che mai, non c’è nulla più da capire, ma solo scegliere – totalmente, inequivocabilmente e orgogliosamente – da che parte stare.
Puniti per una canzone: l’Europa che discrimina VPuniti per una canzone: l’Europa che discrimina Puniti per una canzone: l’Europa che discrimina