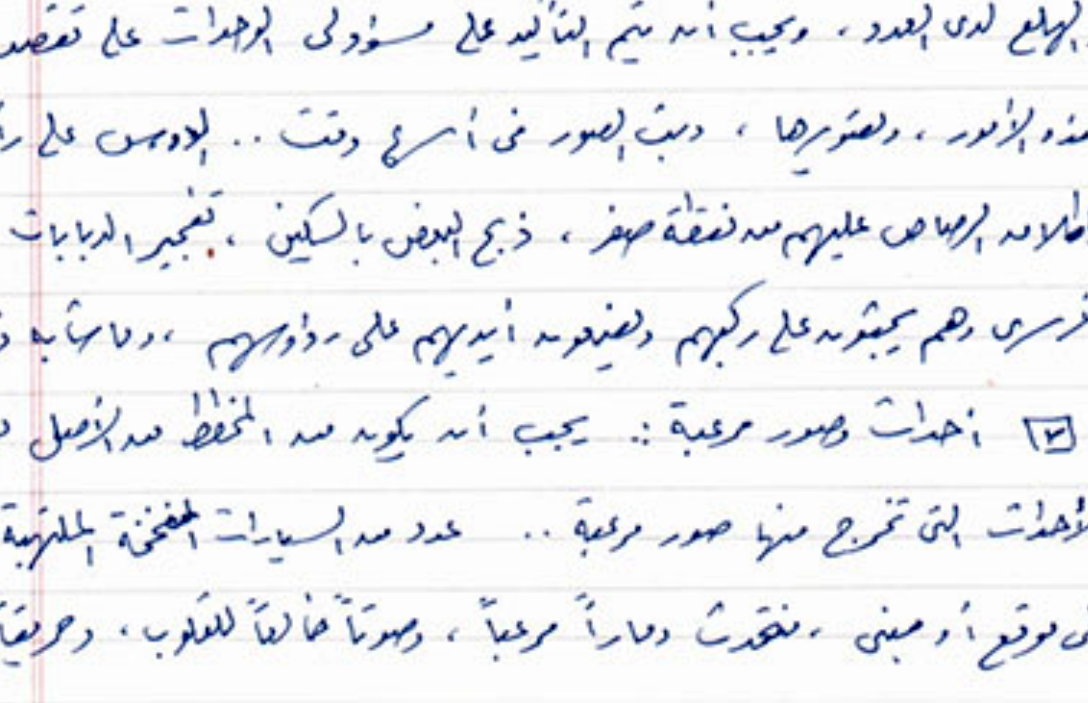Nelle ultime settimane si è fatta strada, soprattutto in Europa, un’idea che a prima vista appare pragmatica ma che a un’analisi più attenta rivela una pericolosa distorsione. Diversi governi hanno scelto o stanno considerando di collegare il rilascio degli ostaggi a un passo politico verso il riconoscimento dello Stato palestinese. L’approccio viene presentato come una mossa diplomatica equilibrata, capace di tenere insieme la pressione su Hamas e la necessità di rilanciare un processo politico. In realtà, questa formula sancisce di fatto che il terrorismo può pagare. Significa accettare che un’organizzazione armata, responsabile di massacri e rapimenti, ottenga un dividendo politico diretto dalle sue azioni. Non è solo un problema di opportunità politica: è un cedimento morale, perché normalizza la violenza come strumento di trattativa, ed è un cedimento giuridico, perché altera le basi stesse del diritto internazionale, che vieta qualsiasi vantaggio derivante da pratiche terroristiche.
Il risultato immediato sarebbe un messaggio devastante a tutti i gruppi che praticano il sequestro e l’attacco contro civili. Il messaggio che colpire funziona, perché aumenta la legittimità politica della propria causa. È la stessa logica che per decenni la comunità internazionale ha cercato di contrastare con linee guida severe sulla non negoziazione con i terroristi. Eppure, nel caso israelo-palestinese, assistiamo a una progressiva erosione di questa regola, spesso giustificata con il richiamo a un presunto “realismo politico”. In realtà, si tratta di un realismo che non tiene conto dei costi di lungo periodo e che rischia di alimentare nuovi cicli di violenza.
Accanto a questa strada, però, esiste una seconda ipotesi purtroppo quasi del tutto assente dal dibattito pubblico: collegare il mancato rilascio degli ostaggi a un riconoscimento della sovranità israeliana su Giudea e Samaria. Questa ipotesi, pur discussa nei circoli più vicini alle posizioni israeliane, non trova spazio nelle agende diplomatiche internazionali. Eppure avrebbe un senso preciso. Invece di premiare Hamas, significherebbe ribadire che la violenza non porta vantaggi, e che chi sceglie di usare i civili come strumento di pressione politica perde terreno sul piano internazionale. In questo modo, non Israele verrebbe messo all’angolo, ma chi pratica il terrorismo.
Ci sono solide basi storiche e giuridiche che legittimano questa prospettiva. La presenza ebraica in Giudea e Samaria ha radici profonde, e lo stesso diritto internazionale ha lasciato negli anni margini interpretativi sullo status di quei territori. Un riconoscimento mirato, legato a un fallimento palese di Hamas nel rispettare le regole minime di umanità, equivarrebbe a trasformare la minaccia in deterrenza. Invece di incentivare nuove azioni di forza, si stabilirebbe che ogni atto di terrore produce un contraccolpo opposto: quello di consolidare la posizione di Israele e ridurre ulteriormente lo spazio politico di chi usa la violenza.
Naturalmente, anche questa seconda opzione non è priva di conseguenze. Un riconoscimento della sovranità israeliana su larga scala in Cisgiordania innescherebbe critiche durissime da parte della maggioranza dei partner internazionali. Alcuni Paesi europei, che già oggi oscillano tra riconoscimento palestinese e pressioni diplomatiche su Gerusalemme, reagirebbero con durezza. Anche attori regionali che hanno normalizzato i rapporti con Israele potrebbero trovarsi in difficoltà, con effetti potenzialmente destabilizzanti. Hamas, dal canto suo, potrebbe tentare di usare tale decisione come argomento propagandistico, rafforzando la narrativa del «Palestina sotto assedio» e cercando di recuperare consensi perduti.
Ma questi rischi, pur reali, non devono oscurare il dato politico centrale. Oggi il dibattito internazionale si muove quasi esclusivamente lungo la prima opzione, quella che lega la sorte degli ostaggi a un riconoscimento palestinese. Si tratta di un rovesciamento logico e morale che finisce per isolare Israele e deresponsabilizzare Hamas. Parlare della seconda ipotesi, al contrario, significherebbe rimettere al centro la regola fondamentale: non sono le vittime a dover pagare, ma i carnefici.
Il silenzio su questa possibilità rivela uno squilibrio preoccupante. Israele viene costantemente posto sotto pressione affinché faccia concessioni, mentre la responsabilità di Hamas scompare sullo sfondo o viene addirittura premiata. In un contesto in cui la violenza è usata come strumento di legittimazione, l’assenza di una discussione seria su un riconoscimento israeliano alternativo segna una grave mancanza di coerenza nella politica internazionale.
In conclusione, tra le due opzioni, la seconda è la più coerente con i principi di deterrenza, diritto e moralità. Non va nascosto che comporti rischi diplomatici e possibili tensioni, ma almeno stabilisce una logica chiara e non contraddittoria: chi pratica il terrorismo non riceve premi, e Israele non viene punito per la brutalità dei suoi nemici. È tempo che anche questa prospettiva entri nel dibattito pubblico e diplomatico, altrimenti la comunità internazionale continuerà a inviare il messaggio sbagliato.
Ostaggi e riconoscimenti: la diplomazia che premia il terrorismo
Ostaggi e riconoscimenti: la diplomazia che premia il terrorismo
Ostaggi e riconoscimenti: la diplomazia che premia il terrorismo