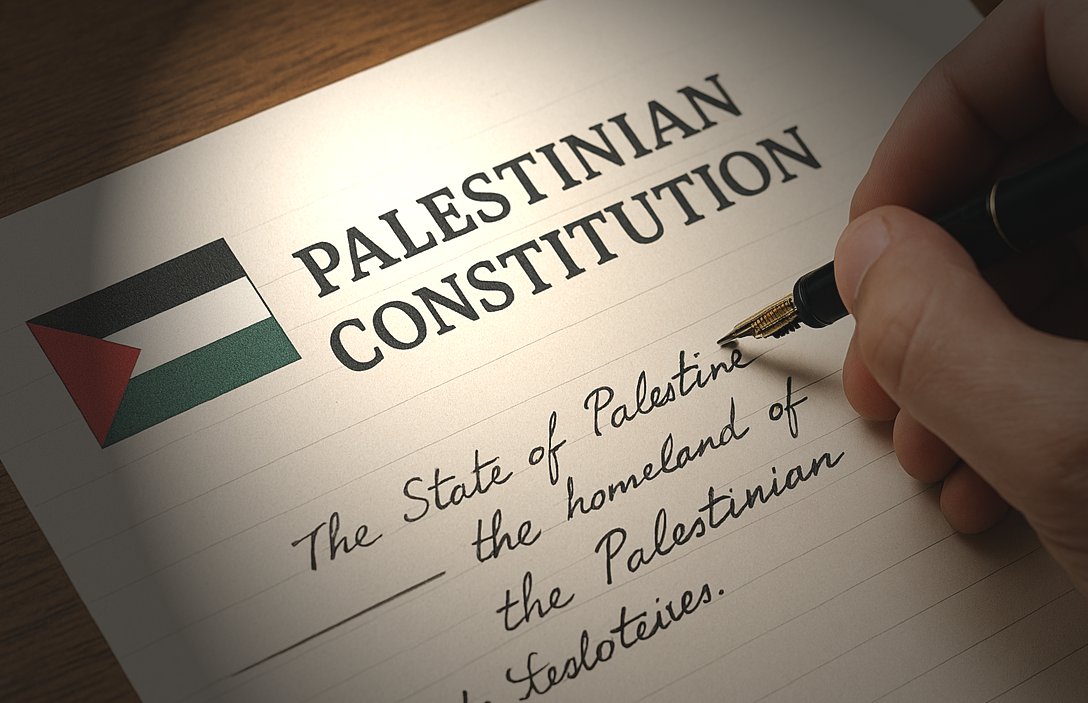Mentre l’eco del 7 ottobre continua a segnare la coscienza israeliana, emergono dettagli che gettano luce su uno dei fronti più delicati della guerra contro Hamas, quello sotterraneo, dove oltre duecentocinquanta ostaggi sono stati trascinati nelle viscere di Gaza e nascosti in un reticolo di cunicoli progettato per rendere quasi impossibile ogni tentativo di localizzazione. Un’inchiesta pubblicata da Mako – il portale di informazione e intrattenimento israelianolegato al gruppo televisivo Keshet Media Group – racconta come l’apparato di sicurezza israeliano sia riuscito, in più di un’occasione, a ottenere informazioni cruciali grazie a capacità tecnologiche e operative che restano in gran parte riservate ma che hanno consentito di osservare ciò che accadeva sotto metri di cemento e sabbia.
Uno degli ostaggi liberati ha riferito che, durante la prigionia, il suo carceriere si era allontanato per pochi istanti; in quel breve intervallo, dal soffitto del tunnel sarebbe scesa una microcamera capace di filmarlo senza che i sequestratori se ne accorgessero. L’apparecchiatura si sarebbe ritratta non appena il terrorista fosse rientrato, lasciando l’ostaggio nell’ignoranza su quanto accaduto. Soltanto dopo il ritorno in Israele, a guerra ancora in corso, l’uomo avrebbe appreso che si trattava di un’operazione dell’IDF. Il dato più rilevante, tuttavia, non è l’episodio in sé, bensì la conferma che simili riprese sarebbero avvenute più volte nel corso dei mesi, offrendo ai vertici militari immagini dirette di prigionieri tenuti in condizioni estreme.
Il contesto operativo in cui queste azioni si sono svolte è quello della cosiddetta “città sotterranea” costruita da Hamas nel tempo, una rete di tunnel che, secondo stime diffuse da fonti militari e centri di ricerca, si estende per centinaia di chilometri e che ha rappresentato un fattore decisivo nella strategia difensiva dell’organizzazione. Penetrare quel sistema senza esporre gli ostaggi a rischi immediati richiedeva un equilibrio delicato tra audacia tecnologica e prudenza tattica, perché ogni errore avrebbe potuto trasformarsi in una condanna per i prigionieri.
Sempre secondo quanto riferito da Mako, l’IDF avrebbe impiegato anche uno strumento speciale e tuttora segreto, per indurre alcuni miliziani a uscire da un tunnel, nel tentativo di creare le condizioni per un recupero degli ostaggi. I vertici della sicurezza seguivano l’operazione in tempo reale dal territorio israeliano, osservando su schermi ciò che accadeva a chilometri di distanza, in un’atmosfera di attesa snervante che si è poi trasformata in delusione quando il piano non ha raggiunto l’obiettivo sperato. L’idea iniziale prevedeva di trasferire gli ostaggi in una località segreta per alcuni giorni, così da ripetere l’azione con modalità simili; dopo il fallimento, tuttavia, quella procedura è stata accantonata e non è stata più riproposta.
Questi dettagli, che emergono a conflitto ancora aperto sul piano politico e diplomatico, mostrano quanto la partita degli ostaggi si sia giocata non soltanto sul terreno ma anche nella sfera dell’intelligence e dell’innovazione tecnologica, in un confronto che ha avuto come teatro uno spazio invisibile e claustrofobico. Se la guerra in superficie è stata raccontata attraverso immagini di macerie e battaglie urbane, quella nei tunnel ha avuto per protagonisti sensori, microcamere e operazioni calibrate al millimetro, in cui ogni decisione implicava una responsabilità enorme.
Resta il fatto che, al di là dei successi parziali e dei tentativi non riusciti, la ricerca di informazioni sugli ostaggi ha rappresentato uno degli assi portanti dell’azione israeliana, dimostrando come la dimensione tecnologica sia ormai inseparabile da quella militare e come, nel conflitto contemporaneo, la capacità di vedere senza essere visti possa fare la differenza tra un’ipotesi e una prova concreta.
Nel buio dei tunnel, l’occhio invisibile