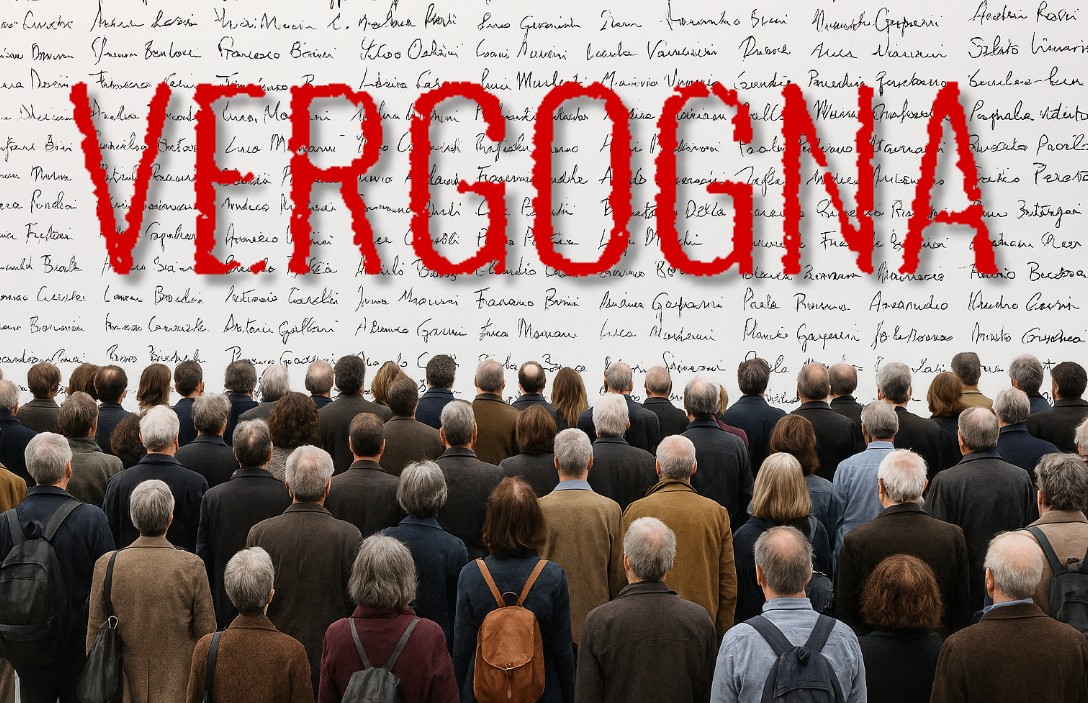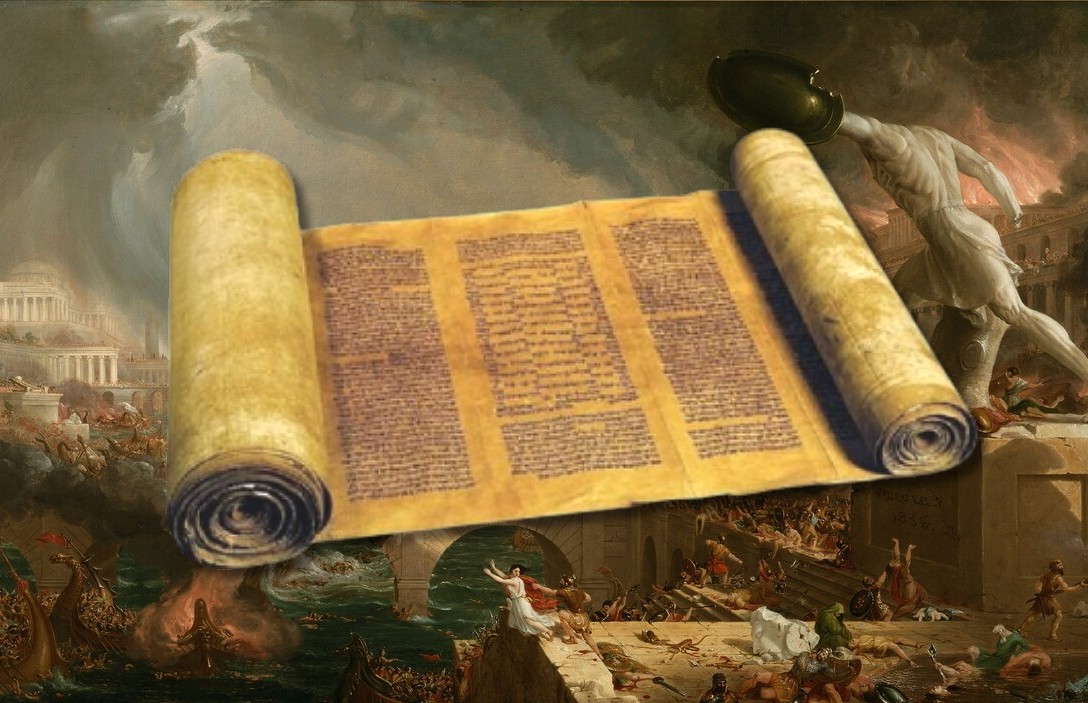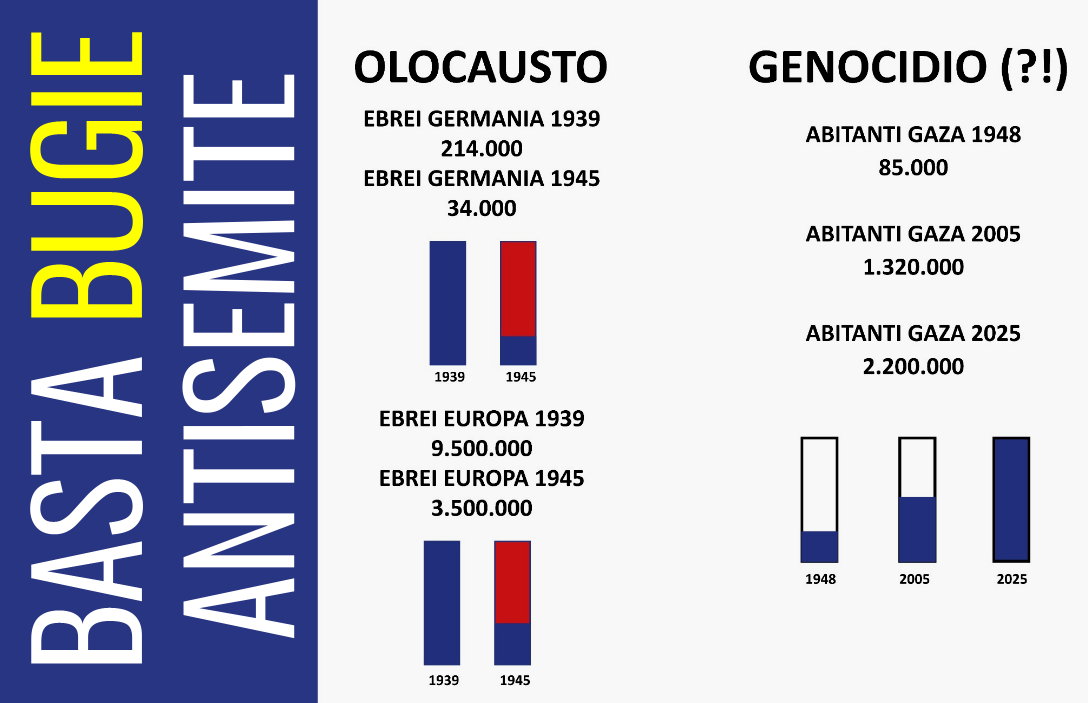Mi è capitato recentemente di ascoltare l’intervento del rabbino americano Ammiel Hirsch, molto preoccupato dopo il suo incontro con il neoletto sindaco di New York Zohran Mamdani. Pare infatti che Mamdani non abbia neppure tentato di dissimulare: in questo gli si deve dar credito di onestà non comune. Hirsch ci racconta come Mamdani abbia sostenuto, con determinazione, la sua idea circa il non diritto all’esistenza d’Israele come stato ebraico: né entro i confini del 1967 e neppure entro quelli del 1948.
Per Mamdani, non c’è posto per la coesistenza, né per due Stati per due popoli. Parole che mi hanno destabilizzata. Persino nel Corano è scritto che gli ebrei verranno tutti riuniti nella terra che Allah ha loro destinato. A questo punto può arrivare l’odio? Al punto che un musulmano possa ignorare persino le parole del Corano? E allora mi è venuto in mente che sì, la politica può persino soffocare il messaggio del profeta dell’islam. Vi faccio un esempio, portando alla vostra attenzione la singolare ironia della storia di Muhammad Asad: uno studioso che è stato tra i più attenti interpreti del messaggio coranico, ma era nato ebreo. Leopold Weiss, nato in una famiglia ebraico-asburgica di Leopoli, nipote di un rabbino, uomo colto e cosmopolita. Quando nel 1926 si convertì all’islam e assunse il nome di Muhammad Asad, non rinnegò la propria origine, ma la portò con sé, dentro un’altra forma di luce. Fintantoché non lasciò che quella luce si spegnesse nella politica.
Quando cominciò la sua avventura spirituale, l’Europa non era ancora quella della Shoah, ma era già attraversata da un’inquietudine che per molti ebrei suonava come un presagio. Weiss partì come reporter, curioso più delle culture che delle religioni, ma si trovò davanti una fede che non separava il divino dal mondo. Nelle sue memorie, The Road to Mecca, racconta il momento in cui comprese che l’islam rappresentava «un ritorno alla semplicità originaria del monoteismo». Non un’abiura, dunque, ma un ritorno alle sorgenti.
Da quel momento la sua vita prese una direzione irreversibile: lasciò l’Europa, visse nella penisola arabica, divenne amico e consigliere del futuro re Ibn Saʿūd, si immerse nello studio del Corano e delle scienze islamiche. Ma se la conversione e la distanza geografica lo salvarono, nulla poté fare per salvare la sua famiglia. Il padre, Akiva Weiss, e la sorella Rachel furono deportati e uccisi nei campi di sterminio nel 1942. Asad, internato dagli inglesi in India come «suddito nemico», tentò invano di liberarli. Colpisce tuttavia il suo silenzio. Non un commento, dopo, né su Hitler né sul Gran Muftì di Gerusalemme, che con Hitler si era alleato. Forse perché, una volta varcato il confine dell’islam, Asad non trovò più una lingua comune con l’Europa. Forse perché la politica era diventata più rumorosa della fede.
Eppure la sua opera successiva, The Message of the Qur’an, è una delle letture più raffinate e teologicamente generose del rapporto tra islam ed ebraismo. In quelle pagine Asad si sofferma sui versetti che riconoscono la missione storica del popolo ebraico e la terra che gli fu promessa. Nella sura al-Mā’idah (5:20–21), Mosè dice: «O popolo mio! Entrate nella terra santa che Allah vi ha destinato». L’espressione araba al-arḍ al-muqaddasa – «terra santa» – è identificata con la Terra d’Israele. La formula «che Allah vi ha destinato» indica, nel linguaggio coranico, un diritto divino.
Da questo punto di vista, il Corano riconosce ai Figli d’Israele un destino: un legame spirituale con una terra che non è arbitrio, ma dono. Altri versetti rafforzano questa lettura. Ad esempio, nella sura al-Aʿrāf (7:137) è scritto: «E facemmo ereditare al popolo che era stato oppresso le terre orientali e occidentali che avevamo benedetto». E nella sura al-Isrā’ (17:104): «Dicemmo ai Figli d’Israele: abitate la terra; e quando verrà la promessa dell’ultima volta, vi riuniremo insieme». Su quest’ultimo passo Asad si ferma a lungo. Egli interpreta il «ritorno» non solo come memoria profetica, ma come evento che si compie nella storia per volontà divina. In questo senso, e quasi suo malgrado, riconosce un sionismo teologico, un sionismo coranico: paradossale, ma coerente. L’islam, nella sua lettura, non nega la promessa fatta agli ebrei, la conferma.
Tuttavia, quando nel 1948 nacque lo Stato di Israele, Asad si trovò dalla parte opposta. Era ormai cittadino del nuovo Pakistan, di cui sarebbe stato ambasciatore alle Nazioni Unite. In quegli anni il mondo musulmano era compatto nella sua ostilità a Israele e Asad si adeguò. La teologia lasciò il posto alla politica. La parola del Corano cedette alla ragion di Stato. Asad aveva trovato nel Corano la legittimazione spirituale della Terra d’Israele, ma non poteva accettare Israele come realtà politica.
Quella stessa tensione oggi riemerge sotto forme diverse, persino in luoghi insospettabili. Forse è per questo che mi è tornato in mente Asad. La recente elezione di Zohran Mamdani mi ha fatto riflettere. Mamdani dice di non negare l’esistenza di Israele, ma di rifiutarne la definizione etnica di «Stato ebraico». Le sue parole hanno diviso la comunità ebraica americana: molti, come il rabbino riformato Hirsch, sono rimasti inorriditi, altri, come gli ultra-ultraortodossi Satmar, che da sempre negano la legittimità di Israele prima della venuta del Messia, sono rimasti affascinati. In Mamdani, i Satmar hanno riconosciuto, paradossalmente, una coerenza teologica: il rifiuto di confondere la promessa con la sovranità. È la stessa frattura che Asad aveva vissuto mezzo secolo prima. Ebreo convertito all’islam, riconosceva nel Corano il legame sacro fra gli ebrei e la Terra d’Israele, ma non poté riconoscerlo nella forma di uno Stato. Assurdo.
Resta pertanto la solita, necessaria, domanda: perché solo Israele deve giustificare la propria esistenza come Stato ebraico? Nel mondo esistono tredici Stati che si definiscono islamici e circa cinquanta che adottano l’islam come religione ufficiale o come fonte legislativa. Nessuno mette in discussione il loro «diritto di esistere». Israele resta l’unico Stato al mondo cui si chiede continuamente di giustificare non solo le proprie azioni, ma la propria stessa esistenza.
Forse, se Muhammad Asad avesse conosciuto – o non avesse dimenticato – la storia di Giuda Maccabeo, avrebbe intuito che la fede, per sopravvivere, non può restare contemplazione. Giuda non attese segni dal cielo né rinviò la riconsacrazione del Tempio in nome della mancanza d’olio: scelse di combattere. E in quella decisione – più che nel miracolo che la seguì – si compì la promessa. È questo, in fondo, il significato di Ḥanukkà: la luce che si riaccende non per grazia, ma perché qualcuno ha avuto il coraggio di riaccenderla, anche se non vi era olio a sufficienza. Quest’anno la festa comincia tra poche settimane. E quella luce, come sempre, tornerà a farsi essa stessa domanda: chi avrà il coraggio di riaccenderla, ancora?
Muhammad Asad: l’ebreo che trovò il sionismo nel Corano (e lo lasciò morire nella politica)
Muhammad Asad: l’ebreo che trovò il sionismo nel Corano (e lo lasciò morire nella politica)