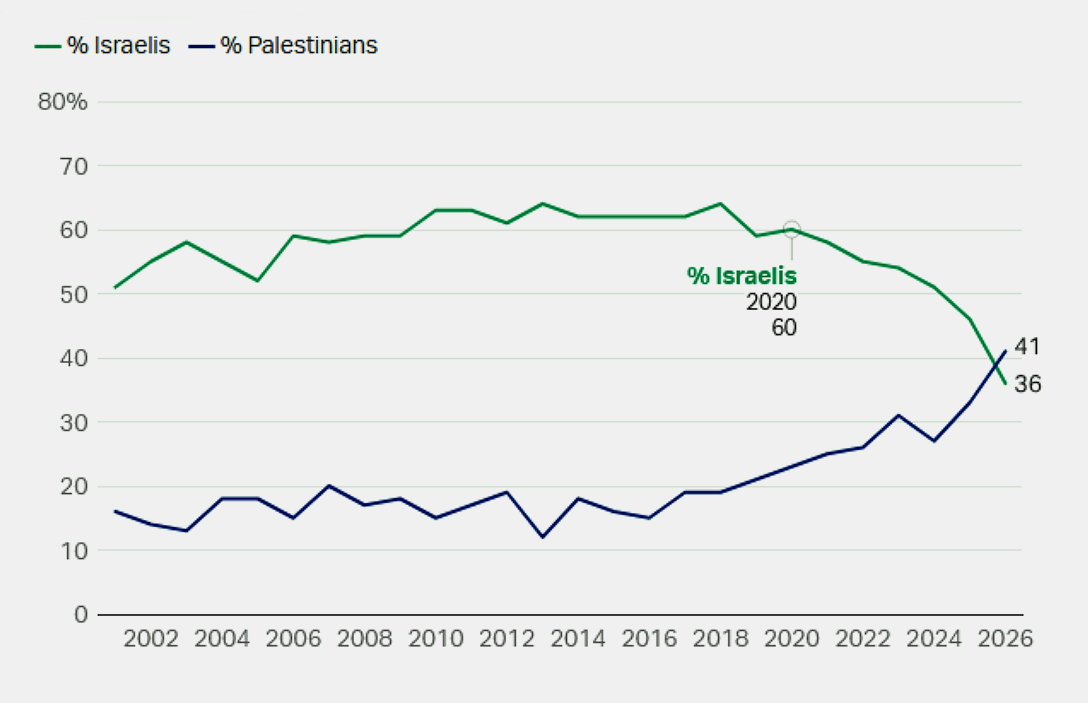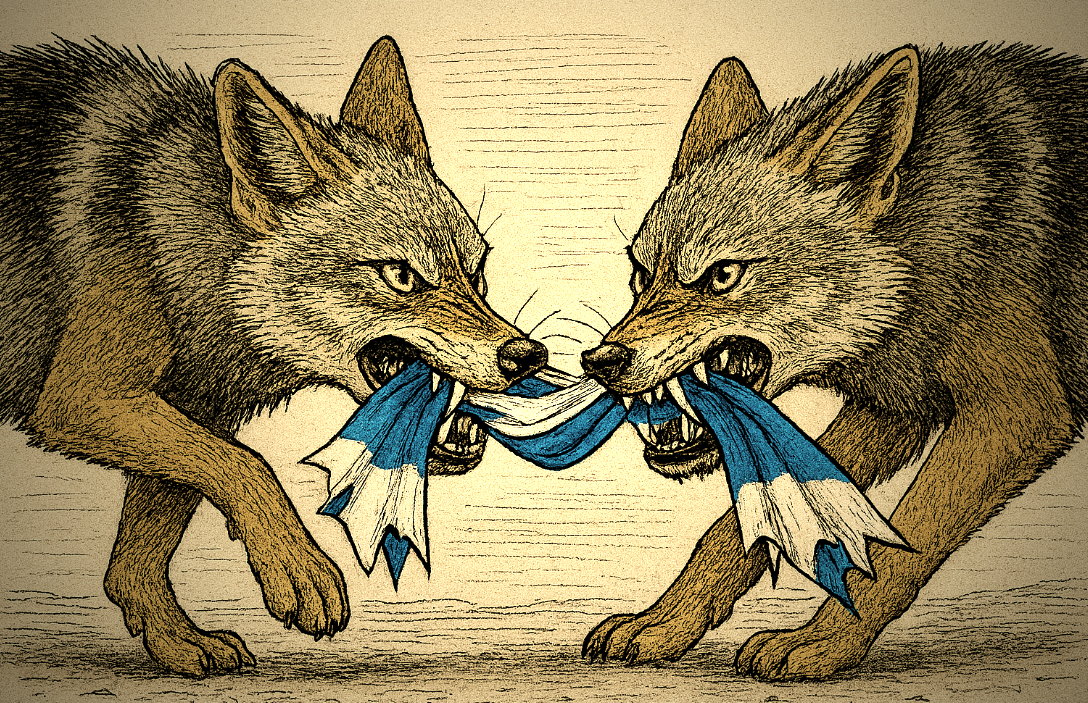A Londra è partita una campagna con un titolo studiato per fare attrito: “Demanding Freedom for Palestinian Hostages”. Il meccanismo è semplice, quasi da manuale dei social: un nastro rosso da mettere sulla foto profilo, video e messaggi coordinati, poi il passaggio alla strada con manifestazioni fissate per fine mese. Il problema non è l’estetica, che ormai è politica quanto un comizio, ma l’operazione linguistica piuttosto infame. Chiamare “ostaggi” persone detenute o condannate per reati legati al terrorismo, e farlo usando un simbolo che richiama volutamente quello diventato internazionale per i rapiti israeliani del 7 ottobre è una forzatura immorale costruita apposta per creare equivalenze inaccettabili.
A promuovere l’iniziativa sono il Palestinian Forum in Britain e la Global Sumud Flotilla, il che non è certo un dettaglio. La scelta di far coincidere l’avvio della campagna con un periodo in cui le autorità britanniche stanno esaminando la posizione di Zaher Birawi, figura di vertice del Forum e nome ricorrente nell’ecosistema delle flotte “anti-blocco”, aggiunge un livello di tensione politica che va oltre la propaganda. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica e ripreso da testate israeliane, l’Office of Financial Sanctions Implementation del Tesoro britannico ha confermato a dicembre 2025 di stare valutando un’eventuale designazione nell’ambito delle norme antiterrorismo sulle sanzioni, quelle che consentono congelamento dei beni e divieti di ricevere fondi o risorse economiche.
Birawi non è un personaggio marginale che si accende e si spegne con l’algoritmo. In Parlamento, nell’ottobre 2023, il deputato laburista Christian Wakeford lo ha indicato per nome, usando la protezione della “parliamentary privilege”, come “operativo di Hamas” presente nel Regno Unito, sostenendo che la permanenza di figure del genere costituisce un rischio per la sicurezza nazionale. La fonte primaria di quella dichiarazione è nei resoconti ufficiali della Camera dei Comuni, quindi non è una voce ma un atto politico messo a verbale.
In questo contesto, l’idea di una campagna sugli “ostaggi palestinesi” sembra meno un gesto di solidarietà e più una mossa di schermatura che vuole spostare il fuoco dalla questione delle reti e delle responsabilità verso un terreno emotivo, dove la parola “ostaggio” diventa una clava. Se tutto è “ostaggio”, allora niente lo è davvero, e la differenza tra civili strappati alle loro case e detenuti arrestati per attività violente viene diluita fino a sparire. Non siamo quindi di fronte a un errore terminologico quanto a una scelta precisa. E la scelta del nastro rosso, che richiama per contrasto la simbologia usata per i rapiti israeliani, è parte della stessa architettura che ha come metodo l’appropriazione di un segno, il suo svuotamento per riempirlo con un’altra storia, pretendendo che il pubblico non noti la sostituzione.
Il Regno Unito si trova così davanti alla sua vecchia tentazione: tollerare per anni zone grigie che si presentano come attivismo politico, e accorgersi tardi che alcune di quelle zone grigie sono infrastrutture. Il tema delle sanzioni, infatti, non è un gesto simbolico ma un dispositivo concreto: colpisce conti, donazioni, flussi economici, e quindi incide sulla capacità operativa di un network, non solo sulla sua reputazione. Le norme britanniche che regolano le sanzioni antiterrorismo sono nate proprio per questo: impedire che denaro, beni e servizi alimentino attività terroristiche anche quando passano attraverso canali formalmente “civili”.
C’è anche un altro livello, più ampio e meno londinese. Negli ultimi anni, Stati Uniti ed Europa hanno aumentato l’attenzione sui circuiti di raccolta fondi e sulle “coperture” umanitarie sfruttate da gruppi armati e da reti collaterali. Lo si vede nelle tranche di sanzioni statunitensi e nel linguaggio, sempre più esplicito, sul rischio di usare la beneficenza come corridoio per la finanza politica e militare. In parallelo, cresce la pressione sugli Stati europei perché non si limitino a proscrivere le sigle, ma seguano i soldi, i ruoli, i passaggi di consegne tra associazioni, comitati e iniziative apparentemente innocue.
La campagna del nastro rosso, letta così, non è un episodio di squallido folclore né una provocazione isolata. È invece un tassello della battaglia per ridefinire il linguaggio trasformando i “detenuti” in “ostaggi”, facendo scivolare “terrorismo” in “resistenza”, e sostituendo il diritto con una morale d’importazione che pretende equivalenze automatiche. E mentre l’opinione pubblica discute del colore di un nastro, le istituzioni sono costrette a decidere se dietro quel nastro ci sia solo rumore, oppure una rete sulla quale valga la pena di intervenire in modo deciso.
Londra, il nastro rosso e la guerra delle parole
Londra, il nastro rosso e la guerra delle parole