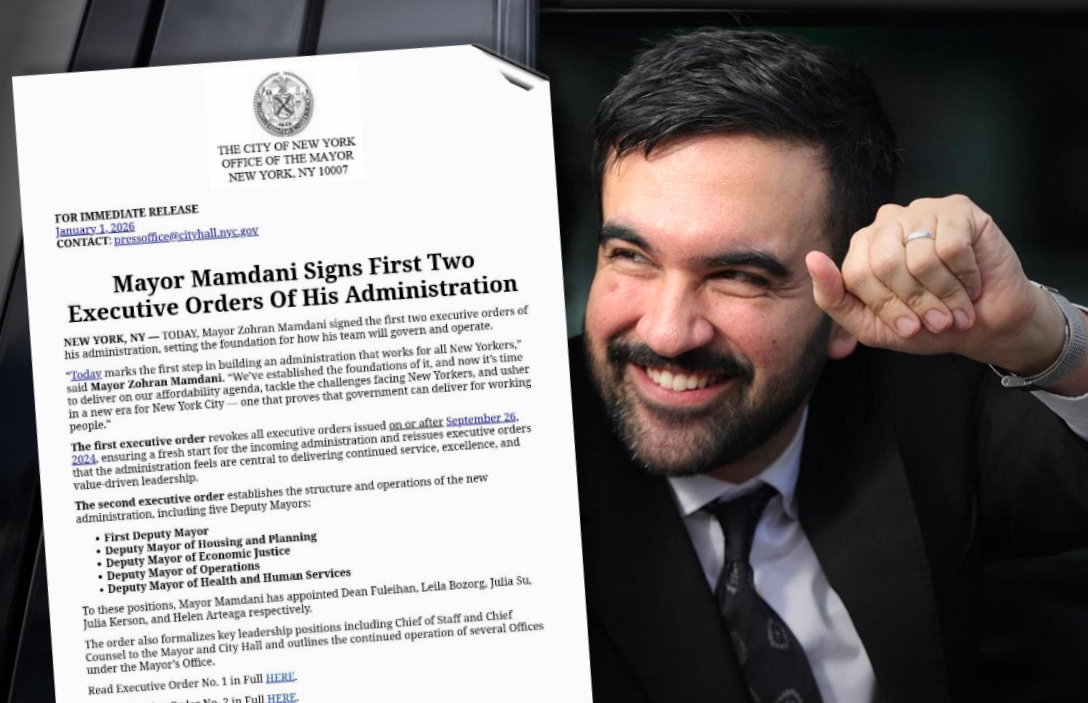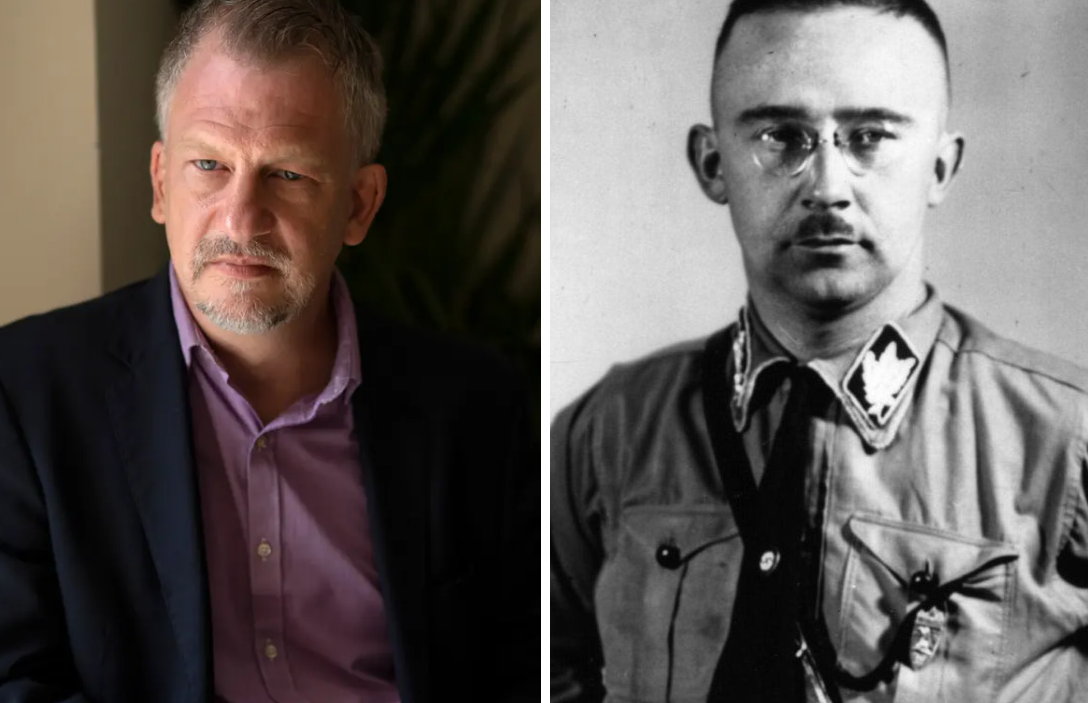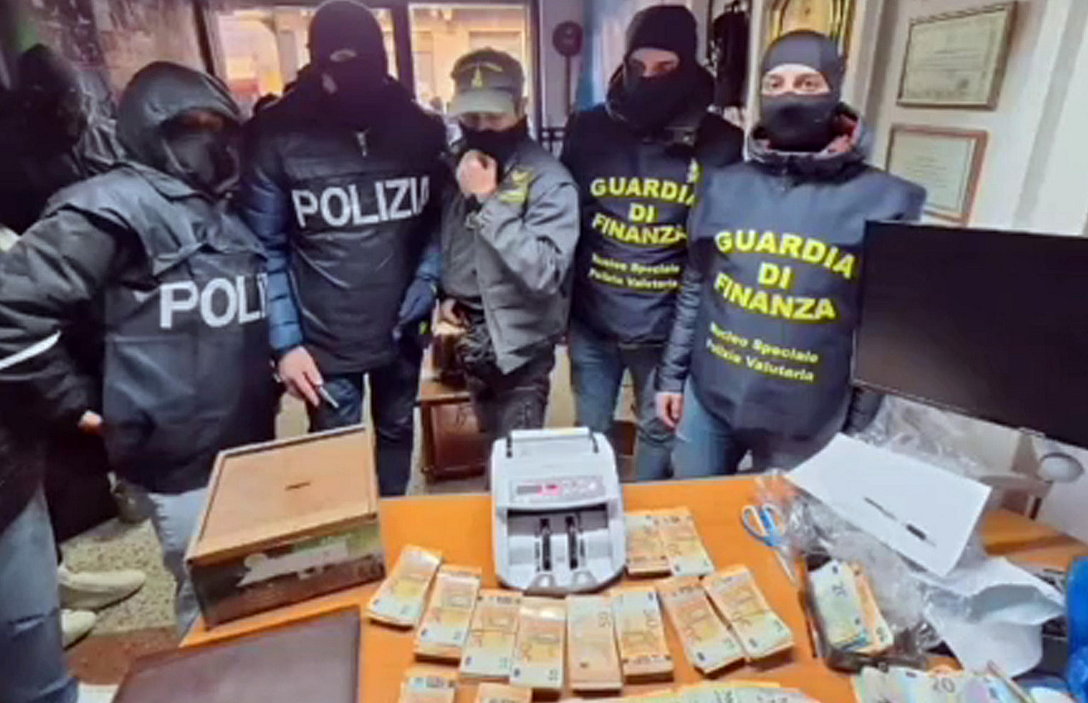Alla fine, anche a Dublino il moralismo un tanto al chilo si è scontrato con l’economia. Il governo irlandese, dopo mesi di proclami e gesti plateali contro Israele, ha deciso di annacquare la legge che avrebbe dovuto limitare i rapporti commerciali con gli “insediamenti” israeliani in Giudea e Samaria. L’idea iniziale era di colpire le merci e i servizi provenienti da quei territori, ma il disegno di legge è stato rapidamente ridotto a un’operazione simbolica: solo beni agricoli di scarso valore, circa duecentomila euro l’anno. In pratica, un manifesto politico travestito da provvedimento economico.
La pressione degli imprenditori ha fatto il resto. In Irlanda hanno sede alcune delle più grandi multinazionali del mondo, soprattutto americane. Le stesse che hanno ricordato al governo che la moralità a senso unico può costare cara. Washington non avrebbe gradito misure punitive contro Israele e gli investitori non intendono farsi trascinare in crociate ideologiche. Così l’esecutivo ha dovuto scegliere: continuare la rappresentazione o salvaguardare l’economia. Ha scelto, come quasi sempre, la seconda.
La retromarcia è stata affidata al ministro degli Esteri Simon Harris, che ha parlato di un «provvedimento limitato» e di una futura iniziativa europea più ampia. Formula elegante per dire che tutto è stato rinviato a data da destinarsi. La legge verrà comunque presentata in Parlamento entro dicembre, ma servirà solo a salvare la faccia di chi aveva già sventolato la bandiera della «giustizia internazionale». Un gesto che fa più rumore nei comunicati che nei bilanci.
È un copione noto. L’Irlanda, che da anni si vanta di essere la coscienza morale dell’Europa, scopre improvvisamente di non potersi permettere il lusso di una coerenza integrale. Troppo forte la dipendenza dalle multinazionali americane, troppo rischioso l’isolamento economico. Gli stessi attivisti che ieri invocavano il boicottaggio oggi sussurrano «forse non è il momento». E i politici, che avevano già brindato alla «punizione d’Israele», si ritrovano a spiegare che «il dialogo è la via migliore».
Israele, intanto, osserva senza sorpresa. Lo scorso dicembre aveva già chiuso la sua ambasciata a Dublino, ufficialmente per «ridimensionamento delle attività», in realtà come segnale politico chiaro: non si tratta con chi confonde la diplomazia con l’attivismo. L’ambasciatrice Dana Ehrlich lo ha detto con franchezza: la presenza israeliana in Irlanda serviva più al governo irlandese, che amava esibirla come trofeo democratico, che alle relazioni bilaterali.
Dietro la vicenda resta una verità poco elegante ma innegabile: quando i proclami anti-israeliani arrivano al punto di minacciare il portafoglio, il fervore “morale” evapora in un attimo. È una lezione utile anche per altri governi europei, inclini a trasformare ogni decisione su Israele in una prova di purezza ideologica. La politica estera, però, non è un concorso di virtù: è un campo minato dove la retorica può costare miliardi.
L’Irlanda ha imparato la lezione nel modo più semplice: i principi sono belli, ma gli investimenti pesano di più. E in tempi di crisi, anche la coscienza (soprattutto se sporca) — quando è a rischio il PIL — può concedersi qualche sconto.
*L’Irlanda frena sull’odio: quando il business vale più dell’ideologia*
*L’Irlanda frena sull’odio: quando il business vale più dell’ideologia*