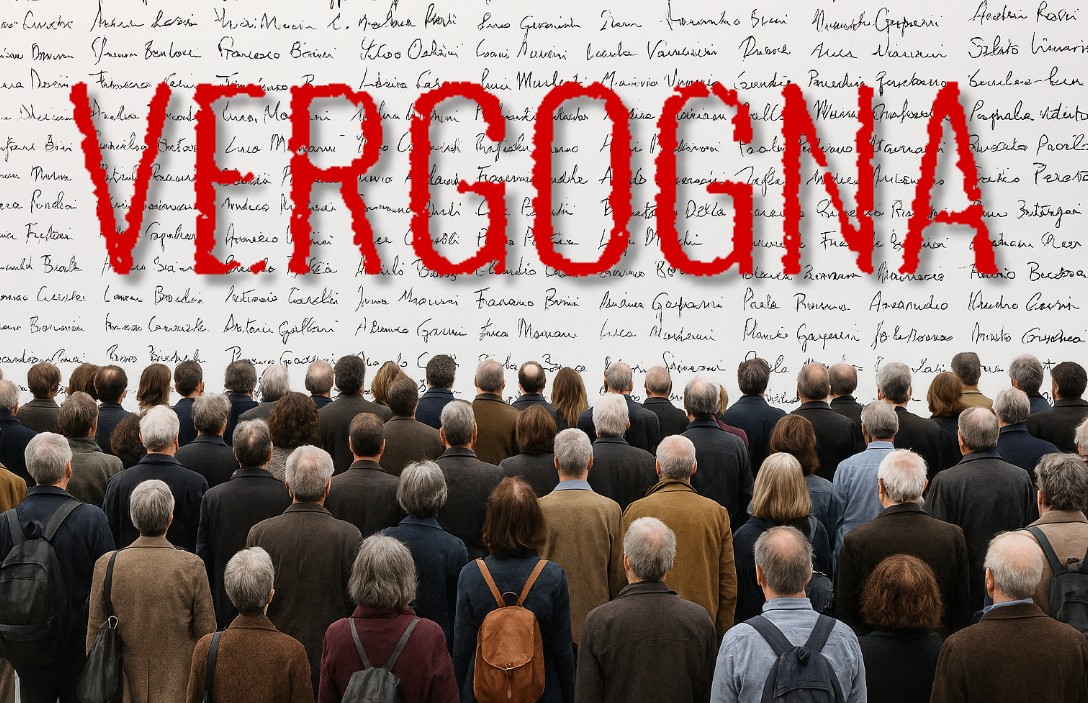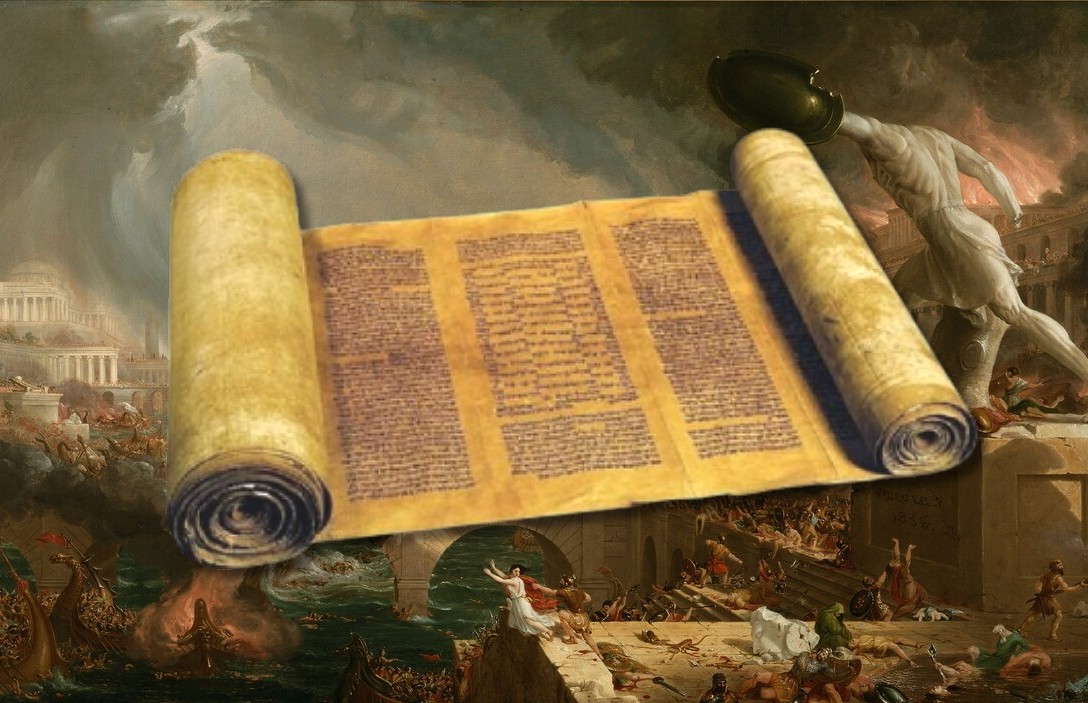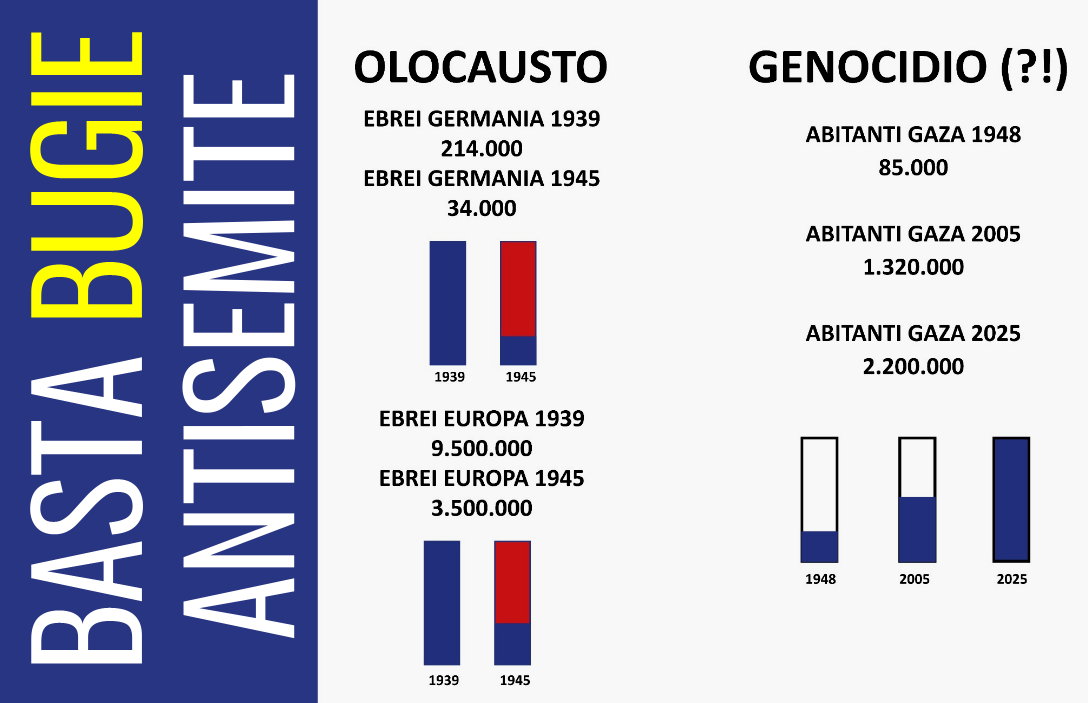Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento sottile ma profondo nel modo in cui si manifesta l’antisemitismo negli spazi accademici: non più solo episodi clamorosi, volantini offensivi, vandalismi, ma una pressione costante, nutrita di sfumature, ambiguità e silenzi. È quella che Yael Silverstein e C. J. Block, in un articolo pubblicato recentemente sul Journal of Jewish Education, definiscono «antisemitismo contemporaneo» e che la loro analisi intende rendere visibile, costruendo una tassonomia delle esperienze antisemite che si dispiegano tra microaggressioni e manifestazioni più esplicite.
Il contributo degli autori si fonda sul quadro teorico delle microaggressioni, uno strumento concettuale che consente di indagare come certe forme lievi, quotidiane e diffuse di discriminazione — commenti ambigui, battute sugli stereotipi, allusioni contestuali, omissioni — possano configurarsi come esperienze antisemitiche reali, anche se non sempre riconosciute come tali da chi le subisce o da chi le osserva. La forza di questa prospettiva è che sposta l’attenzione dall’evento straordinario all’esperienza ordinaria: non conta solo l’attacco violento, ma anche quel piccolo gesto che, ripetuto, logora un’identità, isola una persona, trasmette un senso di non appartenenza.
Silverstein e Block elaborano una tassonomia che distingue vari livelli e modalità di antisemitismo contemporaneo nelle università: dalle forme sottili e pervasive, difficili da identificare, fino a manifestazioni più evidenti. La loro ricerca mostra che, tra gli studenti degli atenei nordamericani, gli episodi sottili prevalgono numericamente su quelli espliciti, ma entrambi — quelli “aperti” e quelli “invisibili” — producono effetti negativi sul benessere psicologico, sul senso di appartenenza e sull’impegno accademico. In altre parole, non sono gesti innocui né “deroghe tollerabili”: generano danno reale. Quasi la totalità degli studenti ebrei intervistati dichiara di aver subito almeno un episodio di questo tipo.
Questo sforzo di visibilità è rilevante non solo per chi studia l’antisemitismo, ma per chiunque voglia comprendere come oggi si costruiscano le soglie della discriminazione. L’articolo mette in guardia contro la tentazione di minimizzare o ignorare, sotto la scusa della delicatezza o della “buona intenzione”, pratiche che non esplodono in violenza ma che alimentano un clima sistemico di esclusione e marginalizzazione. Non tutte le aggressioni si manifestano con cartelli o scritte: talvolta si insinuano nei silenzi, negli sguardi, nei contesti in cui una battuta può passare per ironia, eppure lasciare un segno.
Un’opinione pubblica che accetta l’idea secondo cui “non è nulla di grave” rischia di legittimare comportamenti discriminatori mascherati. Allo stesso modo, le istituzioni accademiche che non riconoscono queste forme come parte integrante del fenomeno antisemita restano cieche a un danno collettivo: indeboliscono la fiducia di chi già si interroga sulla propria appartenenza e falliscono nel promuovere ambienti pluralisti e rispettosi.
Ciò non significa che qualsiasi critica al mondo ebraico o commento ambiguo debba essere automaticamente bollato come antisemitismo. Silverstein e Block invitano a un esercizio di discernimento: distinguere tra critica legittima, controversia politica e attacchi che replicano stereotipi, generalizzazioni o forme di isolamento sistemico. Serve uno sguardo sensibile, capace di contestualizzare senza eludere.
La rilevanza di questo contributo travalica il contesto accademico: ci ricorda che ogni comunità soggetta a discriminazione vive su un continuum che va dalla microaggressione alla violenza aperta. Negli spazi pubblici, nei media, nelle istituzioni, in ogni ambito della convivenza civile, l’attenzione ai segnali deboli non è secondaria: è parte della difesa di una comunità, ma anche della salute democratica condivisa.
In conclusione, ciò che Silverstein e Block ci consegnano è un invito alla vigilanza: l’antisemitismo contemporaneo non è scomparso, si è trasformato in forme più sottili. Riconoscerlo non significa criminalizzare ogni parola, ma assumersi la responsabilità di non sottovalutare gesti che alimentano un clima di esclusione. Un’opinione pubblica matura, un ateneo sensibile, una società viva devono saper vedere l’invisibile — e reagire non solo alla violenza esplosiva, ma anche a quella che si consuma goccia dopo goccia.
L’antisemitismo che non si vede, ma logora
L’antisemitismo che non si vede, ma logora