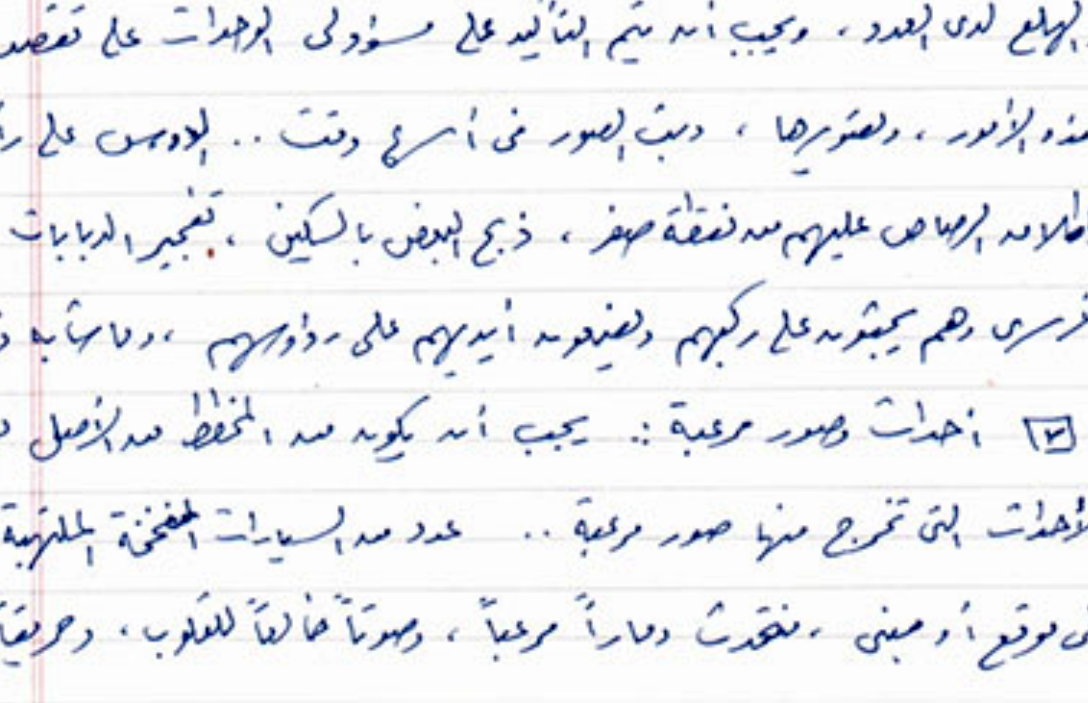C’è un tipo particolare di disinformazione che non ha bisogno di bugie, ma si nutre di silenzi. È la disinformazione per omissione, quella che plasma la realtà non tanto con ciò che racconta, ma con ciò che decide di ignorare.
Il bombardamento accidentale della chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza ha prodotto una reazione immediata da parte delle autorità italiane. Dichiarazioni ufficiali, tweet indignati da parte delle più alte cariche dello Stato, post ministeriali che definiscono l’accaduto come «un’aggressione inaccettabile». Eppure, da giorni, le chiese maronite siriane sono sotto attacco nel nord del Paese, bersagliate da milizie jihadiste legate al governo di Al Jolani, e in Libano diversi gruppi armati legati a Hezbollah minacciano apertamente le comunità cristiane nelle aree di confine. Per non parlare degli stessi territori amministrati da Hamas e dall’Autorità palestinese, dove la repressione delle comunità cristiane è un dato di fatto da molti anni. Su questi episodi – molti – il silenzio istituzionale è davvero assordante.
Tanto assordante da far pensare che non si tratti di una casualità o di semplice distrazione. Il sospetto è che esista davvero una precisa gerarchia delle vittime e delle responsabilità. Quando l’aggressore è percepito – o dipinto – come un nemico «accettabile», come nel caso di Israele, la macchina comunicativa si attiva immediatamente. Quando invece a colpire sono attori non-statali o statali ambigui, magari utili sul piano diplomatico, commerciale o ideologico, cala una coltre di opacità.
L’informazione selettiva che caratterizza spesso la comunicazione istituzionale del nostro Paese contribuisce a costruire così una narrazione asimmetrica. Una narrazione che ci racconta di morti che contano e altri che possono essere bellamente ignorati. C’è chi viene difeso, spesso a prescindere, e chi resta solo, anche di fronte alla persecuzione più evidente.
Questa dinamica comunicativa si traduce in una profonda distorsione della realtà. Non solo impedisce all’opinione pubblica di comprendere la complessità del conflitto mediorientale, ma tradisce un principio fondamentale della politica estera di ogni Paese che voglia dirsi una potenza (anche media): la coerenza nella difesa dei diritti umani. Se condannare l’uccisione di civili è giusto, deve esserlo sempre, non solo quando conviene. Se tutelare le minoranze religiose è una priorità, non può esserlo a giorni alterni.
Il doppio standard mina la credibilità delle istituzioni, delegittima la voce dell’Italia sul piano internazionale e offre terreno fertile alla propaganda di chi, dall’una o dall’altra parte, si nutre proprio di ipocrisie.
È del tutto prevedibile che da certi ambienti si invochi oggi una difesa a oltranza della narrazione unilaterale filopalestinese, fino ad auspicare che il governo prenda le parti di chi, nei fatti, sta manipolando la realtà per scopi politici. Ma è qui che si gioca la posta più alta: la tenuta morale della nostra diplomazia. La verità non si costruisce per convenienza, e i diritti umani non sono mai un’arma selettiva. Se davvero vogliamo essere credibili, dobbiamo avere il coraggio di dire tutto, anche ciò che non fa comodo. Altrimenti, prima o poi, saremo noi a non essere più ascoltati.
Questo atteggiamento, oltre a incrinare la nostra credibilità morale, comporta un danno concreto sul piano dell’interesse nazionale. Per un Paese come l’Italia, che non può contare sulla proiezione militare di una grande potenza né sul peso economico di attori globali come Stati Uniti o Cina, la leva del soft power è uno degli strumenti principali per esercitare influenza nel Mediterraneo allargato.
La nostra storia, la nostra cultura e la vicinanza – in questo caso specifico – al mondo cristiano d’Oriente ci conferiscono una credibilità unica, se ben gestita. La diplomazia religiosa, il sostegno alle minoranze perseguitate, la coerenza nei diritti umani sono ambiti in cui possiamo davvero fare la differenza, costruendo reti, guadagnando fiducia e consolidando relazioni.
Ma se rinunciamo a questa coerenza, se selezioniamo le vittime da difendere sulla base del contesto politico del giorno, anche quel poco margine di influenza che abbiamo rischia di evaporare. Il soft power funziona solo se è percepito come autentico. Diversamente, si trasforma in retorica vuota, facilmente smascherabile da alleati e avversari.
In un contesto mediorientale sempre più frammentato, dove le alleanze si fanno e si disfano con rapidità, mantenere una postura comunicativa sbilanciata ci rende interlocutori meno affidabili. I partner regionali che combattono sul campo contro le milizie jihadiste – inclusi quegli attori che, pur con tutte le ambiguità, condividono con noi l’obiettivo di stabilizzare l’area e proteggere le minoranze – vedono nel nostro silenzio una forma di complicità o, peggio, di disinteresse.
La realpolitik non è solo cinismo: è anche capacità di leggere la realtà, di pesare ogni parola in funzione dell’equilibrio strategico. In Medio Oriente, difendere chi difende le minoranze etniche o etnico-religiose – tutte le minoranze – non è solo un atto di giustizia. È anche e soprattutto un investimento razionale nella nostra sicurezza e nella nostra influenza in questo teatro. Ignorarlo significa perdere terreno, perdere alleati e, in ultima analisi, perdere rilevanza.
La verità a intermittenza. Quando i diritti umani valgono solo per alcuni La verità a intermittenza. Quando i diritti umani valgono solo per alcuni La verità a intermittenza. Quando i diritti umani valgono solo per alcuni/span>