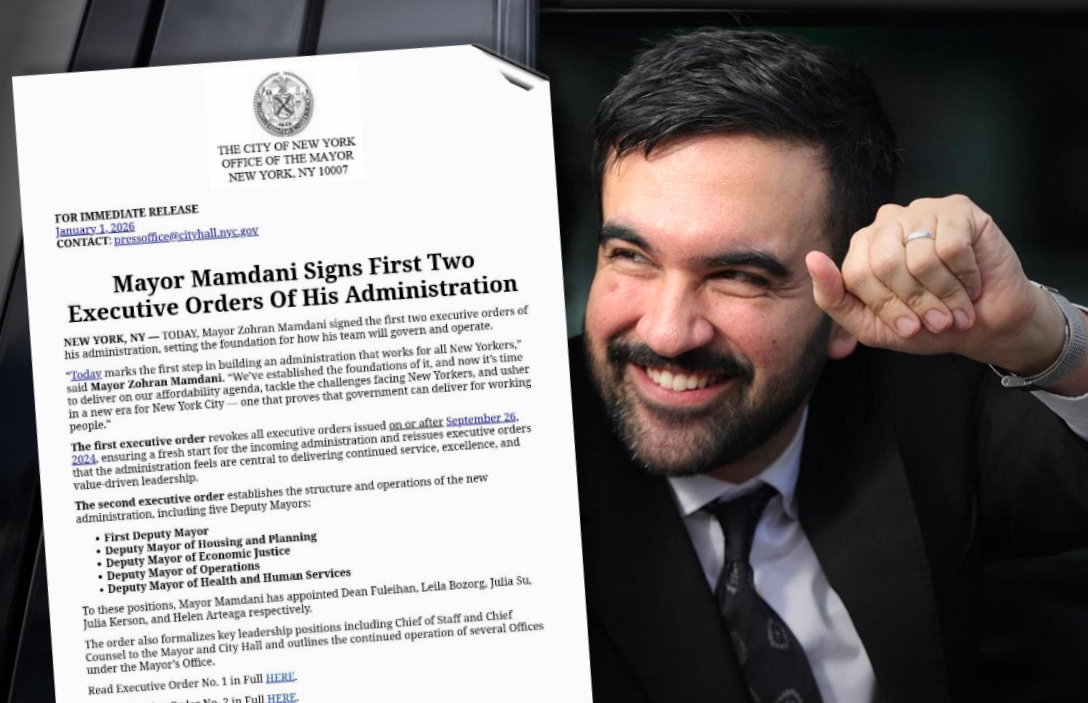L’Università di Pavia ha deciso di prendere posizione. Ma non nel modo in cui un ateneo dovrebbe farlo: cercando equilibrio, complessità, onestà intellettuale. No: ha scelto la strada più facile, quella della condanna unilaterale coperta da un’esile foglia di fico.
Nel documento approvato dal Senato accademico, l’ateneo pavese «condanna con fermezza le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale da parte del governo e dell’esercito di Israele» e poi, come se si trattasse di un pedaggio obbligatorio, aggiunge una frase di rito: «Condanna anche il massacro del 7 ottobre e ogni forma di antisemitismo.» Due righe di equilibrio apparente che servono solo a rendere più digeribile una posizione costruita interamente dentro un pregiudizio.
Perché di questo si tratta: di un pregiudizio potente, profondo, condiviso. Israele non è giudicato per i fatti ma per la sua esistenza. È colpevole a prescindere, e la retorica dei «diritti umani» diventa la formula attraverso cui un ateneo europeo, nel 2025, può permettersi di sottoscrivere un atto politico sotto travestimento morale.
L’Università di Pavia non ha proclamato un boicottaggio, almeno non formalmente. Ha semplicemente deciso di «rivedere» le collaborazioni con università o enti che «rischiano di integrare violazioni dei diritti umani». Una frase elastica, costruita apposta per valere tutto e il contrario di tutto. In pratica, serve a un solo scopo: tagliare i rapporti con istituzioni israeliane e isolare docenti colpevoli di essere israeliani o, peggio, riservisti dell’esercito. Il caso del professore del Dipartimento di Scienze del Farmaco lo dimostra: contratto sospeso, corso disertato, condanna implicita. Nessuno ha chiesto cosa insegni, cosa pensi, se abbia mai approvato la guerra o criticato il suo governo. È bastata la divisa.
Ecco la nuova forma del boicottaggio accademico: nonlo si dichiara, lo si pratica. Si evitano le parole, si costruiscono protocolli, si invocano «verifiche trasparenti». L’ipocrisia come metodo.
Dietro tutto questo c’è la stessa distorsione che attraversa da mesi buona parte del dibattito pubblico: quella che trasforma Gaza in un dramma assoluto e Israele in un simbolo negativo, fuori dal diritto e dalla pietà. Un’antica inclinazione europea che cambia linguaggio ma non sostanza. Si invoca la giustizia universale, ma l’indignazione è sempre selettiva: c’è solo una vittima e un solo colpevole.
L’università, che dovrebbe essere il luogo dove la complessità viene analizzata e non ridotta, ha scelto di rispecchiare la piazza invece che guidarla. Di assecondare l’umore, non di correggerlo. E in questo Pavia non è un’eccezione: è un laboratorio del nuovo conformismo morale.
La foglia di fico della «condanna dell’antisemitismo» non copre la sostanza di un atto che in realtà contribuisce a normalizzarlo. Perché quando un’università isola i suoi partner ebrei in nome dei «diritti umani», quando cita Hamas in una mozione e ignora la realtà del terrorismo islamico, non sta prendendo posizione per la pace, ma contro la verità.
L’illusione di equidistanza serve solo a rendere più accettabile una scelta politica precisa. E l’università che si schiera così non educa, ma legittima. Fa dell’etica un abito di scena. E mentre dichiara di difendere i diritti umani, dimentica il primo di tutti: quello di non essere giudicati per ciò che si è.
La foglia di fico dell’Università di Pavia
La foglia di fico dell’Università di Pavia