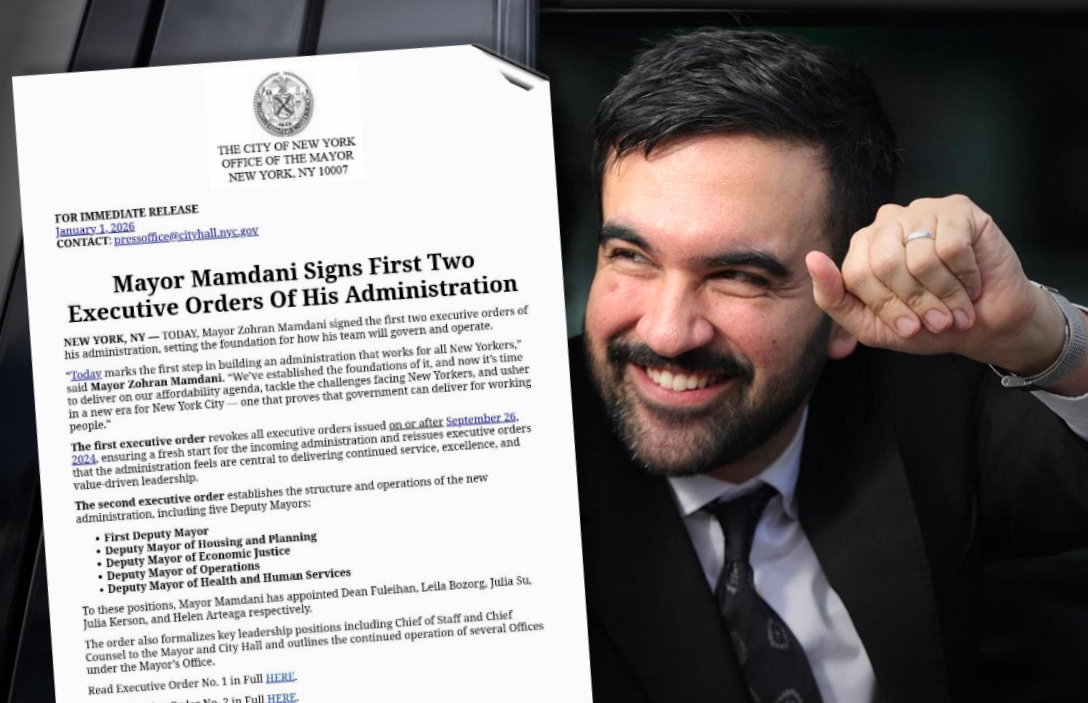Trentuno per cento. Quasi un giovane francese su tre, tra i 18 e i 24 anni, ritiene «legittimo prendersela con gli ebrei in nome della guerra a Gaza». Nella popolazione generale la percentuale è al 19%, già spaventosa. Intanto il 68% dei francesi riconosce che l’antisemitismo è una minaccia seria non solo per gli ebrei, ma per la società intera.
E sulla corsa al «riconoscimento» di uno Stato palestinese, il Paese non è affatto allineato allo slancio degli attivisti: il 71% dice che non deve essere immediato e che prima vanno liberati gli ostaggi; solo il 29% lo vuole subito. Tra i simpatizzanti di La France insoumise, il movimento fondato nel 2016 da Jean-Luc Mélenchon, il favore schizza al 78%. Questi numeri non sono un inciampo statistico, ma un vero bollettino culturale.
Come ci siamo arrivati? Con un lessico che da anni normalizza l’idea che l’ebreo sia «collettivamente responsabile». L’università che tace quando si urlano slogan di eliminazione, il talk show che mette in scena il gioco delle parti tra «pro» e «contro» come se il bersaglio fosse un’astrazione, il politico che strizza l’occhio alla piazza per un dividendo elettorale. Soprattutto, una pedagogia digitale che educa più della scuola: clip di trenta secondi, montaggi emotivi, parole d’ordine usate come badge identitari. «Decolonizzare», «resistenza», «apartheid»: parole trasformate in lasciapassare morali. E quando il lasciapassare si attacca alla pelle, il confine tra critica e aggressione svanisce: se l’altro è il Male, colpirlo diventa non solo lecito, ma doveroso.
Il veleno cammina su tre gambe. La prima è l’estetica della violenza: meme, video, soundbite che trasformano l’insulto in ironia e l’intimidazione in performance. La seconda è l’alibi etico: «non ce l’ho con gli ebrei, ce l’ho con Israele», che però si rovescia in un attimo quando si passa dalla bandiera alla persona. La terza è la deresponsabilizzazione degli adulti: dirigenti scolastici che temono il proprio consiglio studentesco, rettori che scambiano la libertà accademica per indifferenza, partiti che preferiscono l’ambiguità perché «parla ai giovani». Così la finestra di Overton scivola: ciò che ieri era impensabile oggi è discutibile, domani sarà praticabile.
Non basta contare gli atti. Bisogna nominare le cause: l’ossessione identitaria che riduce la storia a fiaba coloniale; la pigrizia giornalistica che confonde fatto e frame; l’infrastruttura dei social che premia la rabbia; l’ignoranza storica coltivata come virtù. Se un terzo dei giovanissimi trova «legittimo» colpire un ebreo in nome di Gaza, non è perché siano nati peggiori: è perché noi adulti abbiamo smontato i freni sostituendo l’educazione civica con il tifo, la complessità con il cartello, la responsabilità con l’algoritmo.
Il dato sul «riconoscimento immediato» dovrebbe far riflettere anche chi invoca scorciatoie simboliche: perfino un’opinione pubblica scossa pretende, prima, la liberazione degli ostaggi e la sconfitta del terrorismo. Tradotto: i cittadini capiscono che i gesti morali senza realismo producono solo altro fumo. I giovani, bombardati da moralismo a buon mercato, il fumo ormai lo respirano come aria.
È dunque necessario e impellente ripristinare lo stigma sociale verso ogni forma di violenza o intimidazione contro gli ebrei, smettendo di concedere tribune a chi la giustifica, rientrando nelle scuole con fatti, storia, diritto, e non con catechismi ideologici. E chiamando le cose col loro nome quando si travalica: non «incidente», non «eccesso di zelo», ma antisemitismo. Perché il veleno, se non lo nomini, diventa cemento. E nei più giovani, diventa abitudine. E l’abitudine, lo sappiamo, è la forma più solida dell’odio.
La coltivazione dell’odio
La coltivazione dell’odio