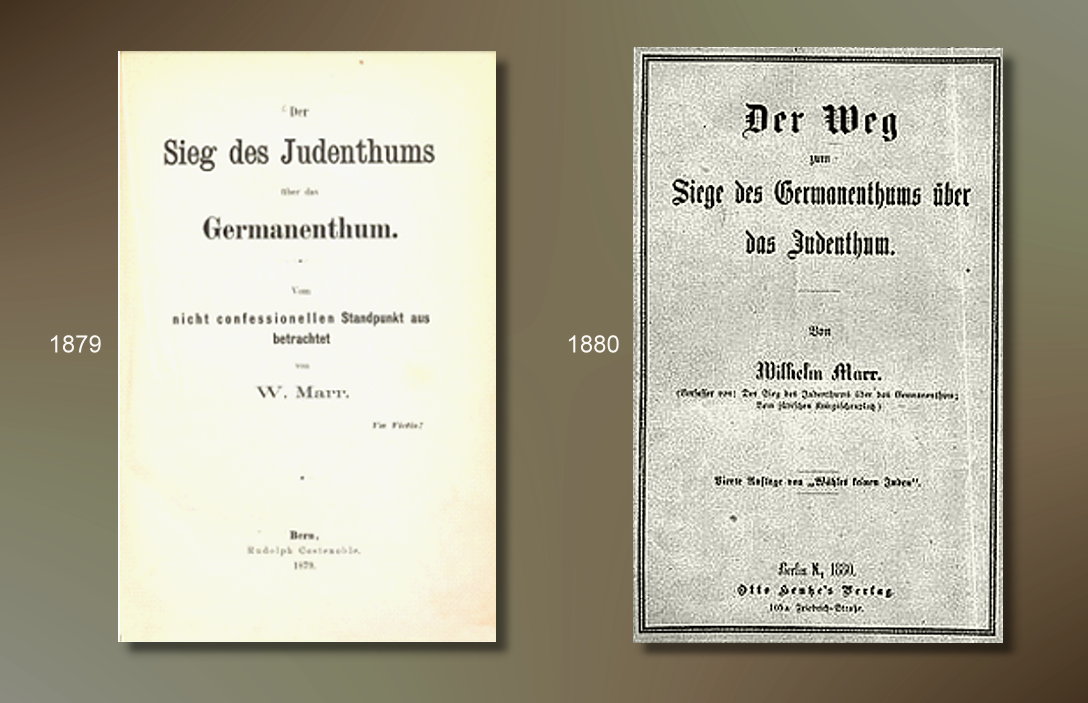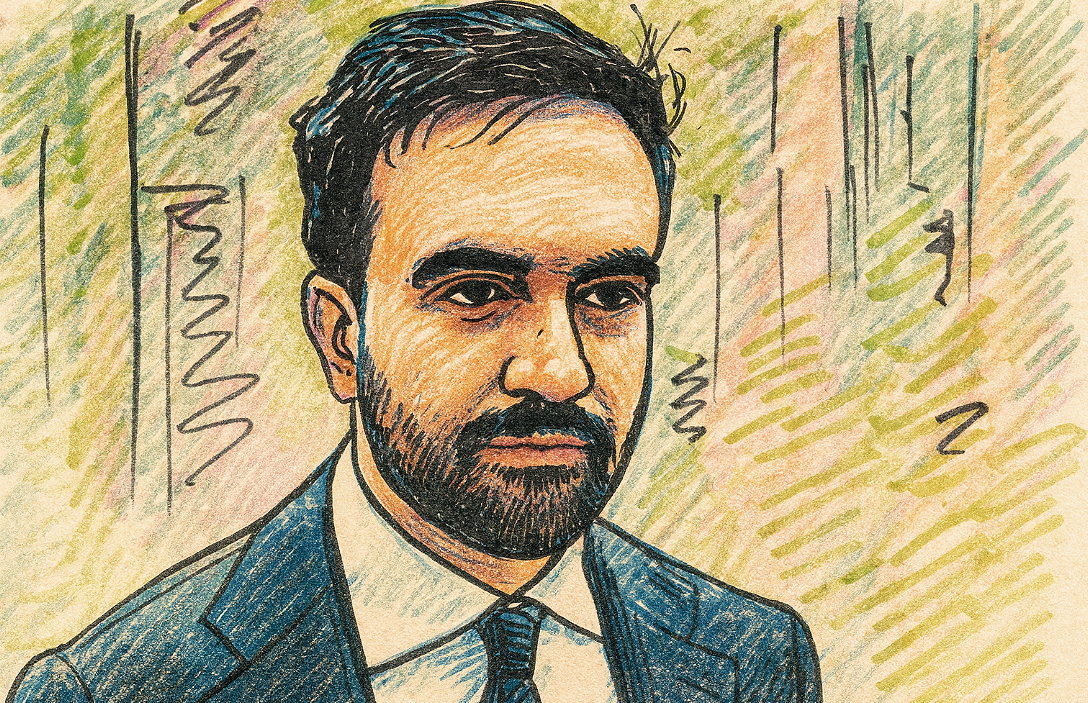La storia di Hsieh Levinson Taft è una di quelle che costringono a fermarsi, perché dentro una singola fotografia si addensano l’arroganza di un regime, la fragilità di una famiglia e una beffa che il tempo ha trasformato in una piccola, silenziosa rivincita. Taft è morta a 91 anni nella sua casa di San Francisco, come ha riportato il New York Times. Da neonata, nel 1935, il suo volto comparve sulla copertina di una rivista nazista che la celebrava come incarnazione della “bambina ariana ideale”. Peccato, per il Reich, che fosse ebrea.
La fotografia venne scattata a Berlino da Hans Blin, un professionista stimato nella capitale tedesca. In quel periodo, l’apparato di propaganda diretto da Joseph Goebbels aveva lanciato un concorso nazionale, una chiamata rivolta ai fotografi per individuare il neonato che meglio rispondesse ai canoni razziali del regime. Tra le immagini inviate, quella di Hsieh Levinson vinse. Fu pubblicata il 24 gennaio 1935 e riprodotta su biglietti d’auguri venduti nei negozi, come modello di perfezione biologica tedesca.
Per i genitori, ebrei perfettamente consapevoli del clima che li circondava, la scoperta fu uno shock. Non certo una curiosità mondana, ma semmai un pericolo concreto e ravvicinato. La madre, anni dopo, avrebbe raccontato di aver chiesto al fotografo se sapesse chi fossero davvero. La risposta, riferita dalla stessa Taft, fu disarmante nella sua ambiguità: lo sapeva, e disse di aver voluto “prenderli in giro”. Una leggerezza che non impedì conseguenze drammatiche. La famiglia iniziò a temere di uscire di casa, il padre fu arrestato da un ufficiale delle SS e riuscì a fuggire protetto da chissà quale angelo divino. A quel punto, restare in Germania non era più un’opzione.
Nel 1938 i Levinson lasciarono Berlino per Parigi, portandosi dietro la paura che quella fotografia potesse tradirli. Tre anni dopo, con la Francia occupata, fuggirono ancora, passando per Cuba prima di approdare negli Stati Uniti. Lì Hsieh Levinson costruì una vita solida e ordinaria, studiò chimica alla Columbia University, insegnò a Princeton, ebbe due figli con il marito Earl, matematico. Per decenni conservò tre copie di quella rivista, nascoste tra gli appunti salvati dalla madre durante la fuga, come si custodisce una prova, non un trofeo.
Nel 2014 tornò per la prima volta al centro simbolico di quella storia, visitando lo Yad Vashem a Gerusalemme. Donò una copia originale della rivista nell’ambito dell’iniziativa “Gather the Fragments”, dedicata al recupero di oggetti personali dell’Olocausto. In un’intervista concessa a Yedioth Ahronoth, le venne chiesto cosa provasse davanti a quel titolo, la più bella bambina ariana. Rispose senza enfasi, ma con una lucidità che ancora oggi colpisce: disse che provava vendetta, e che avrebbe voluto dirlo prima, quando c’erano più nazisti in vita.
Non si trattava di una frase ad effetto, né di una rivendicazione tardiva ma la constatazione che la propaganda, nel suo bisogno di assoluto, può tradirsi da sola. Il Reich aveva cercato un’icona, e aveva scelto il volto sbagliato. La bambina che doveva incarnare la purezza razziale ne ha invece esposto l’assurdità, senza saperlo, semplicemente esistendo. Oggi quella fotografia non racconta la potenza di un’ideologia, ma la sua fragilità. E la lunga vita di Hsieh Levinson Taft, attraversata dall’esilio e poi dalla normalità, resta come una nota a margine che il nazismo non aveva previsto, ma che lo smentisce meglio di qualsiasi manifesto.
La bambina “ariana” che smascherò il Reich
La bambina “ariana” che smascherò il Reich