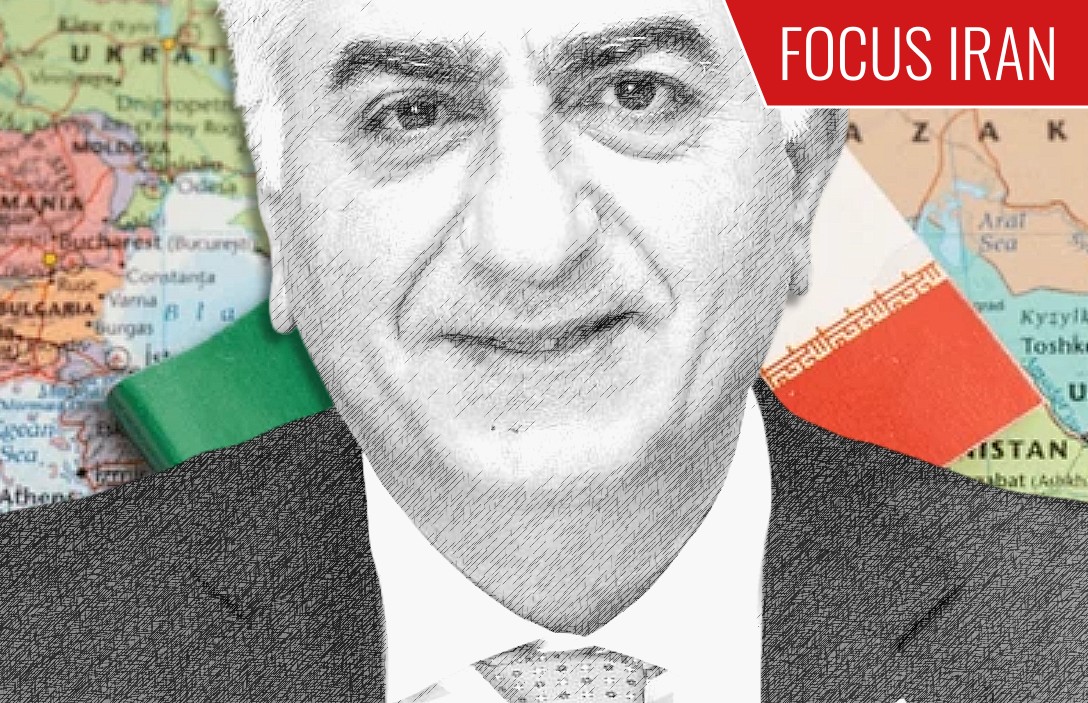La domanda che attraversa le cancellerie occidentali non è più se Israele possa colpire l’Iran, ma se sia davvero pronto a sostenerne le conseguenze. Le indiscrezioni secondo cui Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto al presidente Donald Trump di rallentare un’eventuale escalation militare hanno riaperto un dibattito cruciale: lo Stato ebraico dispone delle capacità necessarie non solo per infliggere danni, ma per reggere una guerra prolungata contro Iran?
Sul piano offensivo la risposta è relativamente semplice. Israele ha dimostrato, negli ultimi anni e in particolare nel confronto diretto del 2025, di poter colpire obiettivi iraniani anche a grande distanza, con una combinazione di intelligence, aviazione, missili stand-off e operazioni coperte. L’idea che Teheran sia intoccabile non è più credibile. Ma una guerra non si misura solo dalla capacità di colpire. Si misura soprattutto dalla capacità di assorbire i colpi.
È qui che emergono le vere ambiguità. La difesa aerea israeliana resta una delle più avanzate al mondo, ma il problema non è tecnologico bensì industriale e temporale. Un conflitto diretto con l’Iran non sarebbe fatto di singoli attacchi simbolici, bensì di ondate ripetute di missili e droni, lanciate sia direttamente sia tramite alleati regionali. In uno scenario di questo tipo, la variabile decisiva diventa la sostenibilità. Quante intercettazioni possono essere garantite ogni giorno, per quante settimane, a che costo economico e con quali scorte disponibili. Non si tratta di “buchi” nella difesa, quanto di un limite strutturale comune a qualunque sistema antimissile sottoposto a saturazione prolungata.
Israele lo sa, e lo sanno anche i suoi interlocutori americani. Non è un caso che, accanto alla retorica della deterrenza, crescano le pressioni diplomatiche per evitare che uno scontro degeneri in una guerra regionale. In questo quadro, la presunta prudenza di Gerusalemme non segnala debolezza, ma razionalità strategica: colpire l’Iran è possibile; gestirne la reazione per mesi è un’altra questione.
Il secondo elemento chiave riguarda proprio l’espansione del conflitto. L’ipotesi più temuta – una guerra regionale totale – resta oggi possibile ma non inevitabile. Il fattore determinante è il comportamento dei proxy iraniani, in particolare Hezbollah. Nonostante la retorica aggressiva, il movimento libanese appare più cauto rispetto al passato: il Libano è economicamente allo stremo e Hezbollah ha già pagato un prezzo elevato negli scontri con Israele. Un suo ingresso pieno in guerra trasformerebbe immediatamente il conflitto in una catastrofe regionale, ma proprio per questo non è una scelta automatica.
Ciò non significa che il rischio sia basso. Milizie sciite in Iraq e Siria, attacchi marittimi indiretti e operazioni cibernetiche offrono a Teheran molteplici strumenti di pressione “a bassa intensità”, capaci di allargare il conflitto senza superare formalmente la soglia della guerra totale. È questo il modello preferito dall’Iran: aumentare i costi per l’avversario mantenendo una plausibile negabilità e lasciando spazio a una de-escalation controllata.
Ed è qui che va valutata la credibilità delle minacce iraniane. Dal punto di vista delle capacità, Teheran non bluffa. Il suo arsenale missilistico e di droni è reale, ampio e in parte già testato contro Israele e i suoi alleati. L’Iran è in grado di colpire, di saturare le difese e di infliggere danni economici e simbolici significativi. Dove invece le minacce diventano meno credibili è sul piano dell’intenzione di scatenare una guerra totale immediata. Il regime iraniano tende a calibrare con attenzione le proprie mosse, consapevole che uno scontro aperto metterebbe a rischio la sua stessa stabilità interna.
In questo senso, la deterrenza funziona ancora, ma in modo instabile. Israele può colpire l’Iran; l’Iran può far pagare un prezzo elevato a Israele; nessuno dei due ha interesse a perdere il controllo dell’escalation. Il vero rischio non è una decisione razionale di “andare in guerra”, bensì una catena di reazioni mal calcolate, un attacco percepito come eccessivo, o un errore di interpretazione delle intenzioni dell’altro.
Alla fine, la domanda iniziale va riformulata. Israele è pronto a una guerra breve e ad alta intensità? Probabilmente sì. È pronto a una guerra lunga, regionale, economicamente e politicamente corrosiva? Molto meno. Ed è proprio questa consapevolezza, condivisa anche dai suoi alleati, a spiegare perché, dietro la retorica muscolare, continui a prevalere una linea di contenimento prudente. Non per mancanza di forza, ma per eccesso di realismo.
Israele è pronto a una guerra con l’Iran?
Israele è pronto a una guerra con l’Iran?