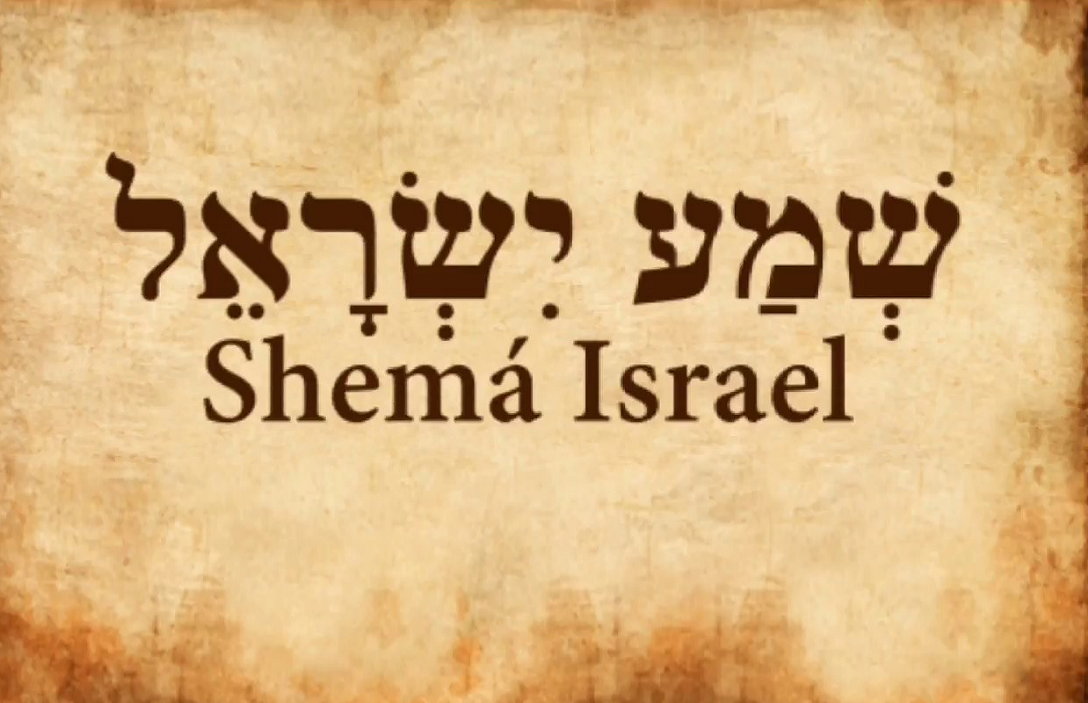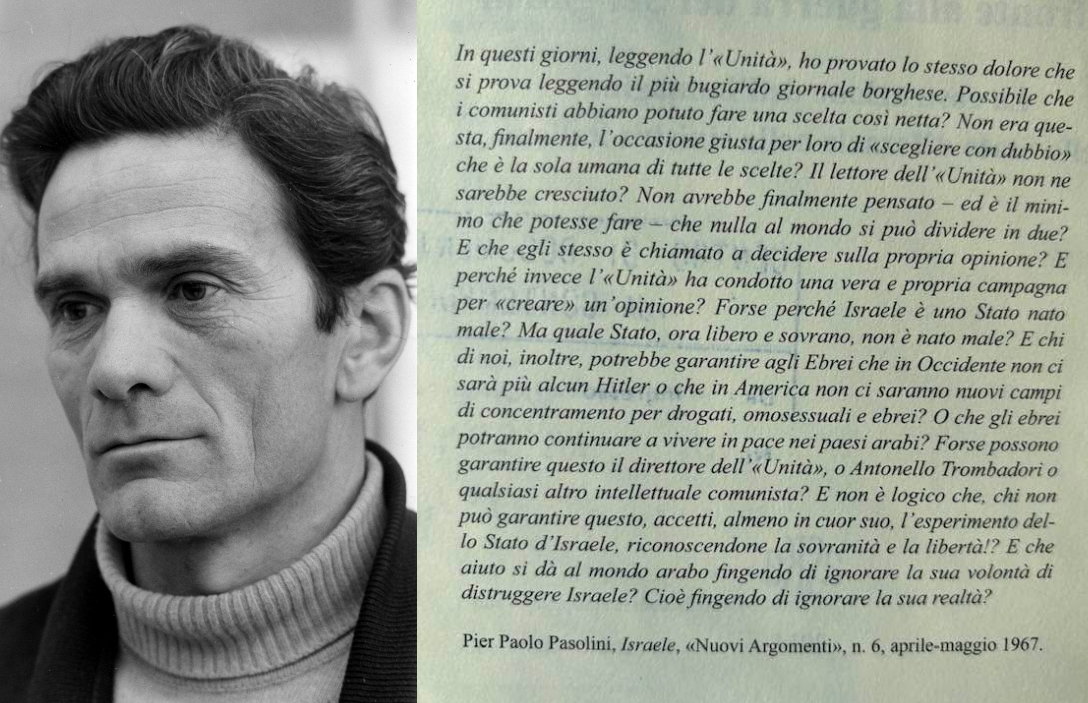L’ottantesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che dal 23 settembre vivrà a New York il suo momento più importante con il cosiddetto “dibattito generale” cui partecipano decine di Capi di Stato e di Governo, sarà una delle più difficili e delicate per Israele. Si cominciano infatti a delineare le tremende conseguenze del massacro di ebrei del 7 ottobre 2023 che, per la sua efferatezza inaudita, le dimensioni senza precedenti e la vastità delle reazioni scatenate in Israele e nel mondo, si è imposto come spartiacque senza ritorno.
Mai Israele era apparso così vulnerabile, mai era stato coinvolto così a lungo in un conflitto sul terreno, mai era stato attaccato su tanti fronti, mai così diviso e lacerato al suo interno. Mai la popolazione palestinese era stata così duramente colpita dalla reazione militare israeliana, e mai Israele era stato così isolato e stigmatizzato dalla condanna di gran parte della comunità internazionale.
Agli occhi degli israeliani, e non soltanto del governo Netanyahu, le Nazioni Unite hanno da tempo perso la credibilità di un onesto mediatore. Vi hanno contribuito la sproporzione tra le risoluzioni adottate contro Israele e quelle contro altri Paesi in conflitto, una lettura unilaterale del diritto dei due popoli a vivere in pace e sicurezza, la strumentalizzazione antisionista e antisemita di tematiche globali come la lotta al razzismo (dalla famigerata Conferenza di Durban in poi) e, da ultimo, la dichiarata comprensione delle presunte ragioni di Hamas da parte dei vertici ONU.
Il dibattito a New York non parte sotto i migliori auspici. Numerosi leader mondiali si dicono impegnati per una soluzione che ponga fine alle ostilità e soccorra i gazawi stremati, ma in realtà non sembrano avere “le carte” per farlo, per usare la brutale terminologia di Trump sull’Ucraina. I clamorosi annunci di imminente riconoscimento dello Stato palestinese da parte delle principali cancellerie occidentali non muteranno la situazione sul terreno, ma rischiano di esacerbare il confronto.
L’opinione pubblica israeliana, compresi molti oppositori di Netanyahu, leggerà tali mosse come conferma che l’ONU è irrimediabilmente antisionista, che il 7 ottobre è passato invano e che Israele può contare solo su sé stesso. In questo quadro, Netanyahu, pur con i suoi limiti, appare come l’unico leader cui affidarsi. Hamas, dal canto suo, ne ricaverà un trofeo da sbandierare: aver inflitto un isolamento umiliante a Israele e aver mostrato al mondo il volto che molti, anche in Occidente, attribuiscono allo Stato ebraico.
La prospettiva di una leadership palestinese nuova, capace di coesistere con Israele, appare sempre più lontana. Le iniziative a favore del popolo palestinese, come la “Flottiglia” nel Mediterraneo e le piazze europee, risultano irrilevanti sul piano umanitario e appaiono piuttosto ispirate a intenti propagandistici e provocatori.
Nel frattempo, Israele è stato sistematicamente demonizzato nei media, nella rete, nelle università e persino nello sport e nell’arte. Il sionismo viene ridotto a sinonimo di fascismo e colonialismo. Da qui, la recrudescenza dell’antisemitismo, presentato come inevitabile reazione a Gaza e che oggi dilaga in modo spaventoso.
Non tutto è però perduto. Molto dipenderà dagli esiti del dibattito ONU e dalle responsabilità che i diversi attori sapranno assumersi. Francia e Arabia Saudita hanno promosso a luglio una Conferenza sulla soluzione dei due Stati, la cui Dichiarazione finale è stata recepita dall’Assemblea Generale (con voto contrario di USA, Israele e Ungheria). Il testo lega la cessazione delle ostilità al rilascio degli ostaggi, all’afflusso di aiuti umanitari, al disarmo di Hamas e all’insediamento di un governo provvisorio palestinese con missione internazionale di stabilizzazione sotto mandato ONU.
Solo se tali condizioni saranno rispettate, il pieno riconoscimento dello Stato palestinese potrà aprire un percorso politico e diplomatico verso la soluzione dei due Stati, proclamata nel 1948 ma mai realizzata per il rifiuto arabo di riconoscere Israele.
Gli Stati Uniti hanno l’onere maggiore: spetta a Trump superare la sua visione transattiva e convincere Netanyahu che Israele non può vivere in una guerra perenne, che consuma le sue energie migliori e logora la coesione interna.
Ai Paesi arabi sunniti tocca tradurre la loro adesione alla causa palestinese in sostegno politico ed economico a un futuro Stato capace di convivere con Israele, rilanciando lo spirito degli Accordi di Abramo.
A Netanyahu spetta comprendere che Israele non agisce nel vuoto e deve restare fedele ai suoi valori fondanti, rinunciando a una logica di potenza per una difficile ma necessaria coesistenza.
Quanto all’Europa, da sempre ambigua sul conflitto israelo-palestinese, è il momento di guardare alla realtà e assumersi responsabilità concrete. Sventolare riconoscimenti senza un impegno politico, diplomatico, economico e militare per renderli effettivi non ha senso. Altrimenti, meglio tacere.
Israele di fronte all’ONU (e al suo futuro)
Israele di fronte all’ONU (e al suo futuro)