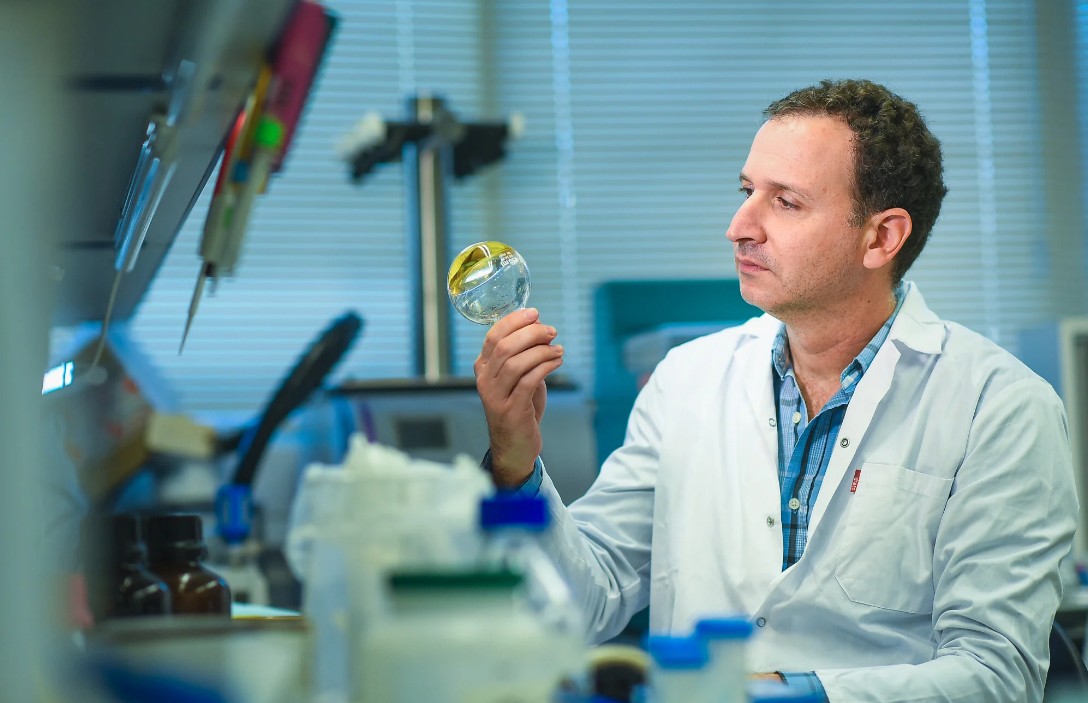Quando lo sceicco Hikmat al-Hajri parla di genocidio, non lo fa per forzare le parole né per cercare attenzione internazionale. Lo dice con la secchezza di chi ha visto la propria comunità colpita in modo sistematico e sa che, senza una protezione esterna, il conto sarebbe stato ancora più alto. Sei mesi dopo il massacro che ha travolto i drusi nel sud della Siria, causando oltre duemila morti secondo le ricostruzioni locali, il leader spirituale di Sweida descrive una realtà che non assomiglia più a una crisi temporanea, ma a una frattura definitiva.
Al-Hajri parla di un regime che non distingue tra oppositori politici e minoranze religiose, e che considera i drusi un corpo estraneo da piegare o eliminare. Non una deviazione improvvisa, sostiene, ma l’esito coerente di un’ideologia jihadista che lui definisce senza esitazioni una prosecuzione di Al-Qaeda sotto altre insegne. La violenza di luglio, con esecuzioni, stupri e villaggi incendiati, viene presentata come un’operazione deliberata, non come il caos di una guerra civile ormai cronica.
La provincia di As-Suwayda vive da allora in uno stato di assedio. Le strade sono bloccate, l’economia è paralizzata, gli studenti evitano le università fuori regione, i malati gravi non vengono accolti negli ospedali del resto del Paese. Mancano cibo e medicinali, e intere famiglie hanno trovato rifugio in scuole ed edifici pubblici dopo la distruzione dei villaggi. In questo quadro, Israele entra nel racconto non come un attore distante, ma come l’unico intervenuto in modo concreto nel momento più critico.
Secondo Al-Hajri, gli attacchi aerei israeliani hanno fermato il massacro mentre era in corso. Non esiste un corridoio umanitario stabile, eppure centinaia di feriti e malati drusi sono stati curati negli ospedali israeliani. Il leader druso parla di un legame antico, fatto di rapporti familiari e di una prossimità che precede la caduta del regime di Bashar al-Assad, anche se per decenni ogni contatto ufficiale con Israele è stato proibito e punito da Damasco.
Da qui nasce una presa di posizione che segna un punto di non ritorno. Al-Hajri non chiede semplicemente protezione, ma rivendica un futuro politico separato. La Siria, dice, non è più uno Stato unitario e non tornerà ad esserlo. La soluzione passa per l’autogoverno e, in prospettiva, per una regione drusa indipendente, eventualmente accompagnata da una fase transitoria sotto la garanzia di un attore esterno. In questa visione, Israele non è solo un alleato di fatto, ma il garante più credibile di qualsiasi accordo futuro.
La delusione verso il mondo arabo è totale. Nessuna condanna del massacro, nessun sostegno politico, anzi una narrazione che ha spesso dipinto i drusi come complici o traditori. Al-Hajri accusa apertamente Paesi come la Turchia di sostenere, direttamente o indirettamente, le forze che opprimono le minoranze siriane. Allo stesso tempo, rivendica un coordinamento strategico con le forze curde, viste come un altro tassello di una possibile architettura post-siriana basata su autonomie regionali.
Il quadro che emerge è quello di una comunità che ha smesso di aspettare salvezze dall’interno e che ha tratto una conclusione netta dall’esperienza degli ultimi mesi. Restare nella Siria governata da Damasco significa accettare una condizione di vulnerabilità permanente. Guardare a Israele, invece, non è presentato come una scelta ideologica, ma come una necessità di sopravvivenza. In questa logica, la divisione del Paese non è una minaccia alla stabilità regionale, bensì l’unica strada per evitare che il Medio Oriente continui a produrre massacri invisibili, consumati lontano dalle capitali e dalle dichiarazioni ufficiali.