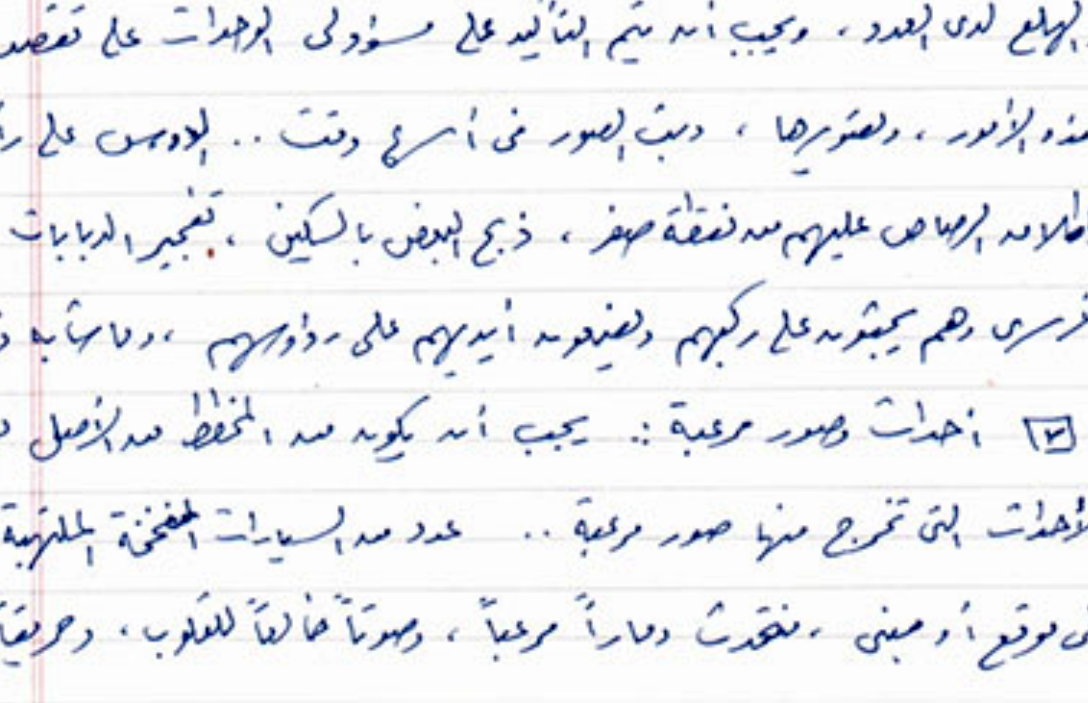Gerusalemme, oggi. Fermata dell’autobus al crocevia di Ramot: sei morti e almeno quattordici feriti, alcuni gravi. Due aggressori neutralizzati. La città riparte in pochi minuti perché qui la normalità convive con l’idea che l’attacco possa riaffacciarsi a ogni incrocio. È il promemoria brutale di un fatto semplice: il terrorismo palestinese non è un lampo isolato, è un flusso continuo che cerca bersagli morbidi e tempi morti. E c’è un effetto politico immediato: drammi così irrobustiscono le ragioni delle ali estreme. Ben Gvir e compagnia li brandiscono per chiedere più durezza, più armi civili, più posti di blocco e meno vincoli, spingendo l’asse del Paese ancora più a destra.
La parte sommersa non fa notizia. Nel 2024 lo Shabak ha sventato ben 1.040 attentati di rilievo in Cisgiordania e a Gerusalemme: una media settimanale che racconta più di qualunque editoriale. Cellule smontate, depositi d’armi svuotati, ordigni sequestrati, autori designati fermati prima che premano il grilletto. Il baricentro è la Cisgiordania, ma non solo: Gerusalemme, la fascia costiera e le grandi arterie restano linee calde. La prevenzione si fa con pedinamenti, intercettazioni, infiltrazioni, analisi di traffici e spostamenti.
Eppure alcuni colpi passano. Nelle ultime settimane sparatorie a incroci, fermate e posti di controllo hanno bucato le maglie della rete e lasciato morti e feriti. Sono gli episodi che occupano i notiziari e alimentano l’illusione ottica: si vede solo ciò che è esploso, mai ciò che è stato disinnescato. Lo Stato vive nell’allerta permanente perché conosce la statistica reale: l’avversario deve riuscire una sola volta, gli apparati devono riuscire sempre.
Dentro questa guerra a bassa visibilità c’è una macchina che non si ferma: unità di polizia di frontiera e forze speciali, sorveglianza elettronica, droni, pattuglie che entrano ed escono dai campi, interrogatori a catena che fanno emergere reti di appoggio. L’ecosistema del terrore è plastico: singoli ispirati online, cellule che rispondono ai grandi marchi dell’odio, finanziatori che spostano contante e componenti, armi clandestine, coltelli, auto usate come ariete. La risposta è adattiva: si stringono varchi, si chiudono contatti, si marcano i nodi prima che diventino esecutori.
Questa attività non appare perché non ha immagini né sirene. È fatta di faldoni, celle telefoniche, ore di ascolto, varchi controllati, porte sfondate alle tre di notte in una casa qualunque di Nablus o Jenin. Si racconta solo quando fallisce, mai quando riesce. Eppure è quella che regge la routine israeliana: scuole aperte, autobus in servizio, mercati che funzionano.
Il quadro è semplice e sgradevole: la violenza non si è fermata, semmai si è professionalizzata. I promotori testano strumenti nuovi, cercano bersagli simbolici, puntano sull’effetto imitativo. Lo Stato risponde con l’unica arma possibile in una democrazia: prevenzione aggressiva dentro la legge, forza mirata, burocrazia rapida, responsabilità chiare. Non esiste il rischio zero; esiste il rischio ridotto ogni giorno da persone che non compariranno mai in nessuna conferenza stampa.
Ramot oggi lo dice chiaro. Bastano pochi minuti e due armi per trasformare una fermata in un cratere nella fiducia pubblica. Ma il bilancio reale si misura anche nel resto del giorno: nelle operazioni che nessuno ha visto, negli attentati che non sono avvenuti, nelle famiglie che non sapranno mai di essere state salvate da una perquisizione, da un’auto fermata a un posto di blocco, da un nome spuntato in un database al momento giusto.
Israele, attentato a Gerusalemme e la guerra che non si vede
Israele, attentato a Gerusalemme e la guerra che non si vede