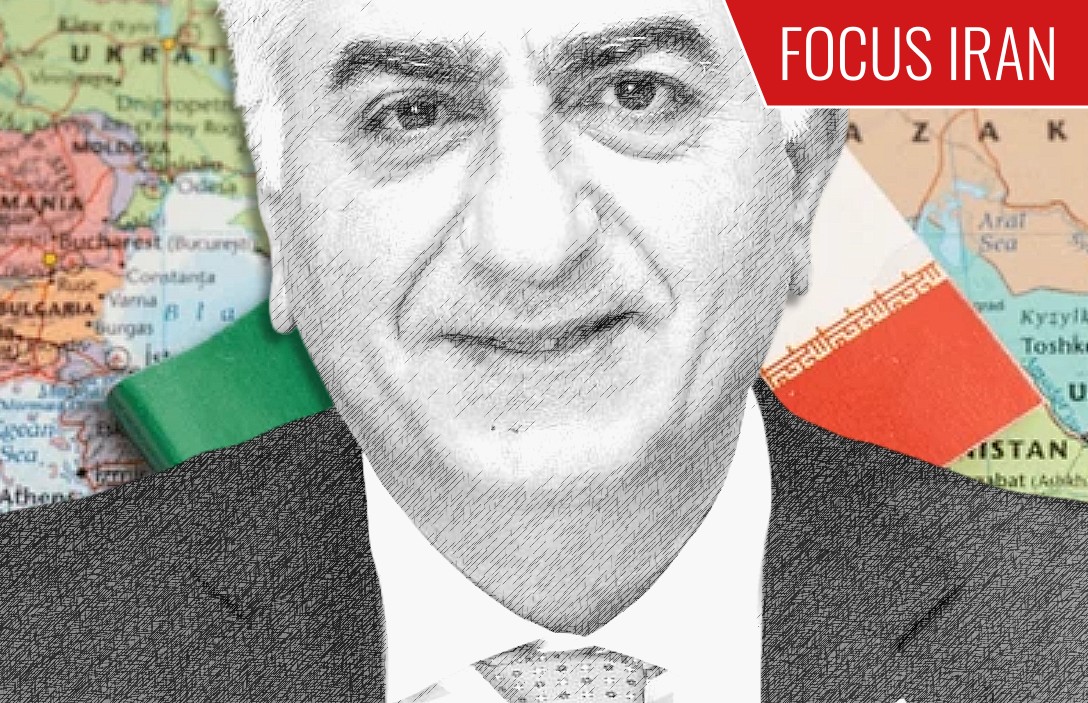Nel pieno di una delle fasi più tese degli ultimi anni in Medio Oriente, mentre l’attenzione internazionale resta sospesa in attesa di capire se e come gli Stati Uniti decideranno di intervenire contro l’Iran, dal cuore della diaspora iraniana arriva un atto d’accusa frontale contro le Nazioni Unite. Non è una denuncia generica né un esercizio retorico, ma una requisitoria costruita su fatti, nomi e corpi che continuano a cadere nelle strade iraniane e su un silenzio istituzionale che, agli occhi di chi è fuggito dal regime, equivale a una forma di complicità.
Nelle stesse ore in cui l’agenzia Fars, legata agli apparati del potere di Teheran, diffondeva filmati presentati come riprese delle cosiddette “telecamere dei manifestanti”, nel tentativo maldestro di suggerire un quadro di violenza che giustificherebbe la repressione, le immagini mostravano in realtà ben poco di ciò che il regime vorrebbe dimostrare. Nessuna insurrezione armata, nessuna folla devastante, ma frammenti confusi che sembrano servire più a costruire un alibi che a raccontare una realtà. Una strategia comunicativa ormai collaudata, che prova a riscrivere ciò che accade mentre le forze di sicurezza sparano, arrestano e isolano il Paese con blackout informativi sempre più estesi.
A rendere il quadro ancora più grave è il coinvolgimento diretto di milizie sciite irachene legate a Teheran, entrate in Iran per contribuire alla repressione delle proteste scoppiate a fine dicembre. Migliaia di combattenti, secondo valutazioni di sicurezza occidentali, avrebbero attraversato i valichi meridionali del confine iracheno per rafforzare un apparato repressivo che fatica a reggere l’urto di una contestazione diffusa, trasversale e sempre meno intimorita. Il ricorso a forze straniere segnala la fragilità del regime e, allo stesso tempo, la sua determinazione a non arretrare, anche al costo di un’escalation sanguinosa contro la propria popolazione.
Questo scenario è approdato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove il dibattito ha messo in luce tutte le contraddizioni dell’organizzazione. Da un lato, appelli formali alla moderazione e all’indagine sulle violazioni dei diritti umani; dall’altro, l’assenza di una presa di posizione chiara e pubblica da parte del Segretario Generale, percepita dagli esuli come un segnale devastante. È in questo contesto che la voce di Masih Alinejad, giornalista iraniana in esilio, ha rotto l’equilibrio diplomatico fatto di frasi calibrate e cautela lessicale. Sopravvissuta a ripetuti tentativi di rapimento e di assassinio organizzati dalle Guardie Rivoluzionarie, Alinejad ha parlato non come osservatrice, ma come testimone diretta di un sistema che elimina chi osa dare parola agli altri.
Davanti ai membri del Consiglio di Sicurezza, Alinejad ha accusato apertamente l’ONU di aver fallito il proprio compito, ricordando che mentre i comunicati restano sulla carta, in Iran si spara sui manifestanti, si eseguono arresti di massa e si spegne ogni canale di comunicazione. Ha chiesto giustizia per chi ha ordinato il massacro e ha denunciato il trasferimento di risorse economiche del Paese verso Hamas, Hezbollah e gli Houthi, mentre milioni di iraniani non riescono a permettersi neppure il pane. Le sue parole, spezzate dalle lacrime mentre leggeva i nomi degli uccisi, hanno reso evidente la distanza abissale tra il linguaggio della diplomazia e quello della realtà.
Sul piano internazionale, intanto, la posizione americana resta ambigua. L’amministrazione di Donald Trump mantiene tutte le opzioni sul tavolo, alternando minacce, rinvii e dichiarazioni che lasciano intendere una pressione calcolata più che una decisione imminente. L’ambasciatore statunitense all’ONU ha definito il regime iraniano una minaccia strutturale alla sicurezza regionale, richiamando il sostegno al terrorismo e il programma nucleare, ma senza sciogliere il nodo centrale di un intervento che potrebbe innescare una reazione a catena in tutto il Medio Oriente.
Israele osserva, misura le parole e rafforza le proprie difese, consapevole che qualsiasi mossa americana avrebbe ricadute dirette sulla sua sicurezza. Le valutazioni che circolano tra analisti e governi convergono su un punto: un attacco militare, anche esteso, difficilmente porterebbe alla caduta del regime, mentre potrebbe alimentare un’escalation regionale. Eppure, l’idea di restare fermi mentre il sangue scorre appare, per la diaspora iraniana, altrettanto inaccettabile.
È in questa tensione irrisolta che si consuma l’accusa più dura rivolta all’ONU: non tanto l’impotenza, quanto l’abitudine a nascondersi dietro procedure e formule, lasciando che il tempo passi mentre la repressione continua. Per chi è fuggito dall’Iran e continua a ricevere messaggi clandestini grazie a connessioni di fortuna, il silenzio non è neutro. È un messaggio che arriva chiaro a Teheran, e che dice che si può continuare.
Iran. La voce degli esuli e il silenzio delle istituzioni
Iran. La voce degli esuli e il silenzio delle istituzioni