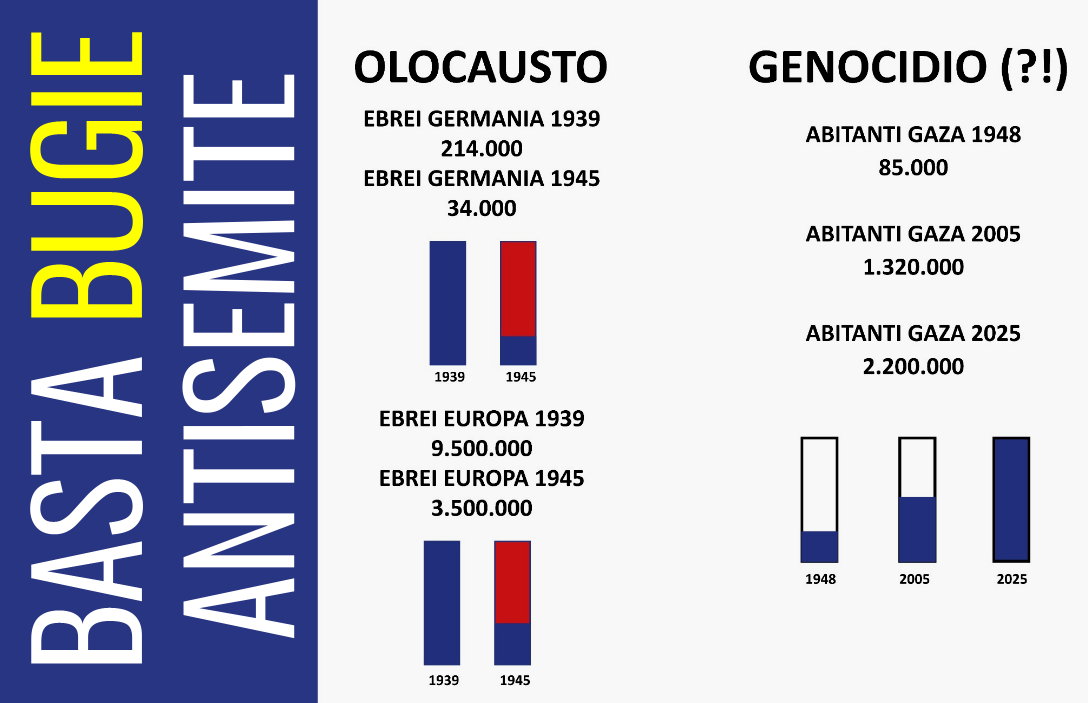In Occidente continuiamo a fissare l’Iran attraverso la lente più rassicurante: missili, centrifughe, rapporti dell’AIEA. È una trama nota, che permette di parlare di geopolitica senza guardare davvero dentro la vita delle persone. Eppure, ascoltando ciò che circola sulle reti iraniane, nei canali Telegram clandestini, nei messaggi criptati dall’interno del Paese, emerge una priorità diversa: domare le donne. È nei corpi e nelle voci femminili che Teheran vede la minaccia più strutturale alla propria sopravvivenza.
La riforma della dote, presentata come un sollievo sociale, nasce da questa logica di contenimento. Togliere alla dote la sua forza coercitiva significa disarmare milioni di donne che, in un sistema dove il divorzio favorisce l’uomo, la violenza domestica resta quasi impunita e i tribunali non riconoscono una reale proprietà congiunta, avevano in quel debito una delle pochissime leve di autodifesa. Prima, un marito violento sapeva che rifiutare il pagamento poteva costargli il carcere. Ora non più. Il governo parla di misure “ragionevoli”, di prevenzione dell’indebitamento, di protezione delle famiglie. Ma nelle piazze digitali iraniane la parola più ricorrente è un’altra: espropriazione. Avvocate femministe, riformisti superstiti e ONG in esilio lo dicono chiaramente: è un colpo secco alla già fragile autonomia economica femminile.
La storia di Bitta Shafi e di sua madre mostra cosa significhi questa stagione repressiva quando scende nel fango della vita reale. Bitta, giovane di Isfahan, era diventata nota denunciando i misteriosi avvelenamenti di studentesse in decine di scuole. Non un’attivista di professione, ma una ragazza che aveva scelto di non tacere. Per questo era stata arrestata, intimidita, rilasciata. Non aveva smesso di parlare, né di denunciare la violenza di Stato dopo la morte di Mahsa Amini. Così il regime ha colpito altrove: la madre, Miriam, prelevata da casa con accuse opache; poi la stessa Bitta, di nuovo arrestata e fatta sparire in isolamento. Una dinamica che riecheggia i casi di Sepideh Qolian o Narges Mohammadi, e conferma una legge non scritta: quando la figlia alza la testa, la madre paga il prezzo. La repressione diventa familiare, trasversale, mirata a spezzare la catena di solidarietà tra generazioni.
È un metodo che si intreccia con le ultime mosse legislative: restringere gli spazi, ridurre i diritti, chiudere ogni margine di manovra. Non è un incidente, ma una strategia affinata dopo le mobilitazioni del 2019 e del 2022, quando ragazze di vent’anni hanno portato in piazza una rabbia che il regime non aveva previsto. Teheran ha capito che il dissenso femminile non è episodico: è un processo culturale che attraversa la società, contagia le periferie, si irradia all’estero e soprattutto crea reti. Dai video senza hijab su Instagram alle campagne globali per le detenute politiche, queste donne parlano una lingua che la Repubblica Islamica non controlla più.
Ed è per questo che il regime ha più paura di loro che dei droni israeliani. I missili si possono intercettare; le donne no. Non quando hanno imparato a condividere, registrare, denunciare. Non quando la loro libertà diventa una questione generazionale. La battaglia decisiva dell’Iran non si gioca nelle centrifughe di Natanz, ma nei silenzi delle stazioni di polizia, nelle clausole di un contratto matrimoniale, nelle improvvise sparizioni dai social di ragazze che avevano imparato a dire il proprio nome.
Per capire dove sta andando l’Iran, bisogna guardare lì: dentro quella crepa piccola e luminosa che si apre ogni volta che una donna alza la testa e il regime, spaventato, risponde con il buio.
Iran. La figlia, la madre e il regime
Iran. La figlia, la madre e il regime