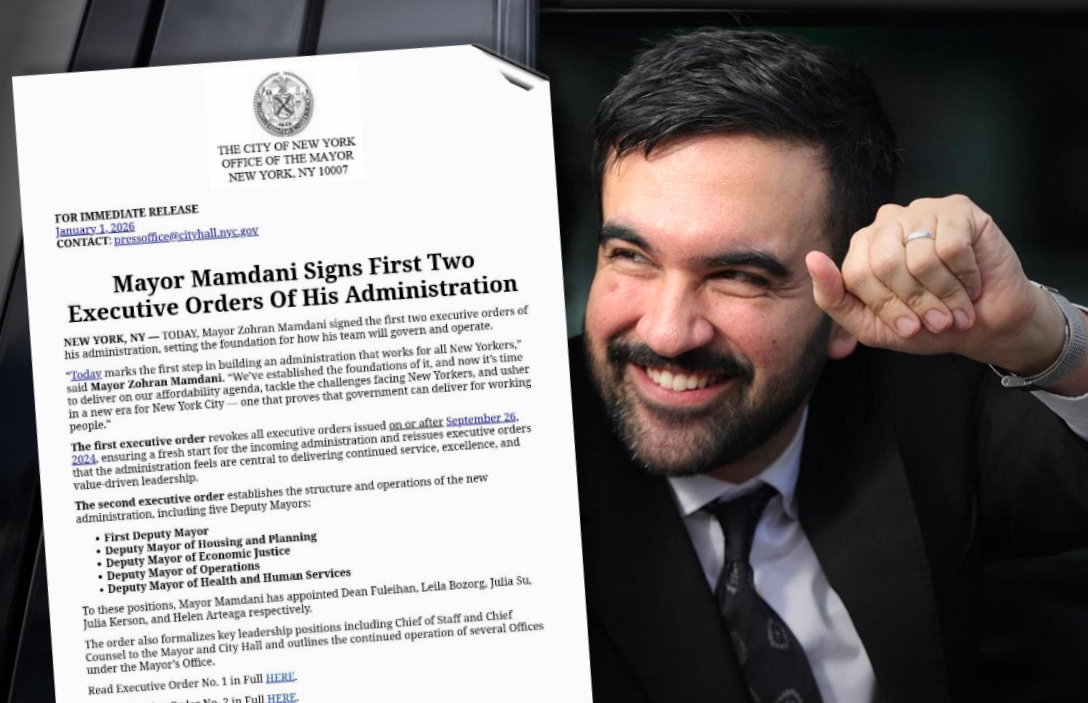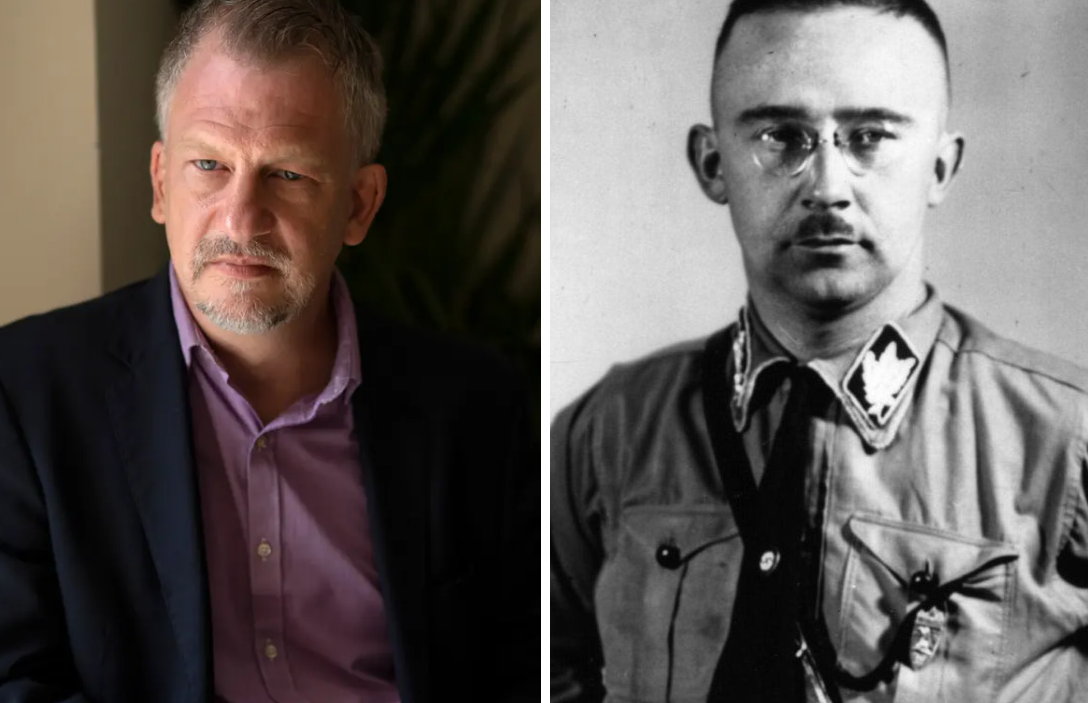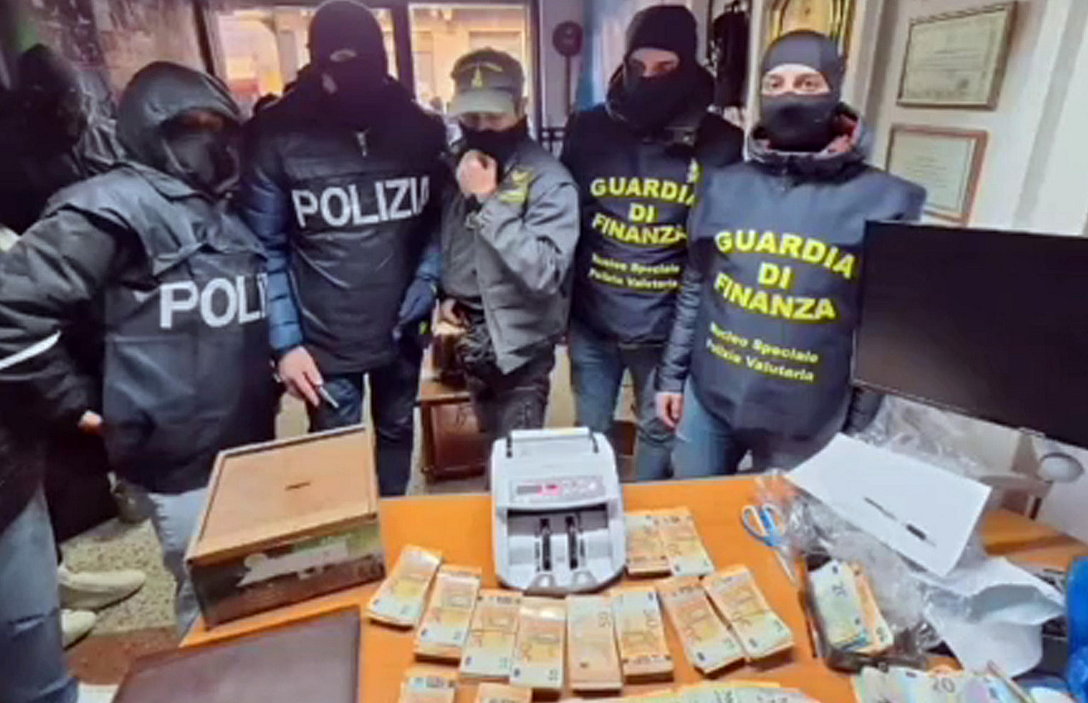Viene sempre più da dubitare che l’espressione storico-psicoanalitica «fare i conti con il proprio passato» abbia ancora – se mai l’ha avuto – un senso. Perché nessuno può negare che la Germania i conti col proprio passato li abbia fatti, eccome. Nessuno può dire che non abbia saputo guardarsi allo specchio, riconoscere l’orrore del nazismo e costruire una democrazia fondata sulla memoria e sulla responsabilità.
Va anche detto che la Repubblica Federale ha fatto molto più del nostro Bel Paese, dove ci si culla ancora nella panzana dei «bravi italiani», mai stati veramente razzisti, mai veramente complici, mentre ogni tanto spuntano eroi misconosciuti – un padre? uno zio? un nonno? – che a loro rischio e pericolo avrebbero salvato decine (ma che dico decine? Centinaia!) di ebrei perseguitati. Questa è però un’altra – e tristissima – storia di bugie e mistificazioni, su cui un giorno o l’altro dovremo pur tornare per ricordare qualche verità sgradevolissima.
Per tornare alla Germania, bisogna constatare che dopo il 7 ottobre 2023, anche qui, come in altri Paesi europei, molte maschere di cera si sono dissolte e una ferina ondata di odio ha dimostrato che il lavoro sulla memoria, se non diventa sostanza, se non entra stabilmente nel patrimonio civile, non è che una liturgia fasulla e indigesta.
L’agghiacciante contabilità della violenza contro gli ebrei segnala che nel 2024, nella Repubblica Federale di Germania, sono stati registrati ben 8.627 episodi. L’anno prima erano quasi la metà: 4.886. Nel 2020, ancora meno: 1.957. La crescita esponenziale lascia storditi e affranti. È difficile accettare la sequela di minacce, aggressioni, violenze, vandalismi, insulti nei cortei, incitamenti all’odio online. In 186 casi si è trattato di aggressioni fisiche, in 300 di minacce dirette.
Inquieta soprattutto il contesto: oltre 1.800 manifestazioni pubbliche hanno veicolato messaggi dichiaratamente antisemiti sotto la canagliesca parvenza di «critiche legittime a Israele». Slogan come «From the river to the sea» (cioè: cancelliamo Israele dalle mappe geografiche) o la chiamata al boicottaggio culturale e accademico di ogni realtà israeliana rientrano tra le espressioni più orgogliosamente esibite e impunite.
Nell’epoca scimunita del woke, contro ebrei, israeliani e sionisti tutto è permesso, tutto è dicibile, tutto viene ripetuto, inneggiato e applaudito.
Secondo il rapporto 2025 dell’associazione RIAS (Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, organizzazione indipendente tedesca che analizza episodi di antisemitismo nella Repubblica Federale), ben il 26% degli episodi rilevati è riconducibile all’«attivismo anti-Israele». Non sempre fisicamente violento, certo, ma spesso prodotto da un antigiudaismo rancoroso che ha solo cambiato linguaggio, senza perdere di vista il bersaglio: dall’ebreo «avido e traditore» all’israeliano «colonialista e assassino».
Qualche fatto recente ed esemplare: il 21 febbraio 2025, al Memoriale della Shoah a Berlino, Wassim al M., siriano diciannovenne, aggredisce con un coltellaccio un turista spagnolo. «Volevo ammazzare un ebreo», si vanta davanti ai poliziotti, scrollando le spalle. E che sarà mai? Del resto, non ha fatto altro che mettere in atto ciò che i suoi compagni promettono.
Aprile 2025, Humboldt-Universität zu Berlin. Alcuni attivisti filopalestinesi occupano l’edificio, imbrattano i muri con insulti contro Israele e simboli di Hamas, causando danni stimati in oltre 60.000 euro. Anche qui, tra gli slogan: «Zionists not welcome», «Intifada now». Il tutto in una delle università pubbliche più antiche del Paese, che in passato vide passare nei suoi corridoi Albert Einstein, Max Planck e Karl Marx.
Sindacati, organizzazioni non governative, partiti progressisti: la cosiddetta «società civile» tedesca ha reagito con lo stesso atteggiamento equivoco. In molti casi, soprattutto a sinistra, si è preferito adottare la formula tartufesca che distingue «ebraismo» e «sionismo», legittimando così un linguaggio che, nella pratica, finisce per colpire i cittadini ebrei tedeschi. Nessuno si stupisce se le comunità ebraiche denunciano un crescente clima di isolamento, mentre sempre più giovani ebrei fanno le valigie.
Al governo di Friedrich Merz va riconosciuta la capacità di aver saputo reagire con una qualche fermezza: sgomberi immediati dei presìdi universitari pro-Hamas, stretta sui gruppi antisemiti, applicazione rigorosa della definizione di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, organismo internazionale intergovernativo dedicato alla memoria della Shoah e alla lotta contro l’antisemitismo): «una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio verso gli ebrei. Le manifestazioni retoriche e fisiche dell’antisemitismo sono dirette verso persone ebree o non ebree e/o verso le loro proprietà, verso le istituzioni delle comunità ebraiche e i luoghi di culto». Anche i Länder sono stati coinvolti con misure coordinate. Purtroppo, non è tutto oro quel che luccica.
Monta la polemica sull’equilibrio tra sicurezza e libertà di espressione. Le università si dividono. Alcuni accademici paventano la «censura politica». Altri tacciono. O, peggio, simpatizzano.
Ecco il punto, signore e signori: non basta ripetere «Mai più». Non basta esibire la Shoah una volta l’anno se poi si accetta che nei cortei si bruci la bandiera di Israele e si acclami Hamas. La Germania ci prova. Con fatica, con incertezze, con errori – ma almeno ci prova. Noi, no.
In Germania la memoria non basta più In Germania la memoria non basta più In Germania la memoria non basta più