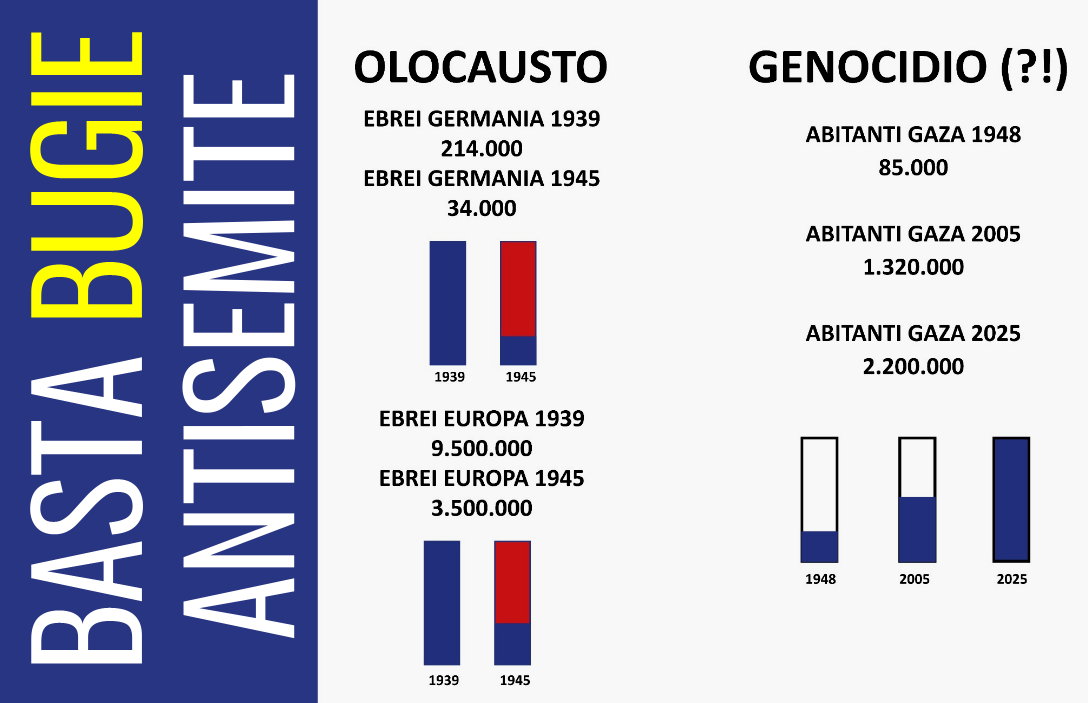Non sempre la sconfitta si vede. A volte indossa un abito tecnico, firma documenti con mano ferma e parla il linguaggio neutro delle ricostruzioni. È così che il Hamas, sconfitto militarmente ma non politicamente, si riaffaccia a Gaza: non più come milizia, ma come “consulente” nella formazione del governo che dovrebbe amministrare la Striscia nel dopoguerra.
Secondo rivelazioni della televisione israeliana Kan, l’organizzazione avrebbe scelto circa metà dei futuri membri del governo di tecnocrati, indicandoli tra personalità “civili” ma fedeli alla propria ideologia. L’altra metà, selezionata dall’Autorità Palestinese, è stata approvata con piena consapevolezza di questa interferenza. Tutto avviene sotto l’occhio complice dei mediatori arabi – in primo luogo l’Egitto – che hanno mostrato a Hamas la lista completa per garantirne il gradimento. È la formula perfetta per un ritorno senza bandiera: mantenere il potere, fingendo di averlo ceduto.
A Gerusalemme, la reazione è stata gelida. Israele chiede agli Stati Uniti di non avviare la ricostruzione finché Hamas non dimostrerà, con fatti concreti, la volontà di disarmarsi. Sul tavolo dei negoziati c’è la proposta americana di sigillare i tunnel sotterranei, iniziando da Rafah. Israele accetta, ma teme che mentre si chiude un tunnel sotto terra, se ne apra un altro sopra: quello politico.
Il ministro Zeev Elkin lo ha detto senza giri di parole: “Tutti a Gaza sostengono Hamas. Chi non lo fa, viene eliminato”. La frase, brutale ma realista, riassume la difficoltà di ogni progetto post-bellico che voglia distinguere tra popolazione e regime. Gaza non è solo un territorio devastato: è un’idea prigioniera di sé stessa.
Sul fronte diplomatico, il mosaico si complica. A Il Cairo si è appena concluso un incontro tra delegazioni di Israele, Egitto, Qatar e Turchia. L’obiettivo ufficiale è discutere la ricostruzione e l’eventuale dispiegamento di una forza internazionale. Ma dietro le quinte, il vero tema è la penetrazione di Ankara e Doha nella nuova architettura di Gaza. Entrambe si presentano come garanti di stabilità, ma Israele le considera due facce della stessa medaglia islamista.
Il piano in venti punti presentato da Donald Trump prevede una “forza di stabilizzazione internazionale” con partecipazione di Turchia, Indonesia, Azerbaigian e Pakistan. A Gerusalemme, però, Netanyahu ha già posto il veto: nessuna presenza turca o qatariota. “Giocano su due tavoli – ha dichiarato – uno umanitario e uno ideologico. Vogliono ricostruire Gaza, ma a modo loro.”
Washington, nel tentativo di rassicurare Israele, parla di presenza civile e di progetti economici, ma il sospetto resta. Non è solo questione di sicurezza, bensì di cornice interpretativa: chi costruirà Gaza, deciderà anche cosa Gaza diventerà. Se un laboratorio di convivenza o un protettorato travestito da rinascita.
La verità è che Hamas, lungi dall’essere smantellato, si sta riciclando nel linguaggio della governance. Non sventola più le bandiere verdi, ma siede dietro i dossier; non scava tunnel nel cemento, ma nelle istituzioni. È la sua specialità: perdere sul campo per vincere nei vuoti del potere.
Israele lo sa, ma si trova di fronte a un dilemma impossibile: come impedire che un nemico sconfitto diventi l’amministratore della sconfitta? La risposta, per ora, è un fragile equilibrio tra veto e tolleranza, tra la necessità di ricostruire e quella di non ricostruire il nemico.
E così Gaza, ancora una volta, si trasforma in un paradosso: la città che cade per rinascere, ma sempre sotto le stesse ombre.
Il ritorno invisibile del Hamas
Il ritorno invisibile del Hamas