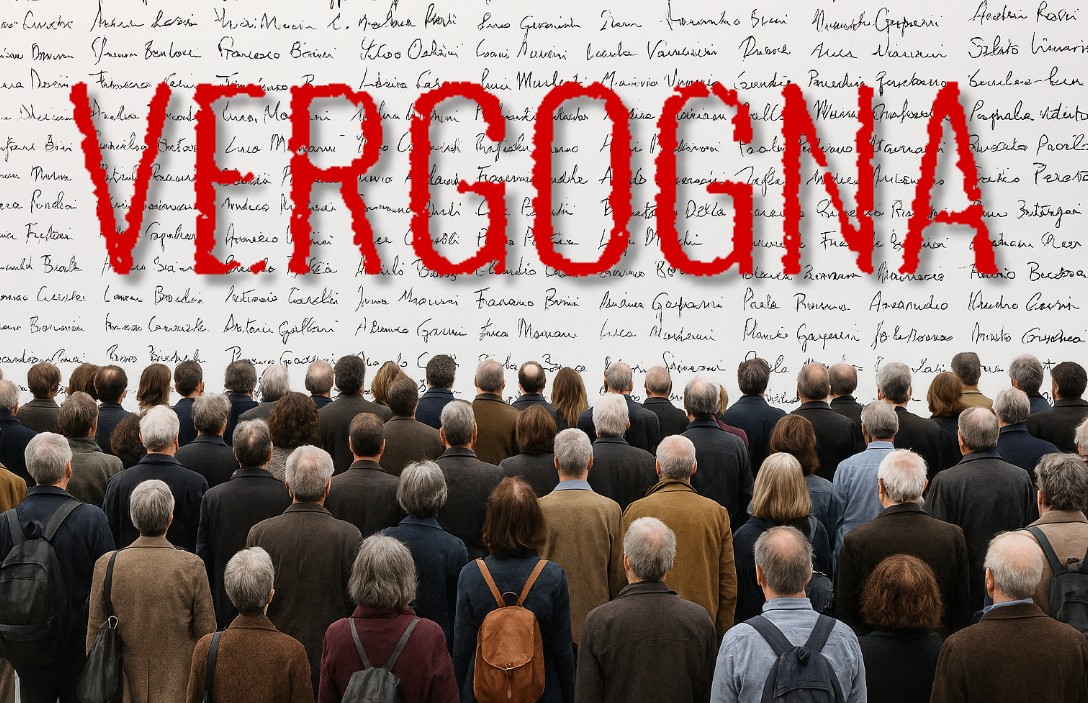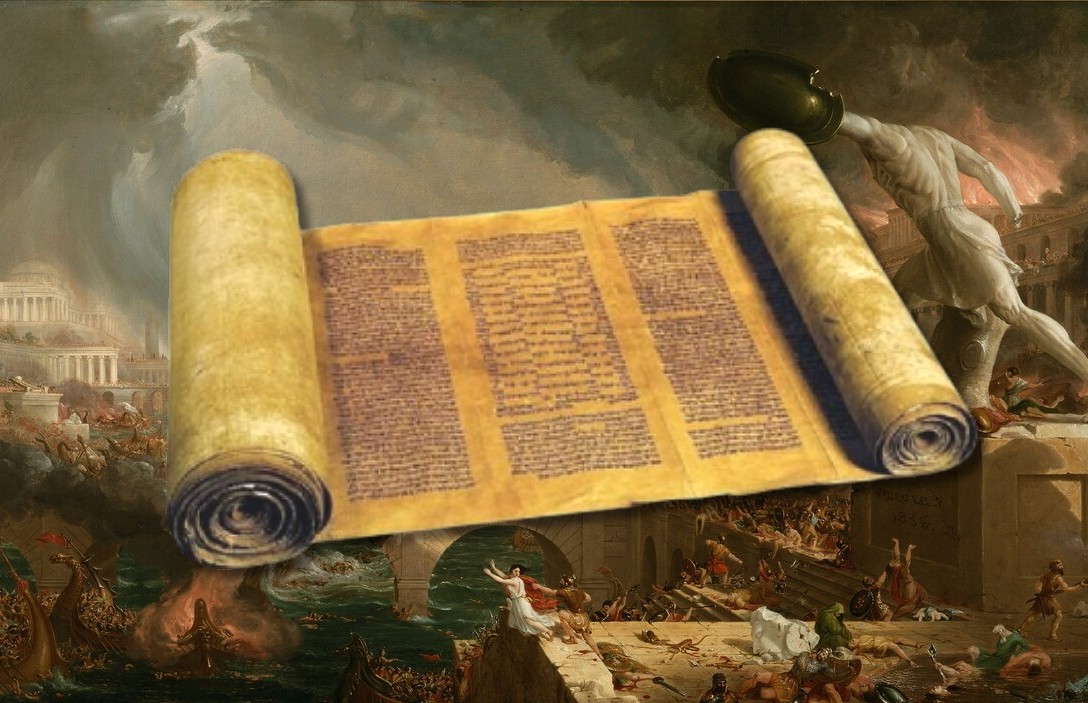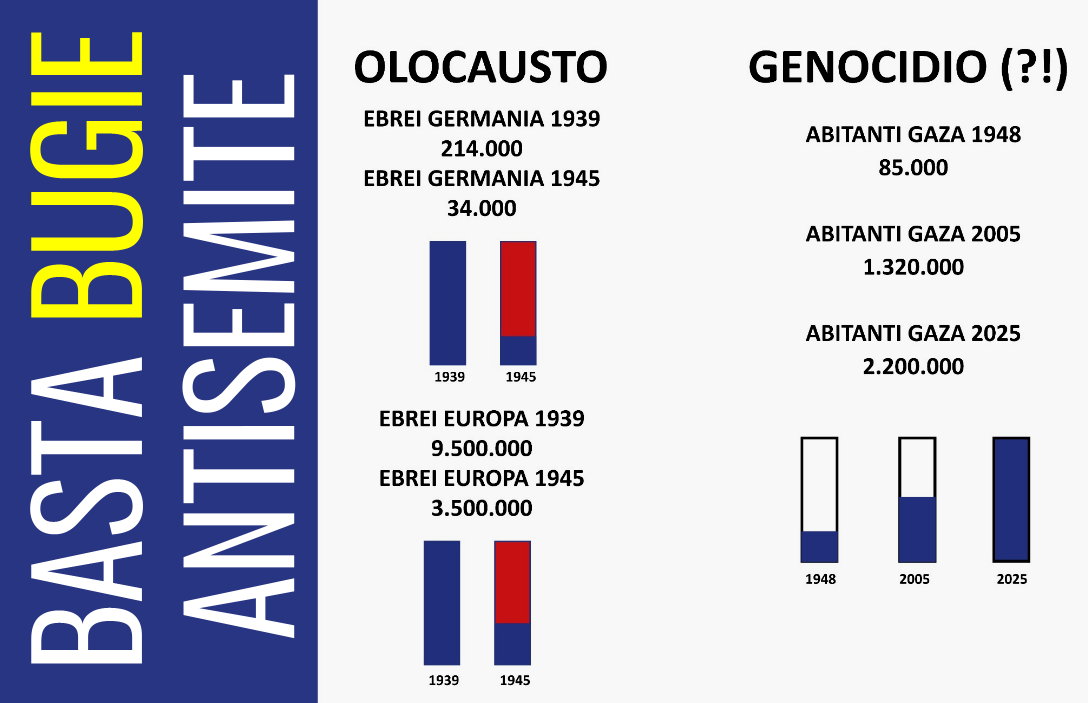Donald Trump l’ha annunciato con l’enfasi di un evento mondiale: «Il Kazakistan è il primo Paese del mio secondo mandato ad aderire agli Accordi di Abramo, il primo di molti». Una frase che suona come una promessa di rinascita diplomatica, ma che racconta più l’ambizione di Washington che una svolta geopolitica reale.
Il Kazakistan non è un Paese arabo, non ha mai avuto un conflitto con Israele e intrattiene con Tel Aviv relazioni ufficiali da oltre trent’anni. Già nel 1992, appena un anno dopo l’indipendenza dall’Unione Sovietica, i due Paesi avevano aperto ambasciate reciproche. Da allora hanno cooperato in campo tecnologico, agricolo e militare senza particolari attriti. L’adesione agli Accordi di Abramo non cancella quindi una distanza ma semmai la ridisegna, dandole un valore simbolico.
Per Trump, l’abbiamo imparto, il simbolismo è sostanza. Gli Accordi di Abramo — nati nel 2020 con Emirati, Bahrein, Marocco e Sudan — sono il lascito diplomatico con cui intende rivendicare una “pace economica” nel Medio Oriente e oltre. Aggiungere il Kazakistan serve a mostrare che il disegno è vivo, che la rete di alleanze fra Paesi musulmani e Israele può allargarsi ben oltre il Golfo. È la prova scenica di un’idea: quella di un mondo che si integra attorno a interessi comuni più che a identità religiose.
Astana, la capitale costruita praticamente da zero negli anni Novanta, da parte sua gioca una partita più concreta. Il Paese, grande otto volte l’Italia e ricco di petrolio, gas e metalli rari, cerca di uscire dalla dipendenza storica da Mosca e Pechino per avvicinarsi agli Stati Uniti. Nella stessa giornata dell’annuncio, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha firmato a Washington una serie di accordi economici da miliardi di dollari: estrazione di tungsteno con imprese americane, cooperazione energetica, accesso di Starlink al mercato kazako. Diplomazia e affari si intrecciano, come quasi sempre accade quando la parola “pace” viene tradotta in investimenti.
Il Kazakistan si presenta come un partner moderato, pragmatico, fedele alla propria tradizione di equilibri: mantiene rapporti con Russia, Cina, Occidente e mondo islamico. Non si schiera mai fino in fondo, ma si muove per convenienza calcolata. L’adesione agli Accordi è dunque la “naturale prosecuzione” — come recita il comunicato ufficiale — della sua politica estera multivettoriale. Un modo elegante per dire che Astana preferisce sedersi a più tavoli.
Dal punto di vista israeliano, la mossa vale un consolidamento. Netanyahu incassa un successo diplomatico a costo zero: un Paese musulmano che ribadisce pubblicamente il riconoscimento di Israele, in un momento in cui il conflitto con Hamas ha isolato Tel Aviv in molte capitali arabe. La notizia arriva come un balsamo politico, anche se privo di conseguenze immediate.
Sul piano internazionale, l’allargamento degli Accordi di Abramo serve soprattutto a ricostruire un’immagine di stabilità. Dopo gli anni della guerra a Gaza e le oscillazioni delle monarchie del Golfo, Washington tenta di rimettere in moto il meccanismo. Non è un caso che Trump abbia parlato di altri Paesi “in fila” per aderire. Ma l’effetto domino non è garantito. Le monarchie del Golfo restano caute, l’Arabia Saudita è ferma, e la questione palestinese continua a rendere fragile ogni retorica di “nuovo inizio”.
L’adesione del Kazakistan agli Accordi di Abramo è quindi un gesto utile, non storico. Rafforza legami già esistenti, apre canali economici, offre visibilità politica a tutti i protagonisti. Ma non cambia la mappa del Medio Oriente né sposta l’asse delle alleanze globali. È un episodio di diplomazia post-moderna: molto storytelling, poca sorpresa.
Nel 2020 gli Accordi promettevano di inaugurare un’era di normalizzazione fra Israele e il mondo arabo. Cinque anni dopo, la normalizzazione riguarda soprattutto il linguaggio con cui si confeziona la politica estera: dichiarazioni solenni, loghi dorati, firme cerimoniali. In questo senso, il Kazakistan ha compreso perfettamente lo spirito del tempo. Entrare in un club prestigioso costa poco e rende molto. Anche se, come accade nei club veri, l’importante non è tanto ciò che si discute dentro, ma chi guarda da fuori.
Il Kazakistan entra negli Accordi di Abramo: una mossa più utile che storica
Il Kazakistan entra negli Accordi di Abramo: una mossa più utile che storica