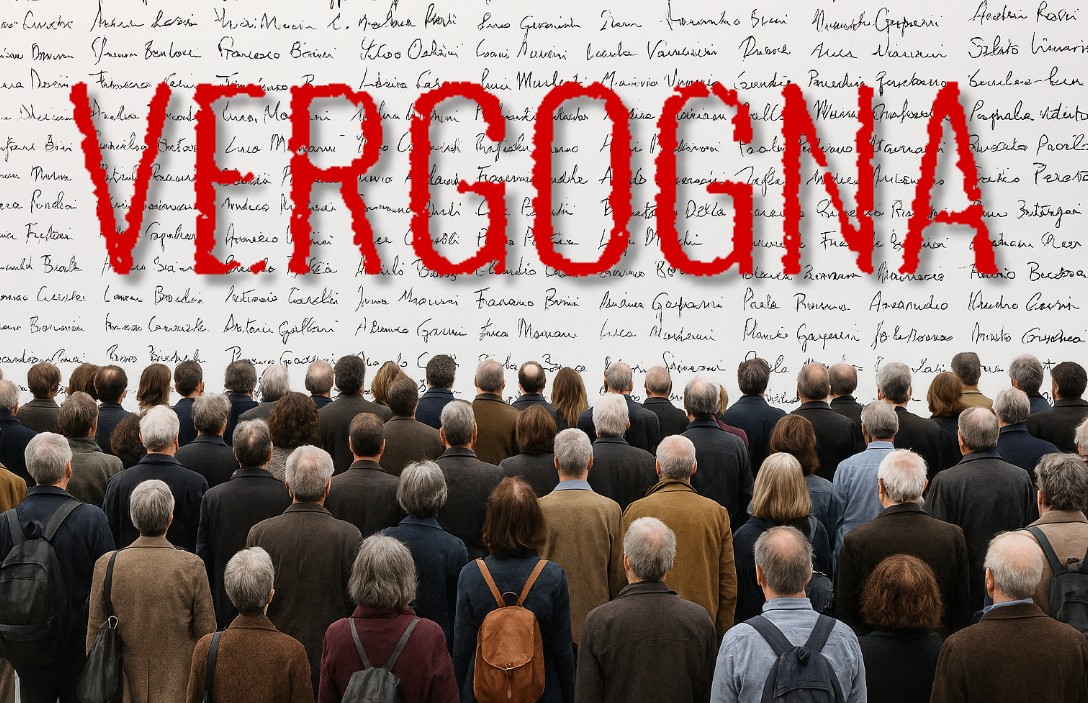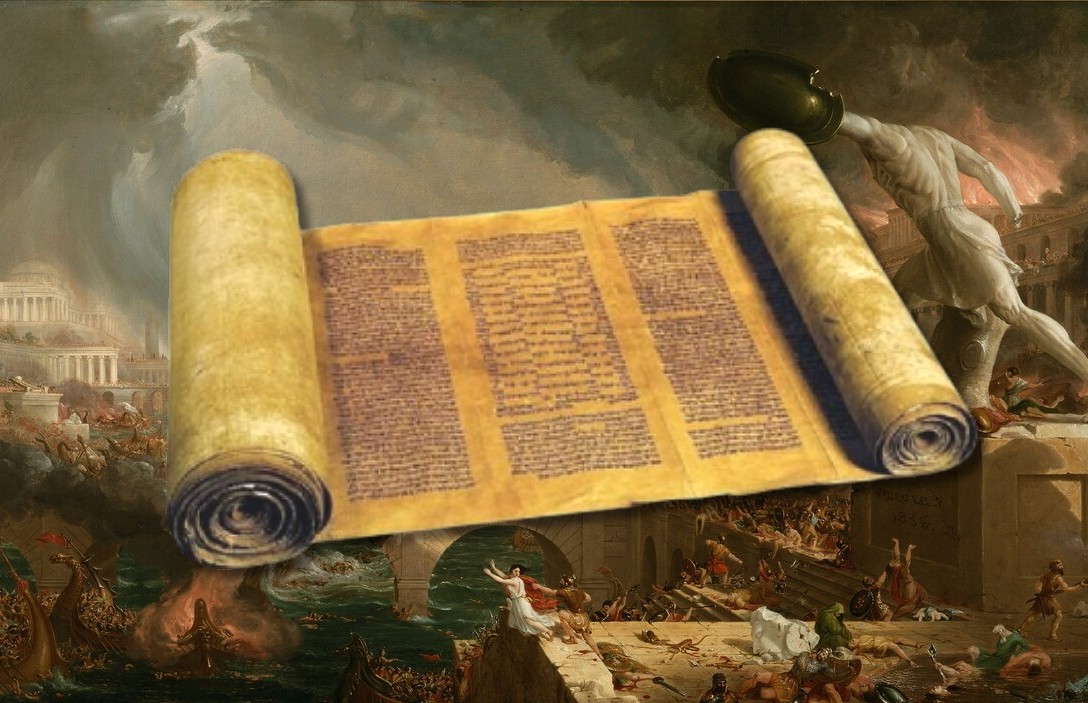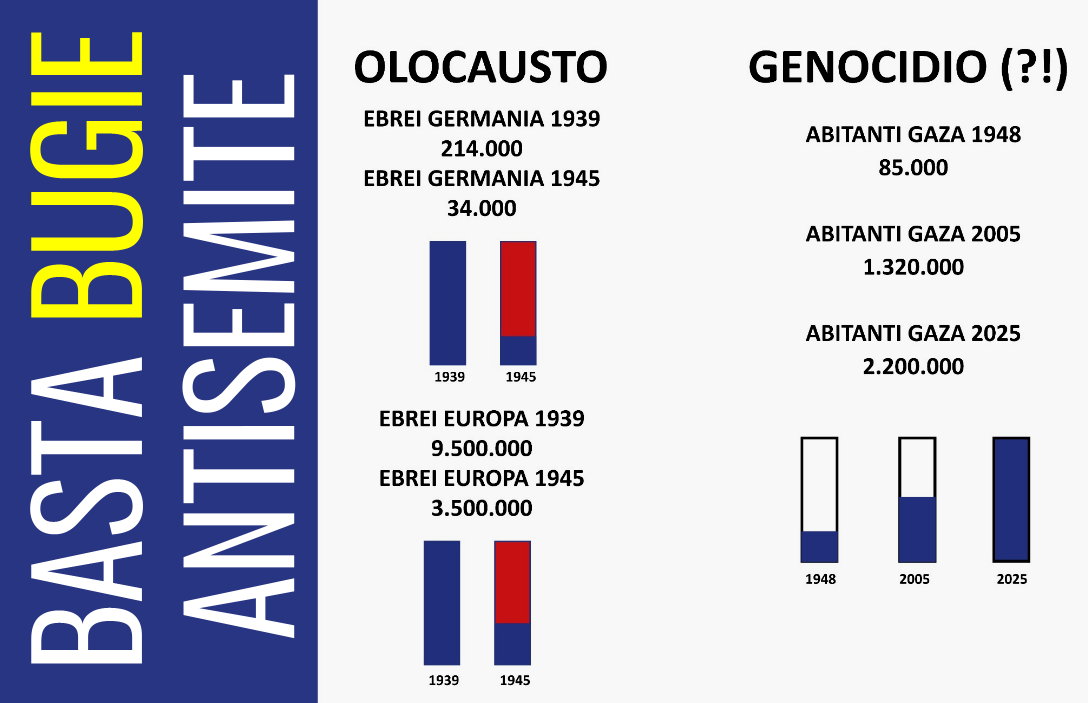Nell’epoca dei discorsi sulla decolonizzazione, in cui ogni pietra viene sollevata alla ricerca di ingiustizie passate, è sorprendente – se non sospetto – che il colonialismo arabo resti uno dei grandi tabù della storiografia contemporanea. Mentre l’imperialismo occidentale viene analizzato con fervore morale nelle aule universitarie da Londra a Berkeley, l’enorme e duraturo lascito delle conquiste arabe, della dominazione culturale e dell’assimilazione forzata viene accolto con silenzio – o, peggio, con giustificazioni camuffate da «complessità storica».
Perché? Perché il paradigma accademico dominante, plasmato da decenni di teoria postcoloniale, ha costruito un binomio semplicistico: colonizzatore = bianco europeo; colonizzato = tutti gli altri. Questo schema rigido non lascia spazio a verità scomode, come l’espansione imperiale arabo-islamica che, a partire dal VII secolo, travolse il Medio Oriente, il Nord Africa e parte dell’Asia e dell’Europa, lasciandoci oggi con 57 paesi islamici, di cui ben 22 sono definibili come arabi. In questa narrazione edulcorata, le conquiste arabe vengono reinterpretate come risvegli spirituali, movimenti di liberazione o eventi storici “naturali” – e non per ciò che furono spesso in realtà: atti di aggressione imperiale e soppressione culturale.
Diciamolo chiaramente: il colonialismo arabo è un fatto reale. Gli eserciti arabo-musulmani che uscirono dalla Penisola Arabica conquistarono le terre dei persiani, dei bizantini, dei berberi, degli assiri, dei nubiani e di molti altri popoli. Non si trattava di «terre arabe», ma di territori con lingue, religioni e civiltà proprie. Col tempo, sotto la bandiera dell’Islam e imposta tramite la lingua e la legge araba, queste popolazioni furono progressivamente arabizzate – talvolta con la spada, più spesso attraverso coercizione sistemica. Lingue indigene come il copto, l’aramaico e il berbero vennero marginalizzate o ridotte quasi all’estinzione. Non fu un «incontro di civiltà», ma una deliberata cancellazione culturale.
Le conseguenze di questo lascito coloniale sono visibili ancora oggi. Lo sanno bene gli amazigh del Maghreb, ancora in lotta per il riconoscimento della propria lingua. Lo sanno i copti d’Egitto, trattati come cittadini di serie B nella loro stessa patria ancestrale. Lo sanno gli assiri di Iraq e Siria, le cui chiese e villaggi stanno scomparendo sotto il peso dell’estremismo islamico e del nazionalismo arabo. Eppure, queste voci faticano a trovare spazio nei circoli accademici occidentali, dove l’identità araba è troppo spesso trattata come indigena e immutabile in tutto il Medio Oriente. Mettere in discussione questa ortodossia equivale a esporsi all’accusa di essere orientalisti, islamofobi o, peggio ancora, eretici rispetto ai dogmi della teoria postcoloniale.
Ancora più preoccupante è come questa cecità selettiva distorca la narrazione storica del popolo ebraico. Gli ebrei sono tra i pochi popoli indigeni del Medio Oriente che hanno mantenuto la propria identità, lingua e continuità nonostante secoli di conquiste arabe e islamiche. Eppure, il ritorno degli ebrei nella loro terra ancestrale viene spesso bollato nei circoli accademici come «colonialismo d’insediamento» – un’inversione orwelliana resa possibile solo negando la storia del colonialismo arabo e l’indigenità ebraica.
A rendere tutto ancora più assurdo è l’uso ossessivo e ideologico del termine «Palestina» come unico nome legittimo per descrivere la terra storica di Israele e Giudea. In qualsiasi altro contesto accademico, sarebbe impensabile riferirsi all’intero continente americano ignorando completamente le nazioni native – Cherokee, Navajo, Lakota, Quechua, Mapuche – parlando solo di «America» come se fosse un’entità naturale e originaria. Eppure, questo è esattamente ciò che avviene con Israele: si cancella il nome storico della patria ebraica, si demonizza chi lo riutilizza e si impone il toponimo dato dai colonizzatori romani – Palæstina, un termine creato per cancellare ogni traccia dell’identità giudaica dopo la rivolta di Bar Kokhba. È l’equivalente simbolico di chiamare gli Stati Uniti «Nuova Britannia» e sostenere che i nativi non ci siano mai stati.
La verità è semplice ma scomoda: il mondo arabo, così come lo conosciamo oggi, è in larga parte il prodotto di conquiste imperiali e assimilazione culturale, non di una continuità antica e immutabile. Riconoscerlo non significa negare la ricchezza della civiltà araba, ma contestualizzarla storicamente e sottoporla allo stesso scrutinio critico riservato a tutti gli altri imperi. È tempo dunque di abbattere i totem della teoria postcoloniale. Una vera decolonizzazione richiede di confrontarsi con tutte le forme di imperialismo – non solo quelle che si adattano a una narrazione ideologica preconfezionata.
Le conquiste arabo-islamiche vanno studiate per quello che furono: un’imponente trasformazione storica, realizzata attraverso il potere, la violenza e la cancellazione dell’altro. Finché il mondo accademico non troverà il coraggio di affrontare questa realtà, rimarrà complice di un doppio standard che perpetua l’amnesia storica e l’incoerenza morale. In nome della giustizia, della verità e dell’onestà intellettuale, il silenzio deve finire.
Il colonialismo arabo: la storia rimossa dall’accademia Il colonialismo arabo: la storia rimossa dall’accademia
Il colonialismo arabo: la storia rimossa dall’accademia