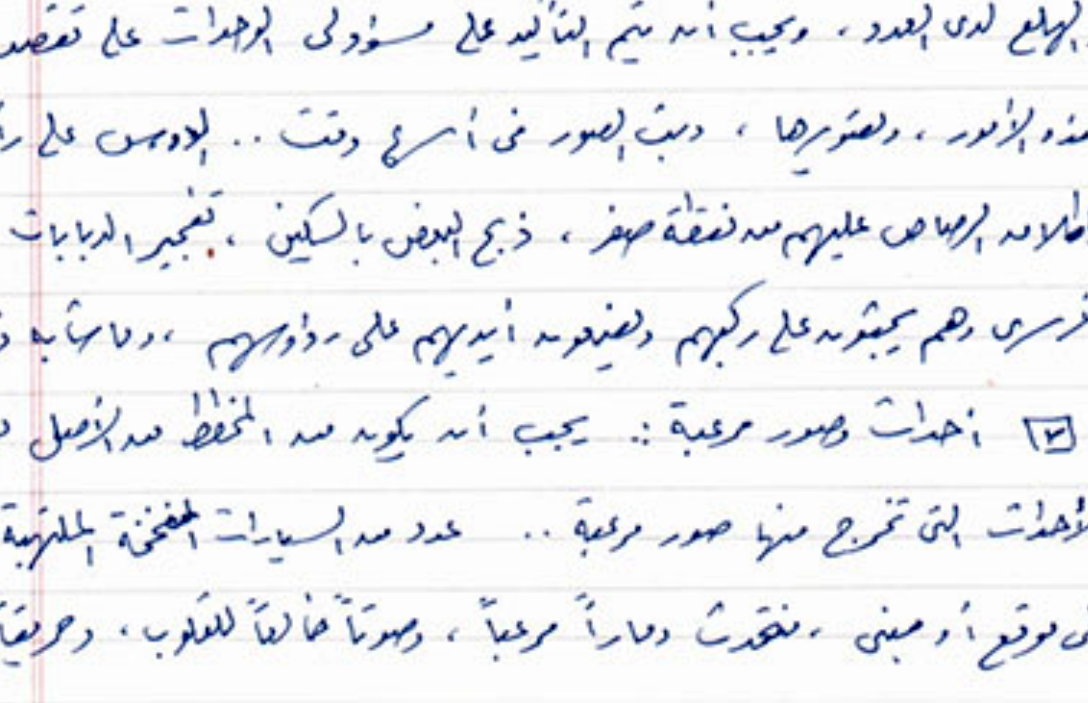Francesca Albanese dichiara che si pente solo di quel che ha detto a Reggio Emilia, quando ha svillaneggiato il sindaco che la premiava con la cittadinanza onoraria (e che, solo per questo, meritava qualcosa di più di una villania). Il fatto vero è che c’è un paradosso che attraversa le Nazioni Unite: gli incarichi nati per difendere i diritti umani spesso finiscono per calpestarli. È il caso della signora Albanese, fino ad aprile 2025 relatrice speciale dell’ONU sulla situazione nei Territori palestinesi, che ora inizia il suo tour – immaginiamo virtuale – per pubblicizzare le sue memorie poco memorabili. Gli è che il suo mandato, formalmente indipendente, si è trasformato in un pulpito ideologico e in una vicenda di finanziamenti opachi che, secondo il rapporto di UN Watch, coinvolge lo stesso apparato delle Nazioni Unite in un sistematico insabbiamento.
Il documento di 80 pagine pubblicato dall’organizzazione con sede a Ginevra è devastante. Ricostruisce, con prove documentali, come Albanese abbia accettato fondi e ospitalità da gruppi di pressione filo-Hamas durante una tournée in Australia e Nuova Zelanda nel novembre 2023. Viaggi, conferenze, incontri politici, perfino una lezione in memoria di Edward Said, tutto pagato — o «sponsorizzato», come scrivono loro stessi — da organizzazioni che non si limitano a simpatizzare per la causa palestinese, ma che hanno pubblicamente giustificato il massacro del 7 ottobre come «atto di resistenza».
L’ONU, invece di prendere le distanze o aprire un’inchiesta indipendente, ha scelto la strada più antica: negare, minimizzare, coprire. Prima Albanese, poi il suo ufficio e infine l’Alto Commissariato per i diritti umani hanno sostenuto che la missione fosse interamente finanziata dalle casse di Ginevra. Peccato che lo stesso comitato interno incaricato di «verificare» la vicenda — formato da colleghi e amici della relatrice — abbia dovuto ammettere l’esistenza di «fondi esterni parziali». In altre parole: le spese interne in Australia e Nuova Zelanda furono pagate, almeno in parte, da organizzazioni di propaganda anti-israeliana.
Il risultato? Una lettera ufficiale di assoluzione, firmata in marzo 2025, che ribalta la realtà. Pur riconoscendo «potenziali conflitti d’interesse» e un «uso inappropriato dell’onorario» chiesto per la sua assistente, il comitato dichiara Albanese «pienamente conforme» al codice di condotta. Una sorta di autocertificazione etica. Tutto questo, mentre cinque governi — Stati Uniti, Israele, Argentina, Paesi Bassi e Ungheria — protestavano contro la sua riconferma.
Le contraddizioni sono a dir poco grottesche. Il viaggio non compare tra le missioni ufficiali del 2023, ma l’ONU ne ha comunque rimborsato parte delle spese. Le associazioni che l’hanno invitata — AFOPA, APAN, Free Palestine Melbourne, tra le altre — hanno ringraziato pubblicamente per la «collaborazione». Eppure per mesi il portavoce del Segretario generale, Farhan Haq, ha ripetuto che «il Segretariato non ha alcun ruolo» nei viaggi dei relatori. Una bugia, visto che è proprio l’Alto Commissariato a gestire e approvare i fondi.
In controluce, emerge un meccanismo di mutua protezione: Albanese mente, il suo ufficio copre, il Segretariato conferma, e il sistema si chiude su sé stesso. Quando UN Watch presenta le prove, l’ONU le affida alla stessa commissione che aveva già difeso la relatrice dagli «attacchi personali». Un giudice che giudica sé stesso.
Albanese non è nuova alle polemiche. In passato aveva definito «inesistente» il diritto di Israele all’autodifesa e aveva accusato i governi occidentali di «sottomissione alla lobby ebraica». Eppure è rimasta al suo posto fino al termine del mandato, protetta da un’istituzione che ormai sembra più preoccupata di tutelare la propria immagine che i principi che proclama.
Il caso va oltre la sua figura dimostrando quanto sia fragile l’indipendenza dei «rapporteurs» ONU e quanto il sistema multilaterale sia vulnerabile alle pressioni ideologiche e finanziarie. Se l’ONU può chiudere un occhio su un conflitto d’interessi tanto evidente, allora la credibilità stessa del suo impianto di tutela dei diritti umani è compromessa.
Francesca Albanese ha detto: «Non ho nulla da nascondere». Il rapporto di UN Watch dimostra il contrario. Ma il vero scandalo non è lei. È l’istituzione che, pur di non ammettere il proprio fallimento, ha scelto di coprirla.
Il caso Francesca Albanese e il silenzio dell’ONU
Il caso Francesca Albanese e il silenzio dell’ONU