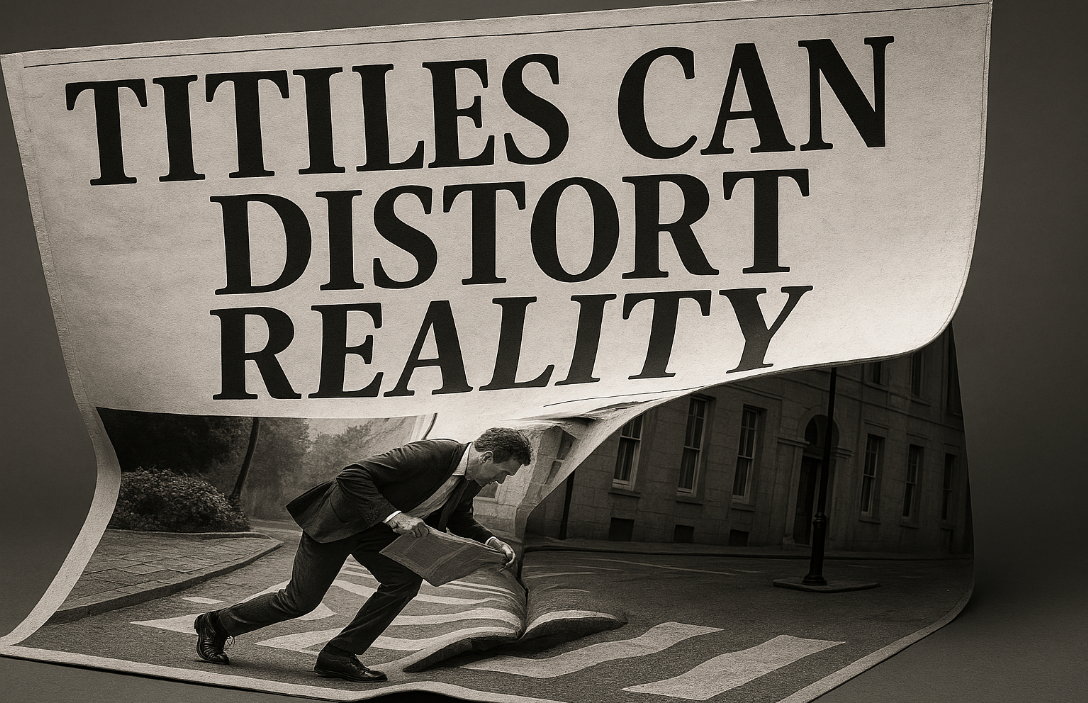C’è un punto, nelle guerre lunghe e ideologiche, in cui la retorica si sfalda e resta soltanto la materia grezza dei fatti, insieme alla voce di chi ha vissuto dall’interno ciò che per anni è stato raccontato come destino, necessità, sacrificio. L’intervista rilasciata a N12 da Hamza Mahra, ex membro delle unità Nukhba di Hamas e nipote di uno dei fondatori dell’organizzazione, appartiene a questa categoria scomoda e per questo rivelatrice. Non siamo di fronte a un’abiura spettacolare néa una confessione costruita per il pubblico occidentale, ma a un racconto lineare e duro di una disillusione maturata nel tempo, dentro Gaza, dentro Khan Yunis, nel cuore stesso di quella struttura che per decenni ha preteso di incarnare la resistenza.
Mahra non parla come un uomo sconfitto, bensì come qualcuno che ha smesso di credere a un sistema che prometteva dignità e ha prodotto macerie, prometteva protezione e ha lasciato i civili esposti a ogni rappresaglia possibile. Quando dice che l’ideologia di Hamas è falsa, non sta facendo un’operazione teorica, bensì una constatazione pratica, nata dall’osservazione quotidiana di una leadership che, a suo giudizio, ha trasformato la vita dei palestinesi in una moneta di scambio, utile solo a perpetuare il proprio potere.
Il passaggio più destabilizzante riguarda il 7 ottobre, definito senza ambiguità un errore devastante. Non un atto eroico mal riuscito, non una risposta sproporzionata a un’ingiustizia, ma una scelta che ha riportato Gaza indietro di decenni, cancellando in poche ore ciò che era stato costruito con fatica in anni di lavoro e adattamento. In quelle parole non c’è indulgenza né tentativo di giustificazione, bensì la consapevolezza che l’azione armata, sganciata da qualsiasi responsabilità verso la popolazione, diventa una forma di autodistruzione collettiva.
Il fatto che Mahra abbia deciso di unirsi alla milizia di Hussam al-Astal, collaborando con Israele, segna un ulteriore scarto rispetto alla grammatica tradizionale del conflitto. Qui non siamo davanti a un riposizionamento tattico, ma a una rottura simbolica, perché implica il riconoscimento che il nemico assoluto, così come è stato insegnato per generazioni, non esiste nella forma semplificata proposta dall’indottrinamento. Israele, in questo racconto, smette di essere un’entità astratta e diventa un interlocutore con cui, per quanto difficile, è necessario fare i conti se l’obiettivo è la sopravvivenza dei civili e non la glorificazione della morte.
Colpisce anche l’assenza di timore dichiarata nei confronti di Hamas. Mahra sa bene cosa rischia, conosce i metodi, le ritorsioni, il prezzo che viene imposto a chi rompe la disciplina, e tuttavia rivendica il diritto di vivere una vita normale, sottraendosi alla catena familiare e ideologica che avrebbe dovuto determinarne il destino. In questo rifiuto dell’eredità, più che in qualsiasi slogan, si intravede la crepa più profonda nel sistema: quando i figli e i nipoti dei fondatori iniziano a considerare quell’eredità come un peso e non come un onore, qualcosa si è irrimediabilmente incrinato.
Questa testimonianza non risolve il conflitto, né pretende di farlo, ma costringe a guardare Hamas per ciò che è diventata agli occhi di una parte dei suoi stessi uomini, ovvero un apparato che divora le energie della società che dice di difendere. Ed è proprio per questo che risulta intollerabile per chi continua a raccontare Gaza come un blocco monolitico, privo di dissenso interno e di conflitti reali. La voce di Hamza Mahra, piaccia o no, ricorda che anche lì esistono scelte, fratture, risvegli tardivi, e che la pace, per quanto lontana, comincia spesso da una diserzione.