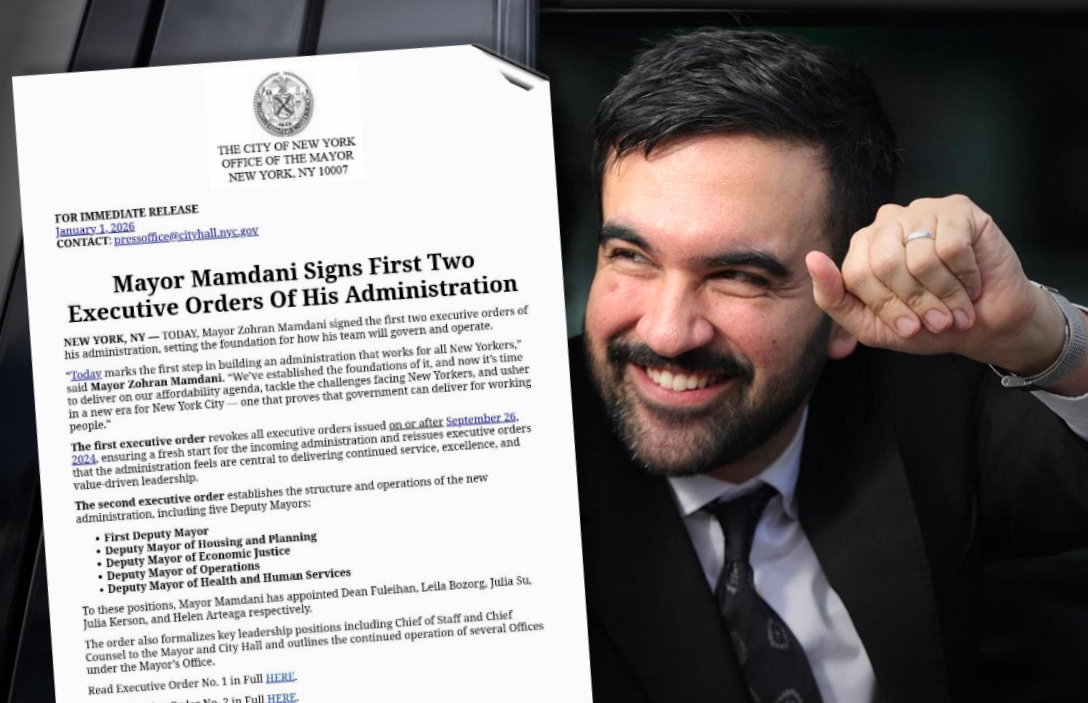La Germania Ovest del dopoguerra amava raccontarsi come un Paese rifondato: democrazia nuova, Costituzione solida, crescita economica, riconciliazione con l’Occidente e perfino con Israele. Tutto vero, in parte. Ma dentro il cuore dell’esecutivo, la Cancelleria federale, la ripartenza fu spesso più continuità che rottura. Una ricerca basata sui fascicoli del personale lo fotografa con una cifra che parla da sola: nel primo decennio della Repubblica Federale, tra gli assunti fino al 1958, circa due terzi erano stati iscritti al partito nazista; e una quota significativa era passata anche da organizzazioni del sistema, dalle formazioni paramilitari a corpi e strutture collaterali.
Il punto non è la scoperta che “in Germania c’erano ex nazisti”, cosa per altro nota da decenni. Il punto è il luogo e il momento. Parliamo della stanza dei bottoni proprio negli anni in cui si fissavano i riflessi della nuova democrazia occidentale. E parliamo di profili che non erano soltanto opportunisti che si erano adeguati per fare carriera, ma giuristi coinvolti nell’applicazione delle leggi razziali, amministratori passati da uffici che avevano gestito l’esproprio dei beni ebraici, uomini della propaganda, giornalisti e autori che avevano lavorato nel perimetro del ministero di Goebbels. La normalità del dopoguerra, insomma, si costruì anche con persone che avevano contribuito a rendere “normale” l’abisso.
Il caso simbolo resta Hans Globke, per un decennio braccio destro di Konrad Adenauer e snodo decisivo del reclutamento nella Cancelleria. Nel Reich era stato un tecnico del diritto: commentari, decreti, definizioni. Proprio quella specializzazione rese la persecuzione efficiente: categorie chiare, vittime identificabili, burocrazia che non inceppa. Globke contribuì alla norma che obbligò gli ebrei ad aggiungere i nomi “Israel” o “Sara” ai documenti e aiutò a far circolare, in Germania e fuori, le regole razziali come se fossero semplice amministrazione. A fianco di lui emergono figure meno note ma ugualmente rivelatrici: funzionari dell’economia e della finanza passati dai territori occupati, dove saccheggio e lavoro forzato non erano incidenti ma metodo.
Perché fu possibile? La risposta ufficiale è il pragmatismo: servivano quadri esperti, l’amministrazione doveva reggere, lo Stato doveva funzionare subito. Adenauer, paradossalmente vittima dei nazisti, volle chiudere in fretta la stagione della denazificazione e reintegrare molti apparati, riservando la severità ai casi più ingombranti. Sullo sfondo, la Guerra fredda fece il resto: l’anticomunismo diventò una passerella morale su cui far rientrare anche profili con un passato pesantissimo, purché “affidabili” e utili alla stabilizzazione del nuovo Stato.
La parte più rivelatrice, però, è l’ossessione per l’immagine. Ufficio stampa e ambasciate monitoravano film e programmi che mostravano i tedeschi come aggressori e difendevano con testardaggine il mito della Wehrmacht “pulita”. La memoria non era ancora la storia delle vittime: era una faccenda di reputazione nazionale, di come apparire nel pieno della ricostruzione e dell’integrazione euro-atlantica. In quel riflesso di difesa riaffioravano anche veleni antichi: il fastidio per chi ricordava le colpe e l’istinto di scaricare altrove la responsabilità del “cattivo” racconto della guerra e dello sterminio.
Una democrazia può nascere anche attraverso compromessi a patto che le regole siano forti e i controlli reali. Ma il prezzo resta alto perché ritarda la presa di coscienza, normalizza l’impunità ed educa una società all’idea che tutto sia negoziabile in nome della stabilità. E quando, anni dopo, la Germania comincerà davvero a guardarsi allo specchio, scoprirà che quello specchio era stato appeso, per un tratto, proprio da mani che avevano imparato a far finta di niente.
Germania, anno zero. Nazisti al governo, subito
Germania, anno zero. Nazisti al governo, subito