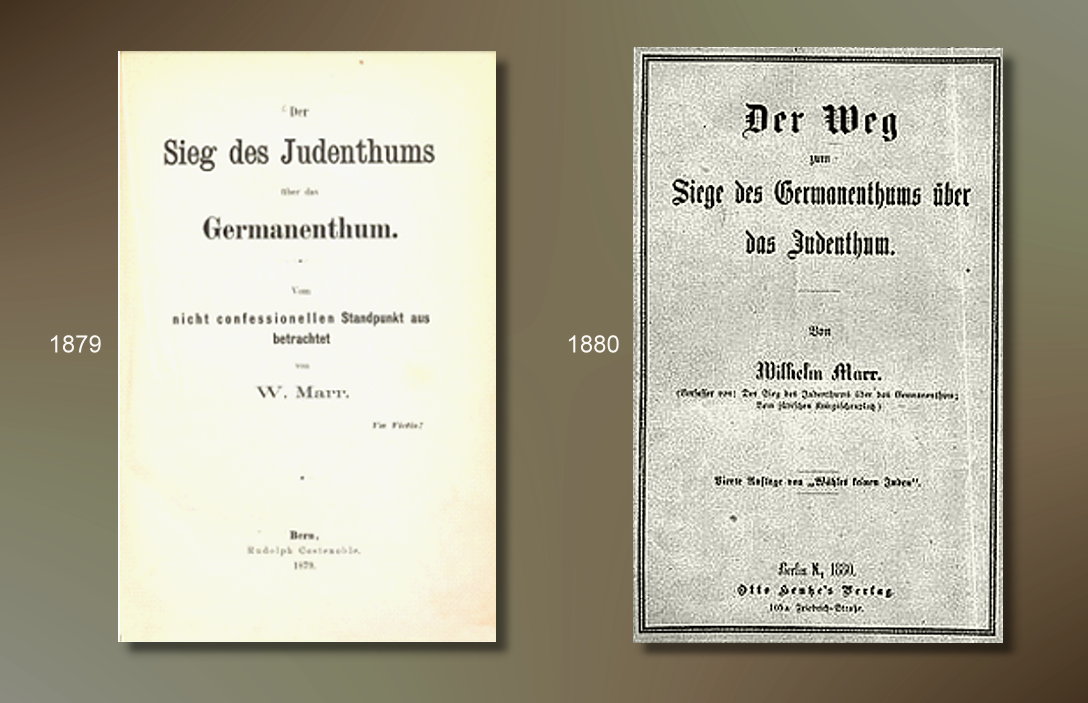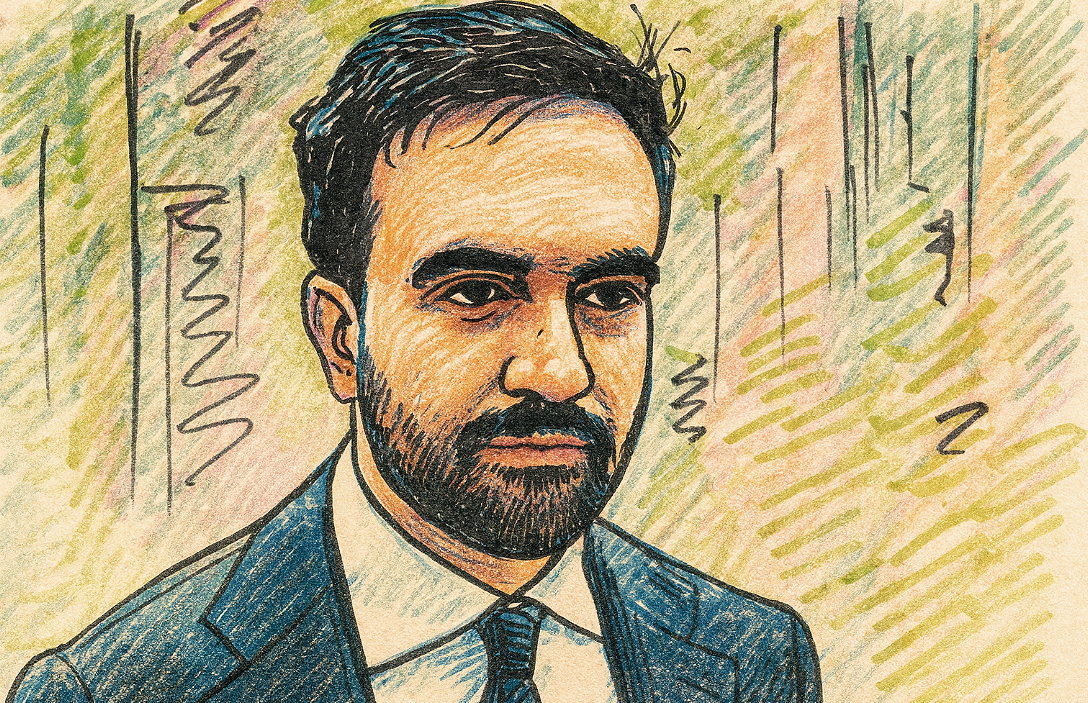«Non è il diritto internazionale a essere sotto attacco. È chi cerca di manipolarlo a metterne in discussione la credibilità. E non sono i diritti umani a essere minacciati, bensì la loro trasformazione in uno strumento ideologico selettivo da parte di chi li usa come arma politica». La figura di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, rappresenta oggi una delle espressioni più pericolose di questa deriva.
Il suo mandato, definito formalmente dalle Nazioni Unite, è chiaro: documentare le violazioni dei diritti umani all’interno dei territori palestinesi occupati dal 1967, da parte di attori statali e non statali. Tutti. Non solo uno. Una funzione che, per essere esercitata con autorevolezza, richiede rigore, imparzialità e un uso responsabile della propria posizione. Albanese, invece, ha scelto sistematicamente di oltrepassare questi confini, svolgendo un’attività che somiglia più a quella di una militante politica che non a quella di una funzionaria internazionale.
Non esiste, a oggi, un singolo documento ufficiale da lei prodotto che condanni in modo chiaro e inequivocabile le atrocità commesse da Hamas, a partire dal 7 ottobre 2023. Gli stupri, i rapimenti, l’uccisione deliberata di civili israeliani, l’uso di bambini palestinesi come scudi umani: ignorati, minimizzati o trattati con distacco. Albanese ne ha parlato solo in margine, in interviste come quella rilasciata a «The Guardian» o attraverso i suoi canali social. Mai con una posizione ufficiale e netta, come il suo incarico richiederebbe. Ha scelto, consapevolmente, di non scrivere una sola riga su bambini israeliani bruciati vivi, sugli ostaggi, sulle famiglie spezzate. Quel silenzio equivale a una presa di posizione.
Nel frattempo, ha trovato il tempo di redigere il famigerato rapporto A/HRC/59/23, in cui accusa oltre sessanta aziende di «complicità economica» con l’occupazione israeliana. Un’accusa basata non su prove o giudizi legali, ma su un ragionamento ideologico che associa genericamente la fornitura di tecnologie o mezzi a una responsabilità diretta per le azioni dello Stato israeliano. Il rapporto non cita violazioni specifiche, non produce prove documentali, né si fonda su strumenti giuridici come lo Statuto di Roma, le Convenzioni di Ginevra o i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani. Nessun contraddittorio. Nessuna notifica preventiva alle aziende. In ambito giuridico, si parlerebbe di violazione della «due diligence» procedurale. In ambito politico, di abuso di mandato.
Il linguaggio usato è rivelatore: «profitti sulla distruzione di vite innocenti», imprese che «alimentano l’impresa della depredazione e della discriminazione», aziende che «favoriscono violazioni del diritto internazionale». Espressioni gravi, senza riscontri tecnici né sentenze. Non è il linguaggio di una relatrice speciale, ma di un’attivista.
Così facendo, Albanese ha violato il Codice di Condotta delle Nazioni Unite per i titolari di mandati speciali, che impone neutralità, rispetto dei limiti territoriali e tematici del mandato, divieto di commenti personali non supportati da sentenze o prove, e obbligo di imparzialità. Albanese ha ignorato tutto ciò. Ha commentato eventi fuori dal suo ambito, espresso giudizi politici senza basi, ignorato Hamas (che rientra nel suo mandato). Ha agito come parte in causa. Mai prima d’ora un relatore speciale ONU aveva redatto un rapporto simile o ricevuto sanzioni formali da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza.
Le sanzioni degli Stati Uniti, decise dal Dipartimento di Stato con il sostegno bipartisan del Congresso, non sono un attacco al diritto internazionale, come affermano le cheerleader pro-Palestina. Sono il segnale concreto della crescente preoccupazione per la politicizzazione del sistema ONU. E l’organizzazione, pur senza rimuoverla, ha scelto di non difenderla. Il silenzio dell’ONU è imbarazzato, non solidale.
E l’Italia? L’Italia tace. Nessuna nota ufficiale, nessuna presa di distanza, nessuna perplessità. Eppure, si tratta di una cittadina italiana che utilizza un incarico internazionale per portare avanti una campagna ideologica unilaterale. Il governo italiano dovrebbe essere il primo a pretendere rispetto del mandato, a difendere la credibilità delle istituzioni multilaterali, a segnalare le gravi irregolarità. Invece resta in silenzio. Un silenzio che suona come imbarazzo istituzionale.
Da parte della sinistra italiana più ideologica c’è chi vorrebbe addirittura un intervento a difesa di Albanese. Per costoro, la critica statunitense a una cittadina italiana andrebbe affrontata con patriottismo. Ma questa è una visione distorta: non si tratta di difendere una persona, ma di valutare il comportamento di una funzionaria. Se ha tradito il principio di imparzialità, va richiamata, non protetta. Il patriottismo istituzionale non è cieca solidarietà, ma capacità di distinguere chi onora il Paese da chi lo espone al ridicolo.
Non si difendono i diritti umani proteggendo chi li strumentalizza. Non si tutela il diritto internazionale sostenendo chi lo piega a fini politici. L’Italia dovrebbe unirsi alla richiesta di revisione del mandato della relatrice, se non della sua rimozione. Per la giustizia, non per la geopolitica. Perché chi ricopre incarichi internazionali deve rappresentare il diritto, non ideologie personali.
Oggi Francesca Albanese è una figura divisiva, ideologica, tossica. Ha scelto di bruciarsi con le sue stesse parole e omissioni. L’Italia non può restare spettatrice. Questa pagina si può chiudere in un solo modo: Francesca Albanese deve lasciare l’incarico, prima di causare ulteriori danni alla credibilità delle istituzioni e del Paese che porta il suo nome.
Francesca Albanese, la relatrice ONU diventata megafono ideologico. E l’Italia tace Francesca Albanese, la relatrice ONU diventata megafono ideologico. E l’Italia tace Francesca Albanese, la relatrice ONU diventata megafono ideologico. E l’Italia tace