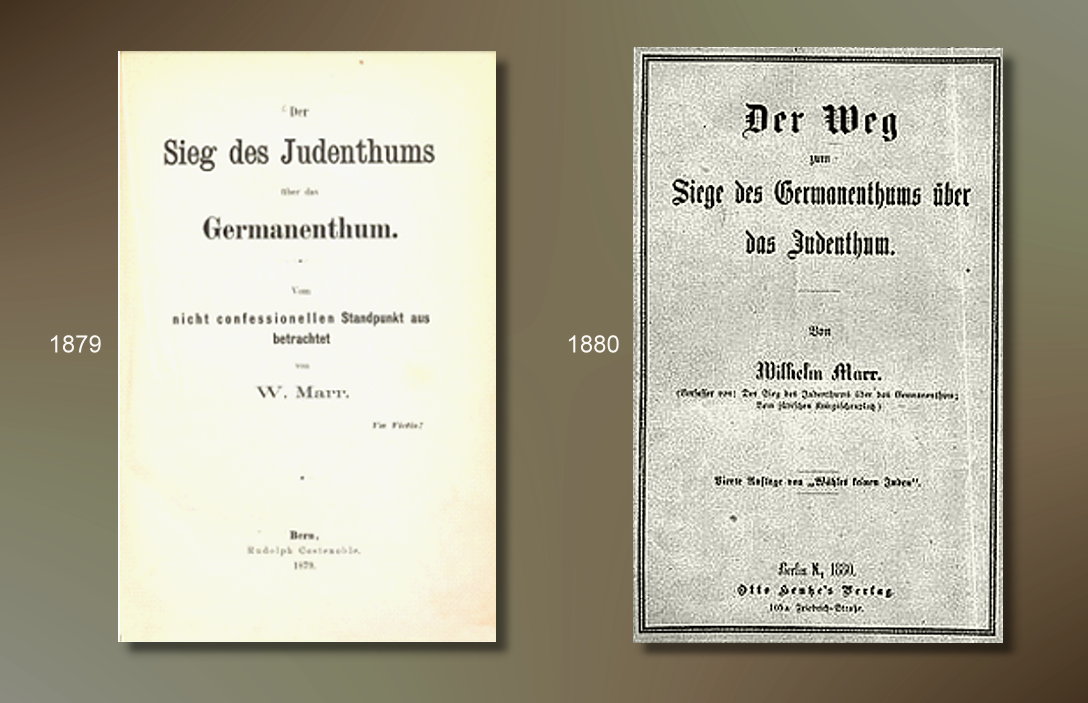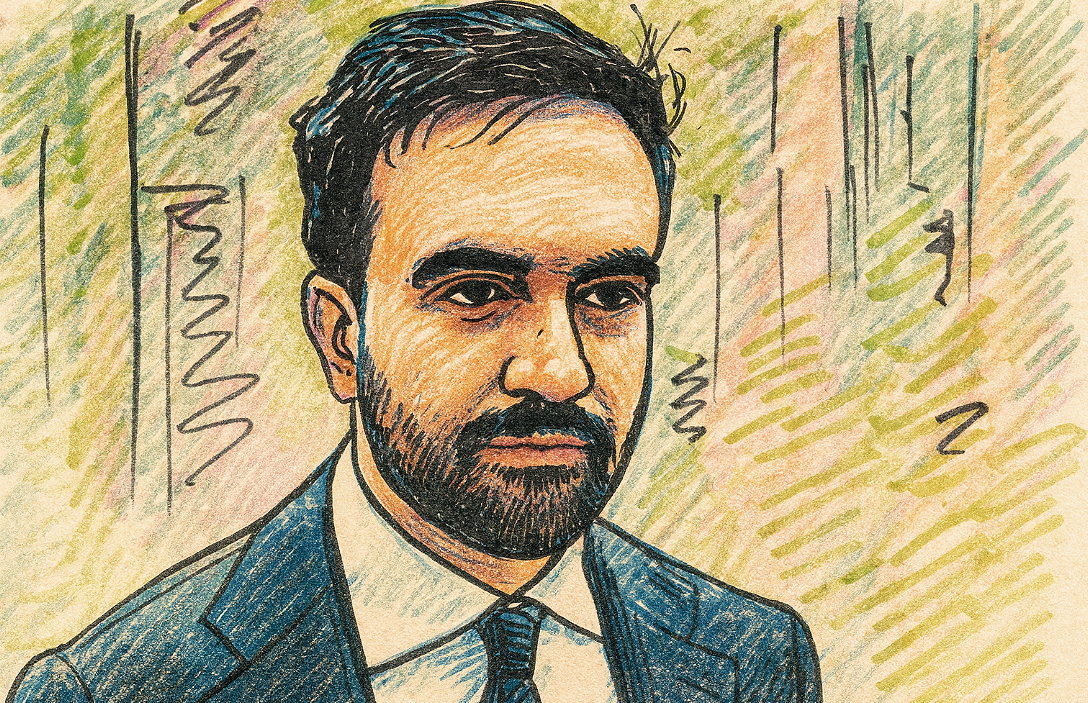Francesca Albanese, oggi Relatrice Speciale ONU per i Territori palestinesi, è diventata la beniamina di quella che potremmo chiamare senza esitazioni il «complesso industriale propalestinese»: un intreccio di ONG, attivisti, accademici e istituzioni che hanno costruito una vera e propria economia ideologica intorno alla causa palestinese. Un sistema che, più che alla difesa dei diritti umani, sembra interessato a perpetuare il conflitto come fonte di risorse politiche, accademiche ed economiche. È in questo contesto che vanno lette le sue posizioni, sempre più indulgenti verso Hamas e sempre meno compatibili con la missione di imparzialità e credibilità che l’ONU dovrebbe incarnare.
Nelle sue dichiarazioni, Albanese si è spinta fino a definire Hamas un mero «organo amministrativo», o a sottolinearne il ruolo nella costruzione di scuole e servizi sociali. È vero che Hamas, nei suoi primi anni, cercò di costruire consenso attraverso l’offerta di cliniche, reti assistenziali e strutture educative. Lo studioso di “Economia del Terrorismo” Eli Berman ha mostrato come per Hamas, e per molti gruppi militanti, fornire beni collettivi sia un modo per legittimarsi agli occhi della popolazione e favorire il consenso. Ma ridurre Hamas a questo, o lasciar intendere che ciò attenui la sua natura terroristica, è una grave distorsione della ricerca empirica su questi temi. Fornire servizi non è mai stato lo scopo primario di Hamas: la sua missione, chiaramente dichiarata, è la distruzione di Israele attraverso la lotta armata. Confondere la tattica con l’essenza equivale a offrirgli una patente di rispettabilità che non merita.
Il problema più profondo è che questo modo di raccontare Hamas riflette l’ideologia del complesso industriale propalestinese. Un’ideologia che non solo normalizza la violenza, ma la nobilita come espressione «di resistenza», trasformando un’organizzazione che pratica esecuzioni sommarie, torture, stupri ed è responsabile di stragi di civili in un attore quasi politico-sociale. Lo stesso meccanismo ha reso l’UNRWA incapace di distinguersi da Hamas a Gaza, trasformandola in strumento più che in garante. E lo stesso meccanismo ha spinto buona parte della cosiddetta «comunità dei diritti umani» a tacere di fronte agli abusi sistematici di Hamas, mentre grida solo contro Israele.
In questo contesto, Francesca Albanese non è un’eccezione ma un sintomo. Il suo ruolo non è più quello di una relatrice indipendente, ma quello di una voce perfettamente integrata in questa macchina ideologica e mediatica. La conseguenza è che il linguaggio dei diritti umani viene svuotato, trasformato in arma retorica di parte, mentre chi davvero subisce Hamas – i palestinesi stessi di Gaza – resta invisibile.
L’Italia non può restare indifferente. Non è solo una questione di politica estera, ma è una questione di credibilità e di valori. Continuare a tollerare la presenza di Albanese in quel ruolo significa legittimare la deriva di un’istituzione internazionale già screditata e, di fatto, tradire la stessa missione universale dei diritti umani.
Per questo chiedere le dimissioni di Francesca Albanese non è un gesto politico contro qualcuno, ma un imperativo morale anche a favore della dignità del popolo palestinese, che deve essere liberato sia dall’oppressione di Hamas sia dall’abbraccio tossico di un’industria ideologica che prospera sulla loro sofferenza.
L’Italia deve smettere di tacere e farsi sentire. E deve farlo ora.
Francesca Albanese e il complesso industriale propalestinese: perché l’Italia deve chiedere le dimissioni
Francesca Albanese e il complesso industriale propalestinese: perché l’Italia deve chiedere le dimissioni
Francesca Albanese e il complesso industriale propalestinese: perché l’Italia deve chiedere le dimissioni