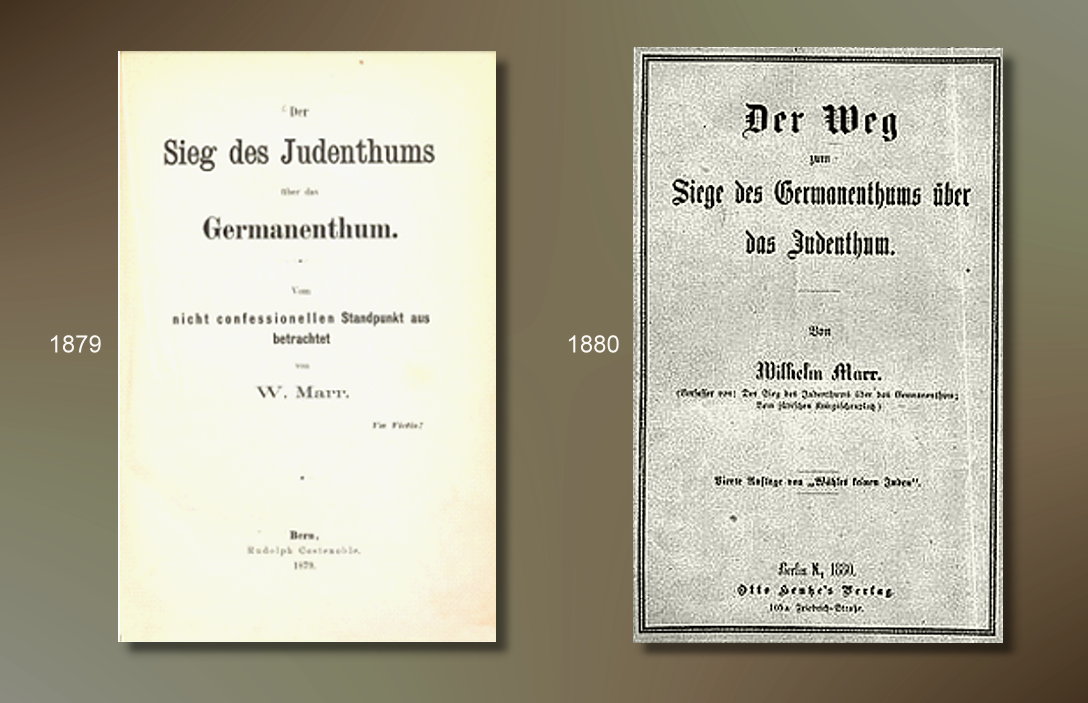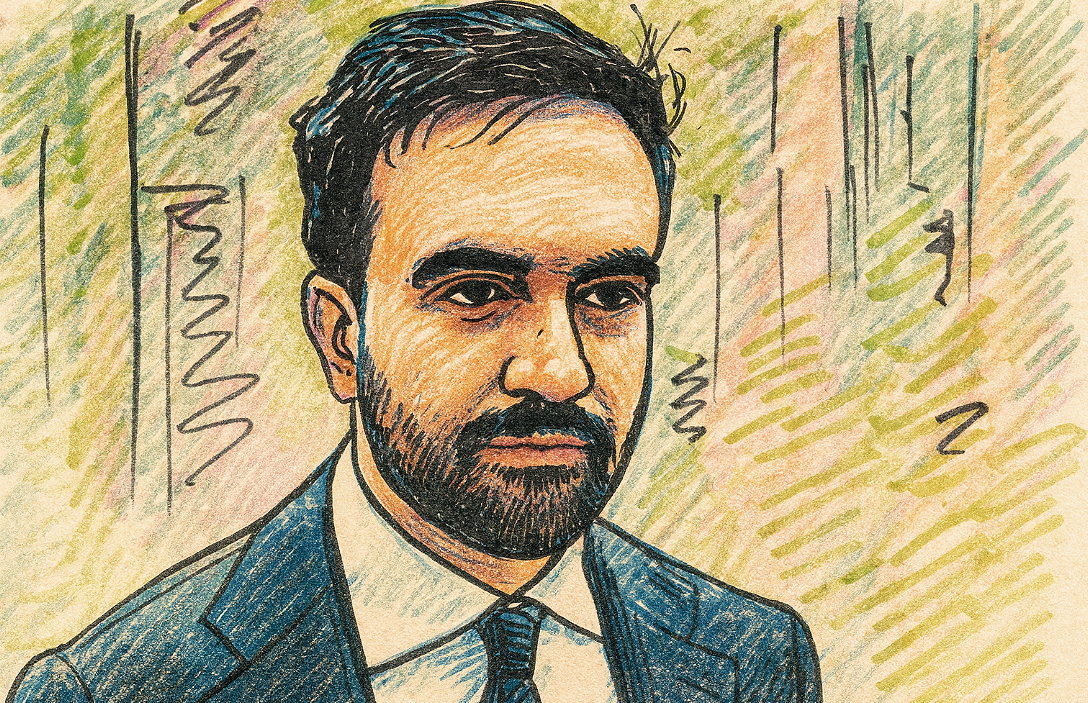Alla fine la musica non l’hanno zittita. Israele sarà in gara all’Eurovision 2026 di Vienna, e questo – al netto delle liriche e dei costumi di scena – è diventato il vero punto del contendere: non una questione artistica, ma un braccio di ferro politico travestito da serata pop. L’Unione europea di radiodiffusione ha votato in segreto, tra spintoni diplomatici e regolamenti ritoccati all’ultimo minuto, per impedire un nuovo voto che avrebbe potuto portare all’esclusione dello Stato ebraico. Risultato: decisione confermata, frattura aperta.
I primi ad alzarsi dal tavolo sono stati Paesi Bassi, Irlanda, Spagna e Slovenia, che hanno annunciato il ritiro immediato. Il popolo se ne farà una ragione. Madrid è andata oltre: la tv pubblica non trasmetterà nemmeno la competizione. Il tutto accompagnato da settimane di pressioni internazionali, accuse di irregolarità nel televoto, appelli alla “moralità” dell’evento e paragoni fuori fuoco con la guerra a Gaza. Quella che avrebbe dovuto essere una festa continentale si è trasformata in un tribunale da campo.
Il presidente israeliano Herzog ha commentato la decisione con una frase che fotografa perfettamente il clima: “È una vittoria contro chi vuole farci tacere”. E non serve amarlo per capire che, di fronte alla campagna di esclusione, la posta in gioco è diventata molto più ampia del ritornello di una canzone.
Nelle settimane precedenti, diversi Paesi avevano minacciato l’ammutinamento se l’UER non avesse sbarrato le porte a Israele. Spagna, Slovenia, Belgio e Turchia hanno guidato il fronte del rifiuto; dall’altra parte, Regno Unito e Svezia hanno ricordato che l’Eurovision nasce proprio per tenere la politica fuori dalla stanza. Londra, con un pragmatismo molto british, ha aggiunto un caveat: Israele deve garantire la piena autonomia della sua radiodiffusione pubblica dal potere politico. Messaggio chiaro, ma di gran lunga più sobrio rispetto al diluvio moralistico che ha attraversato l’assemblea.
L’Ucraina ha sbattuto la porta in faccia a ogni parallelismo tra Israele e la Russia, bandita nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina. Una distinzione che sembra ovvia a chiunque abbia dimestichezza con la realtà, ma che nell’arena infuocata del concorso è diventata improvvisamente materia di negoziato.
Nel frattempo, Kan – l’emittente pubblica israeliana – ha schierato il suo amministratore delegato Golan Yochpaz e la rappresentante Ayala Mizrahi per difendere la posizione del Paese e rispondere punto per punto alle contestazioni. Non è bastato a calmare le acque, ma ha impedito la manovra più estrema: espellere Israele con un secondo voto.
Le modifiche al regolamento approvate dall’UER non sono neutre. Più peso ai giurati nazionali nelle semifinali, dimezzamento dei voti del pubblico da venti a dieci, stretta sui voti considerati “anomali”. Misure che molti osservatori leggono come un modo elegante per ridurre l’entusiasmo degli spettatori pro-Israele, cresciuto negli ultimi anni nonostante tutto.
Resta una verità elementare: l’Eurovision non è mai stato un monastero, ma questa volta la politica ha sfondato le porte con gli anfibi ed Israele entra comunque mentre altri escono con grande rumore. La musica, come sempre, farà quello che può. Adesso proverà a coprire il frastuono. Mica roba da niente, ma Israele a combattuto battaglie ben più dure.
Eurovision, la resa dei conti che non canta
Eurovision, la resa dei conti che non canta