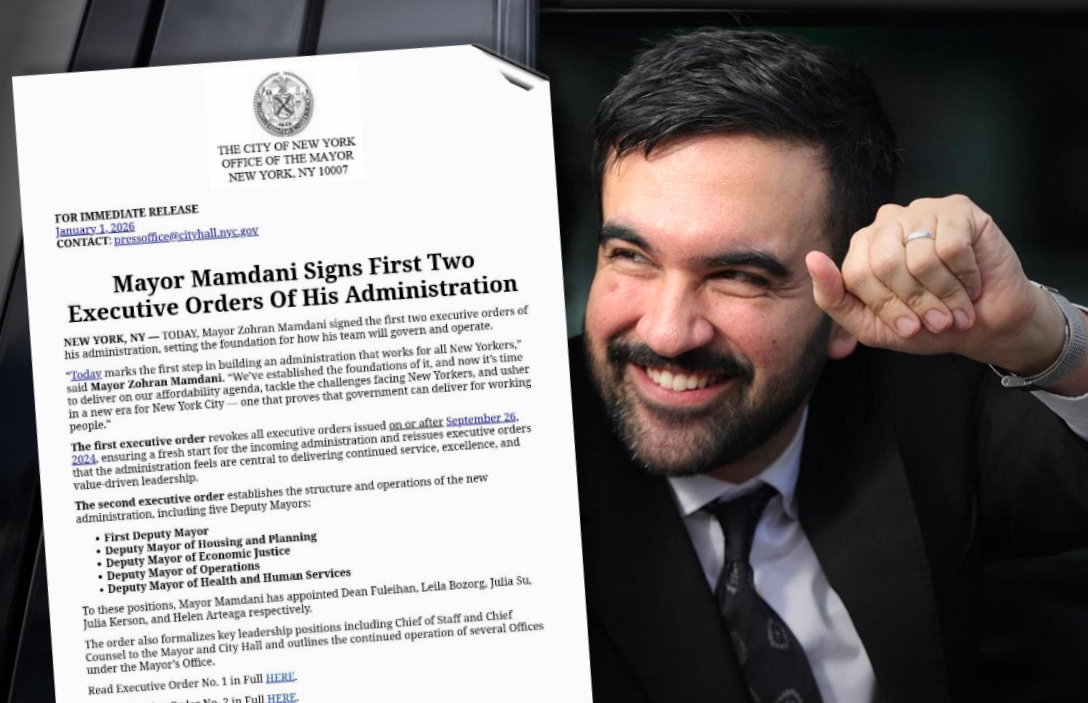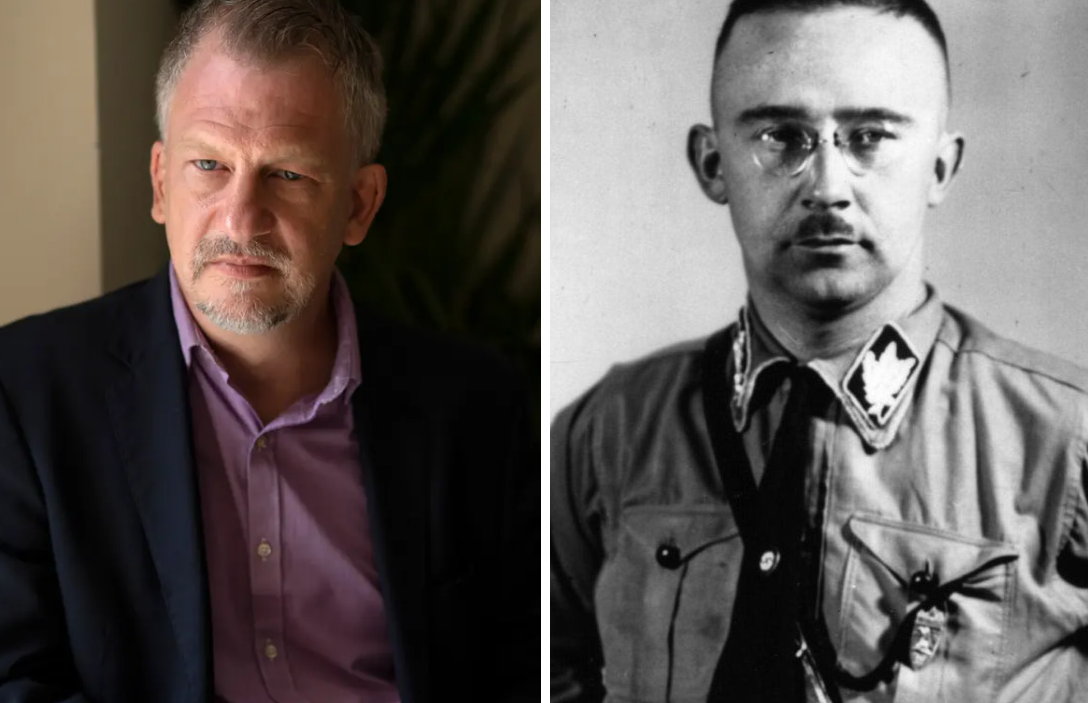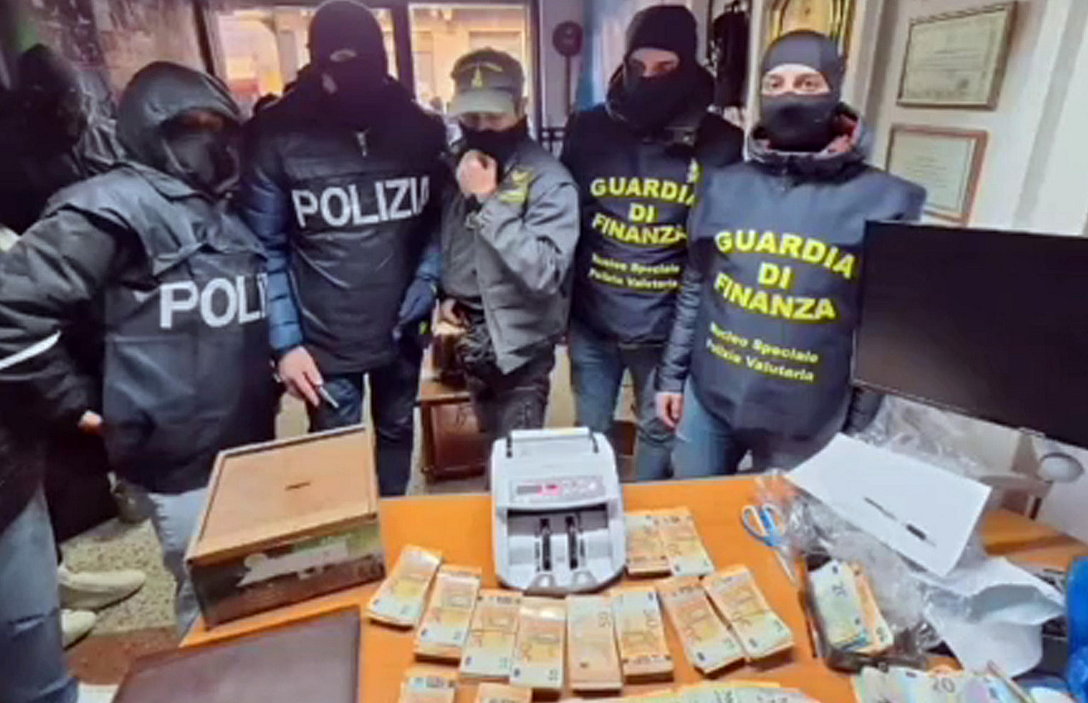Il Regno Unito si è svegliato davanti a un trauma collettivo: l’attacco alla sinagoga di Heaton Park, durante Yom Kippur, non è stato solo l’ennesimo episodio di violenza antiebraica ma un punto di rottura. Due uomini della comunità – Adrian Daulby e Melvin Cravitz – sono stati uccisi da Jihad Al-Shamie, cittadino britannico nato in Siria, poi abbattuto dalla polizia pochi minuti dopo. Un attentato improvviso, spietato, compiuto da un individuo che non figurava in alcuna lista del programma antiterrorismo, e che ha costretto il governo a guardare in faccia una realtà che si preferiva rimandare.
La ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha reagito ordinando una revisione indipendente, affidata a Lord Macdonald, delle leggi che regolano ordine pubblico e crimini d’odio. Una scelta che la politica britannica definisce «storica», perché mette per la prima volta sul tavolo tutto ciò che finora era rimasto confinato a dibattiti sporadici: la capacità delle norme di proteggere le comunità vulnerabili, la gestione di proteste sempre più aggressive, il confine ambiguo tra libertà di espressione e istigazione all’odio, la crescente influenza delle manifestazioni filo-Hamas, la difficoltà delle forze dell’ordine di intervenire con strumenti adeguati ma proporzionati.
Il problema è semplice da enunciare e difficilissimo da risolvere. Una democrazia non può soffocare il diritto di protesta; allo stesso tempo non può accettare che piazze affollate diventino il luogo in cui slogan, minacce e simboli violenti si trasformano in intimidazione delle minoranze. Né può tollerare che la legge resti un guscio vuoto, applicata in modo discontinuo o inefficace, incapace di prevenire atti come quello di Manchester.
La revisione toccherà le definizioni stesse di «offesa aggravata», «ostilità», «istigazione all’odio»: concetti che sulla carta esistono da anni ma che spesso non intercettano i fenomeni reali, oggi accelerati da social network, radicalizzazioni improvvise e movimenti di protesta fluidi, difficili da inquadrare con categorie statiche. Per la polizia si aprirà una discussione altrettanto complessa: quanto potere serve per gestire manifestazioni potenzialmente pericolose senza scivolare nell’arbitrio? E quali margini devono essere introdotti affinché il diritto alla libertà individuale non diventi il paravento per attività che mirano a creare disordine o diffondere odio?
La comunità ebraica britannica guarda alla revisione con un misto di sollievo e timore. Sollievo, perché per la prima volta lo Stato riconosce apertamente che esiste un problema di sicurezza profonda e concreta. Timore, perché qualsiasi riforma rischia di essere troppo lenta o troppo timida rispetto alla rapidità con cui l’odio si organizza e si manifesta. Le famiglie delle vittime chiedono giustizia e protezione, ma ciò che servirà nei prossimi mesi è una strategia che non si limiti a rincorrere l’emergenza: deve prevenire, educare, imporre limiti chiari a chi usa la protesta come scudo per incitare alla violenza.
Il termine fissato dal governo per la conclusione dei lavori è febbraio. È evidente che la posta in gioco va oltre la legislazione britannica: riguarda tutte le democrazie che devono decidere se affrontare l’odio con strumenti adeguati oppure lasciarlo crescere finché non esplode in nuove tragedie. L’attacco di Manchester ha reso impossibile far finta di nulla. Ora bisogna vedere se il Regno Unito avrà il coraggio di correggere le proprie fragilità prima che l’odio diventi di nuovo sangue.
Dopo Manchester, revisione «storica» per leggi su odio e ordine pubblico
Dopo Manchester, revisione «storica» per leggi su odio e ordine pubblico