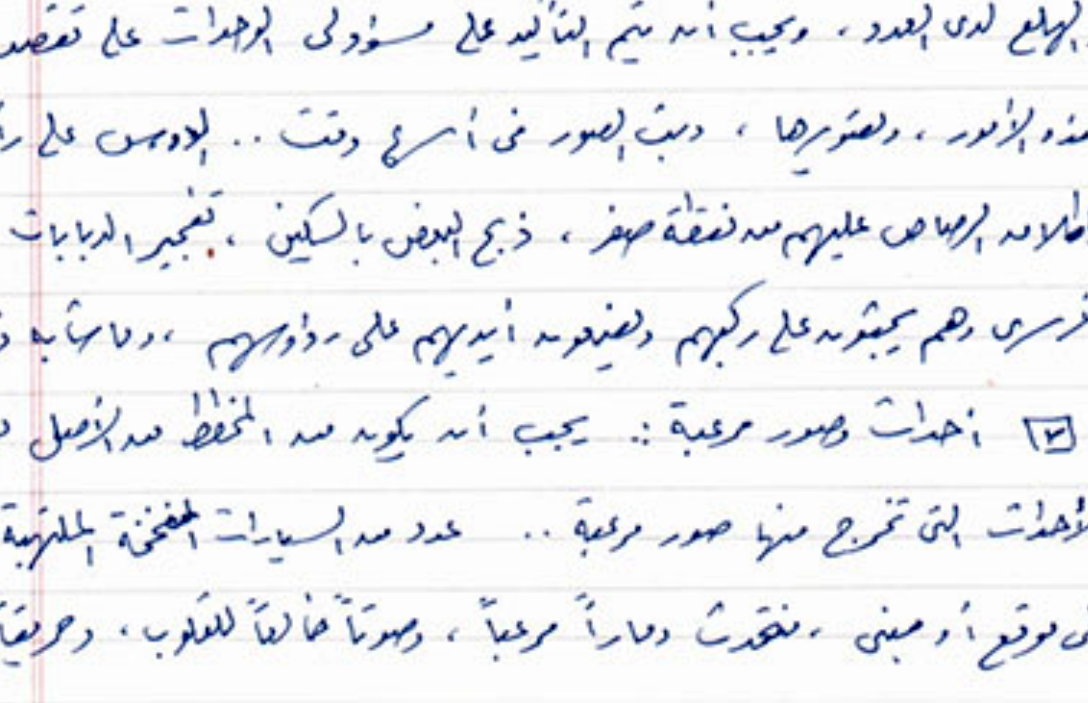Il termometro del mondo ebraico scende, e non per un capriccio stagionale. L’ultima valutazione annuale del JPPI, Jewish People Policy Institute, think tank indipendente con sede a Gerusalemme, consegna un quadro inquietante. Dopo il 7 ottobre, quasi tutte le “sei misure del benessere ebraico” virano in peggio: geopolitica, coesione, resilienza, identità, rapporto con gli Stati Uniti; si salva la demografia, sostenuta dall’energia israeliana, ma con incrinature da non sottovalutare. Non è allarmismo, ma diagnosi seria e necessaria.
Sul fronte geopolitico, Israele è scivolato dalla solidarietà iniziale a un isolamento alimentato anche dall’assenza di una rotta credibile per “il giorno dopo” a Gaza. La guerra macina costi e delegittimazione, tra riconoscimenti statuali pro-palestinesi e dossier giudiziari che trasformano il conflitto in materia penale internazionale. Ne risulta una potenza militare di prim’ordine incastonata in una cornice esterna più ostile e confusa.
La relazione con gli Stati Uniti resta l’àncora, ma un’àncora trascurata non salva nessuno. La cooperazione è intensa; eppure l’erosione bipartisan avanza, corrosa da polarizzazioni speculari e da una retorica interna israeliana che offre bersagli facili. Paradossalmente l’indicatore verso Washington migliora mentre si assottiglia il margine di manovra politica: combinazione efficace sul piano operativo, fragile su quello del consenso.
La resilienza è la spia che lampeggia. Da un lato l’escalation dell’antisemitismo in Occidente, che traveste vecchi veleni con linguaggi nuovi; dall’altro la lawfare, l’uso strategico del diritto come strumento di guerra politica. La somma di odio sociale e assedio legale non colpisce solo l’immagine di Israele: mette a rischio mobilità, sicurezza delle comunità in diaspora e libertà d’azione dell’intero sistema.
La coesione, ricomposta nel trauma, si è di nuovo incrinata. La leva per gli haredim riapre ferite sulla ripartizione degli oneri, mentre la gestione degli ostaggi, la strategia di guerra e l’assenza di un orizzonte politico alimentano diffidenza e risentimento. Una democrazia può reggere guerre lunghe, ma non senza regole condivise.
Se la demografia regge, la fuoriuscita — anche temporanea — di segmenti laici e giovani sottrae capitale umano ai circuiti dell’innovazione. È un’emorragia lenta che indebolisce muscoli cruciali per il futuro.
Infine l’identità: la diaspora organizzata ha reagito con generosità, e tuttavia una parte del mondo progressista e delle generazioni più giovani si allontana, scivolando verso un antisionismo di maniera. Quando i legami affettivi cedono alle caricature ideologiche, ci si ritrova stranieri in casa propria.
Il rapporto non si limita al referto. Servono un obiettivo politico chiaro per l’uscita dalla guerra, un progetto di ricostruzione di Gaza con un’autorità credibile, una disciplina di governo che distingua responsabilità da propaganda, un’iniziativa diplomatica robusta verso Europa e Paesi arabi moderati, l’integrazione strutturale della diaspora nei processi decisionali. E servono regole: una costituzione leggera che stabilizzi il sistema, una riforma che affronti la questione dell’esonero militare per gli haredim, un piano nazionale contro l’antisemitismo e strumenti di attrazione accademica capaci di invertire la fuga dai campus ostili.
Non è un esercizio di stile, ma una necessità politica e morale. Meno slogan e più sostanza; meno scontro performativo e più architettura istituzionale; meno fatalismo e più diplomazia. Il tempo, stavolta, non è neutrale.
Dopo il 7 ottobre: Israele tra isolamento esterno e fratture interne
Dopo il 7 ottobre: Israele tra isolamento esterno e fratture interne
Dopo il 7 ottobre: Israele tra isolamento esterno e fratture interne