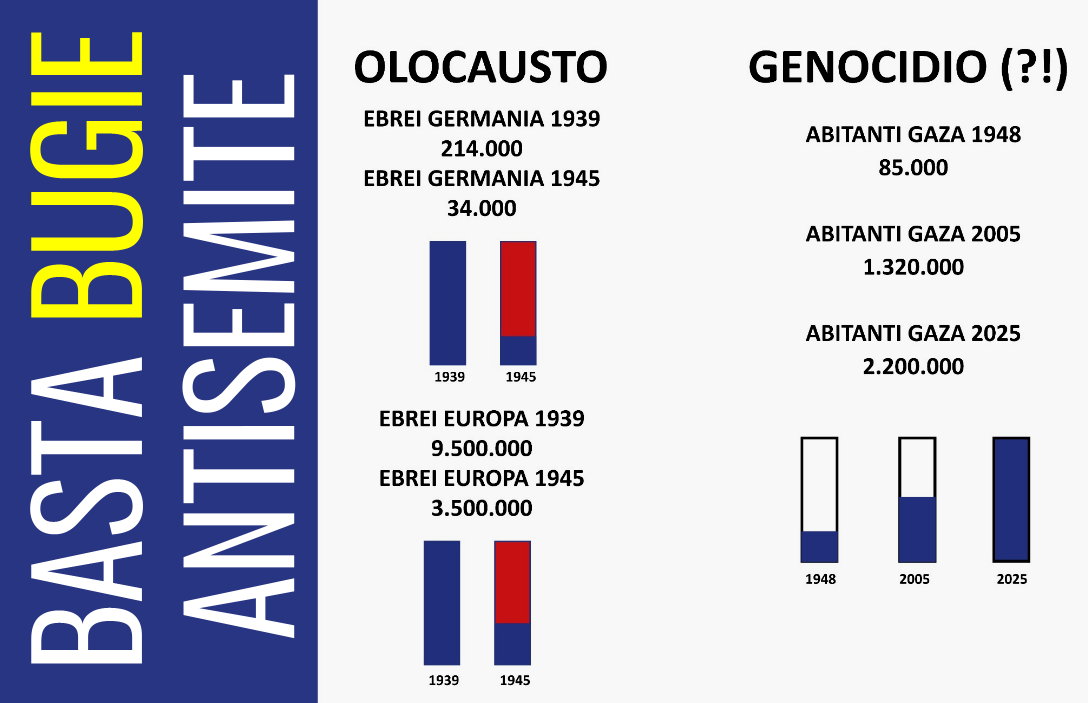L’antisemitismo australiano non è nato il 7 ottobre 2023 ma da quel giorno ha smesso di essere marginale, iniziando a comportarsi da fenomeno sociale: strutturato, imitativo, contagioso.
I numeri aiutano a capire la dimensione, non il gelo che portano con sé. Il principale osservatorio comunitario, l’Executive Council of Australian Jewry, ha registrato 2.062 incidenti nel periodo ottobre 2023–settembre 2024; nel report successivo (ottobre 2024–settembre 2025) gli episodi risultano 1.654. Non è “in calo” nel senso rassicurante del termine: significa che l’eccezione è diventata un nuovo livello di normalità, e quel livello resta, comunque, enormemente superiore agli anni precedenti. E dentro quei numeri non c’è solo il graffito o l’insulto: aumentano anche vandalismi gravi, incendi dolosi, atti che richiedono logiche da sicurezza nazionale, non da ordinaria amministrazione.
Episodio spartiacque, già nell’ottobre 2023, fu la manifestazione davanti alla Sydney Opera House, che trasformò un luogo simbolico in una scena da allarme civico: non tanto per il numero dei partecipanti, quanto per la sensazione, chiarissima, che una parte del discorso pubblico stesse perdendo i freni. Il sottotesto era: se può accadere qui, può accadere ovunque.
Da lì in poi, il passo verso la violenza non è stato immediato ma coerente. Nel dicembre 2024 l’Australia ha avuto un salto qualitativo nella percezione del rischio: l’attacco incendiario a una sinagoga a Melbourne (indagato come atto di terrorismo) ha costretto Canberra a trattare l’antisemitismo non come somma di “incidenti d’odio”, ma come possibile filiera: istigazione, emulazione, radicalizzazione, coordinamento. È in quel contesto che l’Australian Federal Police ha lanciato la Special Operation Avalite, una struttura investigativa dedicata che mette insieme competenze federali e intelligence (con ASIO) su minacce, reati e reti, inclusi quelli che passano dalle piattaforme digitali.
Nel luglio 2024 il governo Albanese ha nominato Jillian Segal AO (Ufficiale dell’Ordine d’Australia) come Inviata Speciale alla Lotta all’Antisemitismo. Non una carica ornamentale ma il riconoscimento, tardivo, della necessità di una regia nazionale, perché l’antisemitismo contemporaneo è un fenomeno a cavallo tra comunità locali e geopolitica, tra ordine pubblico e cultura, tra scuole e algoritmi. Nel 2025 l’Inviata ha pubblicato un piano con un dato che fotografa la velocità della degenerazione: tra ottobre 2023 e settembre 2024 gli episodi sono cresciuti di oltre tre volte, con un impatto che ha spostato la questione dal “vivere bene insieme” al “vivere sicuri”.
C’è poi il capitolo legislativo: nel 2025 sono state rafforzate norme federali e statali (in particolare nel New South Wales) contro minacce, istigazione alla violenza, simboli d’odio e condotte mirate contro gruppi protetti. Anche qui, il punto non è il dibattito tecnico, ma il segnale: lo Stato ha ammesso che non bastavano le formule generiche contro la discriminazione; servivano strumenti pensati per un clima in cui l’odio si presenta come attivismo e la minaccia come opinione “forte”.
Fin qui, la politica. Ma la parte più scomoda è culturale, e l’Australia la sta affrontando con lentezza. Perché l’antisemitismo post-7 ottobre ha una caratteristica specifica: si è mimetizzato in un linguaggio morale. Non si presenta come “odio per gli ebrei” (troppo brutale, troppo riconoscibile), ma come ossessione per Israele elevata a identità. È un meccanismo che produce due risultati: normalizza l’idea che l’ebreo sia comunque sospetto, e concede a chi aggredisce una giustificazione preventiva (“non ce l’ho con te, ce l’ho con…”). Nella vita reale quella distinzione regge pochi secondi, poi cade: perché la vetrina colpita è kosher, la scuola vandalizzata è ebraica, la persona insultata per strada non è un governo a Gerusalemme, è un cittadino australiano.
Questo slittamento ha spaccato anche il modo in cui le istituzioni reagiscono. Da un lato condanne ufficiali nette: Albanese, il ministro degli Interni Tony Burke, l’Attorney-General Mark Dreyfus, i vertici di AFP e ASIO hanno ripetuto più volte che non c’è posto per l’antisemitismo. Dall’altro, la sensazione diffusa (anche dentro la comunità ebraica, espressa pubblicamente dai suoi rappresentanti) che per mesi si sia avuto timore di “toccare” la questione con la forza necessaria: paura di polarizzare, di irritare piazze già calde, di pagare prezzi elettorali. Il risultato è la classica trappola occidentale: si aspetta troppo, e quando si interviene lo si fa sotto pressione, dopo che il problema ha già conquistato spazio.
E poi, il 14 dicembre 2025, Bondi Beach che considera un evento ebraico come bersaglio legittimo ed è il risultato di un bienniio in cui si è permesso condisiderare “gli ebrei” un concetto su cui sfogarsi, e Israele la scorciatoia retorica per dirlo ad alta voce senza pagare costo sociale. Quando le università tollerano ambiguità ideologiche che diventano intimidazione, quando i media rincorrono la semplificazione emotiva, quando i partiti preferiscono la gestione dell’immagine alla gestione del rischio, quando le piattaforme trasformano ogni conflitto in una guerra di clip. Non serve un grande complotto: basta una lunga serie di piccole viltà, e poi qualcuno, prima o poi, si sente autorizzato a fare il salto.
Se tratti l’antisemitismo come rumore di fondo, diventa un linguaggio. Se diventa un linguaggio, diventa un’abitudine. E quando diventa un’abitudine, prima o poi diventa sangue. Bondi Beach non è un “cambio di fase”: è la fase a cui si arriva quando si finge che la fase precedente fosse soltanto retorica.
Australia. L’antisemitismo e le scoperte in ritardo
Australia. L’antisemitismo e le scoperte in ritardo