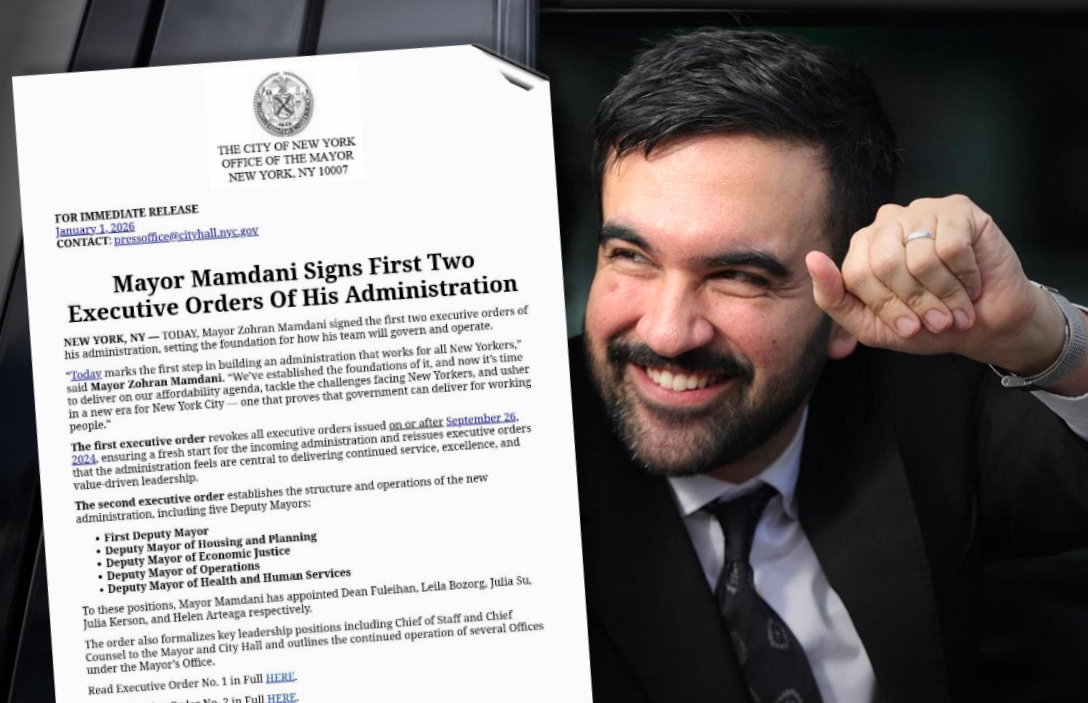Non sono l’islamismo, né un antisemitismo classico, né la pressione di grandi minoranze musulmane a spiegare perché alcuni Paesi europei siano diventati i critici più sistematici e rumorosi di Israele dopo il 7 ottobre. È la conclusione, controintuitiva ma ben documentata, di un rapporto in uscita del centro di ricerca sull’ebraismo europeo contemporaneo dell’Tel Aviv University, curato da Uriya Shavit e Uzi Rabi.
Lo studio prende in esame otto Paesi – Irlanda, Islanda, Belgio, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Slovenia e Spagna – indicati come il gruppo più coerente e attivo nel contestare Israele sul piano politico e diplomatico. Li chiama P-8. Ed è proprio qui che cade il primo luogo comune: in sei di questi Paesi la popolazione musulmana è inferiore alla media europea. In Islanda è circa l’1%, in Irlanda il 2%, in Slovenia, Malta e Lussemburgo tra il 3 e il 4%. Anche in Spagna, dove la percentuale è leggermente più alta, meno della metà dei musulmani ha la cittadinanza e l’impatto politico resta marginale. Il voto musulmano, semplicemente, non spiega.
Se non è demografia ma storia. O meglio: vulgata nazionale. Infatti molti di questi Paesi non portano sulle spalle un senso di colpa legato alla Shoah. Sono stati neutrali durante la Seconda guerra mondiale, oppure il loro ruolo nei confronti degli ebrei non è mai diventato un tema centrale del dibattito pubblico. Risultato: criticare Israele politicamente non costa nulla, non richiede premesse né cautele né giri di parole. Laddove in Germania o in Austria ogni frase su Israele passa attraverso un filtro di responsabilità storica, in Irlanda, Spagna o Islanda quel filtro semplicemente non esiste.
C’è poi un fattore più prosaico, ma decisivo: l’assenza israeliana. In cinque degli otto Paesi analizzati Israele non ha un’ambasciata né un ambasciatore residente. In quelli dove è presente – Norvegia, Belgio e Spagna – le comunità ebraiche sono piuttosto scarse numericamente e la capacità di incidere nel dibattito pubblico è limitata. Il terreno resta libero per attori pro-palestinesi ben organizzati, spesso da decenni. Il caso islandese è emblematico: un singolo attivista palestinese, arrivato nel Paese negli anni Settanta, ha avuto spazio e tempo per costruire una narrazione senza contraddittorio, fino a incidere sulle scelte ufficiali dello Stato.
Il rapporto individua anche una convergenza politica: tutti i Paesi del P-8 sono governati da coalizioni di sinistra o centro-sinistra, o da esecutivi che dipendono in modo decisivo da forze progressiste. Parlano un linguaggio diverso da quello israeliano attuale, soprattutto su temi come guerra, diritti, uso della forza. Non è una deviazione occasionale: è una distanza strutturale tra visioni del mondo. In questo quadro, posizioni israeliane che evocano annessioni o trasferimenti non trovano alcun interlocutore credibile in Europa.
A tutto questo si aggiunge una forma di attivismo a basso rischio. Questi Paesi non hanno un peso decisivo in Medio Oriente, non sono pilastri della sicurezza europea, non sono attori centrali nel confronto con Russia o Cina. Invece possono permettersi dichiarazioni, mozioni e lodati riconoscimenti simbolici. Qualcuno lo chiama “virtue signaling”: prese di posizione che non cambiano gli equilibri ma rafforzano l’identità morale interna. Che non è roba da poco. In alcuni casi, però, il simbolico diventa concreto, come gli embarghi o i boicottaggi decisi da Spagna e Slovenia, che rischiano di fare scuola.
Infine, c’è il mito dell’underdog, e cioè chi è percepito come strutturalmente più debole in uno scontro asimmetrico, indipendentemente da chi abbia ragione o torto. Sei di questi Paesi hanno costruito la propria identità nazionale attorno a una lotta di liberazione contro una potenza più forte. Oggi, quella lente viene automaticamente applicata al conflitto israelo-palestinese: i palestinesi come Davide, Israele come Golia. Una lettura che nel 1948 avrebbe potuto favorire il sionismo, ma che nel 2026 si rovescia completamente.
Il rapporto non dipinge un’Europa “perduta”. Al contrario, suggerisce che Israele abbia ancora margini, a patto di cambiare approccio con una presenza diplomatica stabile ovunque, un lavoro paziente con media e degli opinion leader locali, un dialogo con le socialdemocrazie europee, una distinzione netta tra critica legittima e antisemitismo reale. Soprattutto, la fine dell’alibi più comodo: attribuire tutto all’odio o all’Islam. È una spiegazione rassicurante, ma falsa. E finché Israele continuerà a crederci, lascerà ad altri il racconto dell’Europa.
Antisemitismo. I critici più duri di Israele in Europa
Antisemitismo. I critici più duri di Israele in Europa