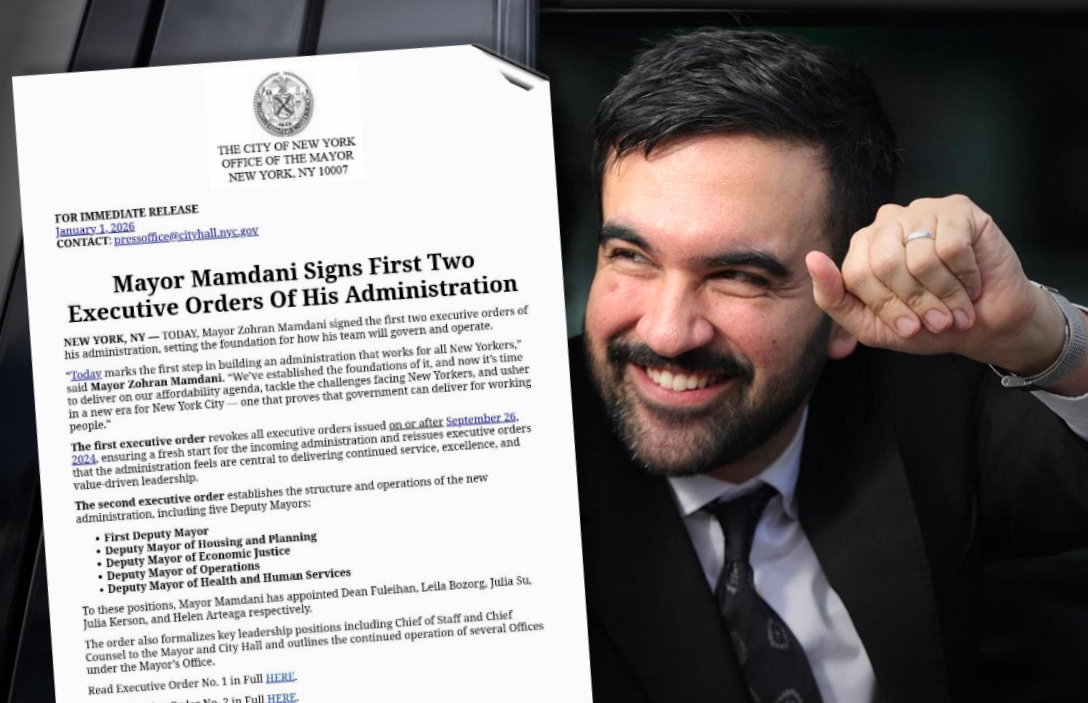Il rientro a Londra di Alaa Abdel Fattah, dopo anni di detenzione nelle carceri egiziane e la grazia concessa dal presidente Abdel Fattah el-Sisi, è stato accolto dal governo britannico come un successo politico e morale. Il primo ministro Keir Starmer ha parlato di una “priorità assoluta”, ringraziando il Cairo e rendendo omaggio alla famiglia dell’attivista. Il linguaggio è quello consueto delle buone cause occidentali: diritti, libertà, riunificazione familiare.
Vale però la pena di ricordare l’intero tragitto politico di questo personaggio. Abdel Fattah è stato a lungo il volto simbolico della rivolta che nel 2011 portò alla caduta di Hosni Mubarak. Blogger, attivista, intellettuale radicale, ha incarnato per molti osservatori occidentali l’idea di una Primavera araba laica e progressista, finalmente allineata ai valori liberali. Anche la sua lunga detenzione, culminata in condanne ripetute e in un regime carcerario durissimo, è stata raccontata come la prova definitiva dell’autoritarismo del regime egiziano.
Il problema nasce altrove, in una zona che i comunicati ufficiali e una parte consistente dei media preferiscono sorvolare con discrezione. Prima di diventare il “prigioniero politico più famoso d’Egitto”, Abdel Fattah aveva lasciato tracce scritte inequivocabili di un pensiero tutt’altro che encomiabile. Nei suoi post dei primi anni Dieci, l’attivista non si limitava a una critica aspra di Israele, ma arrivava a definire “eroico” l’uccidere i sionisti, civili compresi, invocandone l’eliminazione senza ambiguità.
Non si trattava di boutade isolate – ammesso e non concesso che su un tema del genere possano esistere boutade – né di frasi estrapolate con malizia. Erano prese di posizione coerenti, reiterate, firmate. Un linguaggio di incitamento alla violenza che oggi scompare dal racconto pubblico, come se fosse un dettaglio imbarazzante da archiviare in nome di una causa ritenuta superiore.
La questione riguarda il modo in cui l’Occidente seleziona ciò che ricorda e ciò che preferisce dimenticare. Abdel Fattah viene celebrato come dissidente, vittima di un regime repressivo e cittadino britannico finalmente riaccolto a casa. Il suo antisemitismo esplicito, però, viene rimosso dal discorso pubblico. Una rimozione che non è casuale, ma rivela un riflesso ormai consolidato: la tendenza a sospendere il giudizio quando l’odio si dirige verso Israele o verso i “sionisti”, categoria elastica che consente di normalizzare parole e concetti che, se rivolti a qualsiasi altro gruppo, verrebbero giustamente considerati inaccettabili.
Nel contesto britannico, dove il dibattito sull’antisemitismo ha già mostrato crepe profonde negli ultimi anni, la celebrazione acritica del ritorno di Abdel Fattah assume un significato che va ben oltre il singolo caso. Diventa il sintomo di una difficoltà strutturale nel chiamare le cose con il loro nome.
C’è poi un ulteriore livello, più squisitamente politico. Ringraziare pubblicamente al-Sisi per la grazia significa riconoscere, implicitamente, che il dossier dei diritti umani può essere gestito come una leva diplomatica, da azionare quando conviene e da accantonare quando diventa scomodo. Abdel Fattah torna a Londra come simbolo, mentre migliaia di altri detenuti egiziani restano invisibili, privi di cittadinanze occidentali spendibili e, soprattutto, di un racconto mediaticamente utile.
Il ritorno di Alaa Abdel Fattah non è uno scandalo né una tragedia. È piuttosto uno specchio che riflette l’incapacità occidentale di tenere insieme due elementi che dovrebbero coesistere: la difesa dei diritti individuali e la chiarezza morale sul linguaggio dell’odio. Separarli, come ha fatto il governo laburista, produce una storia incompleta, in cui la complessità viene sacrificata sull’altare della buona coscienza. E prima o poi, questa semplificazione presenta il conto. A dire il vero, lo ha già presentato.
Alaa Abdel Fattah, Londra e l’amnesia selettiva dell’Occidente
Alaa Abdel Fattah, Londra e l’amnesia selettiva dell’Occidente