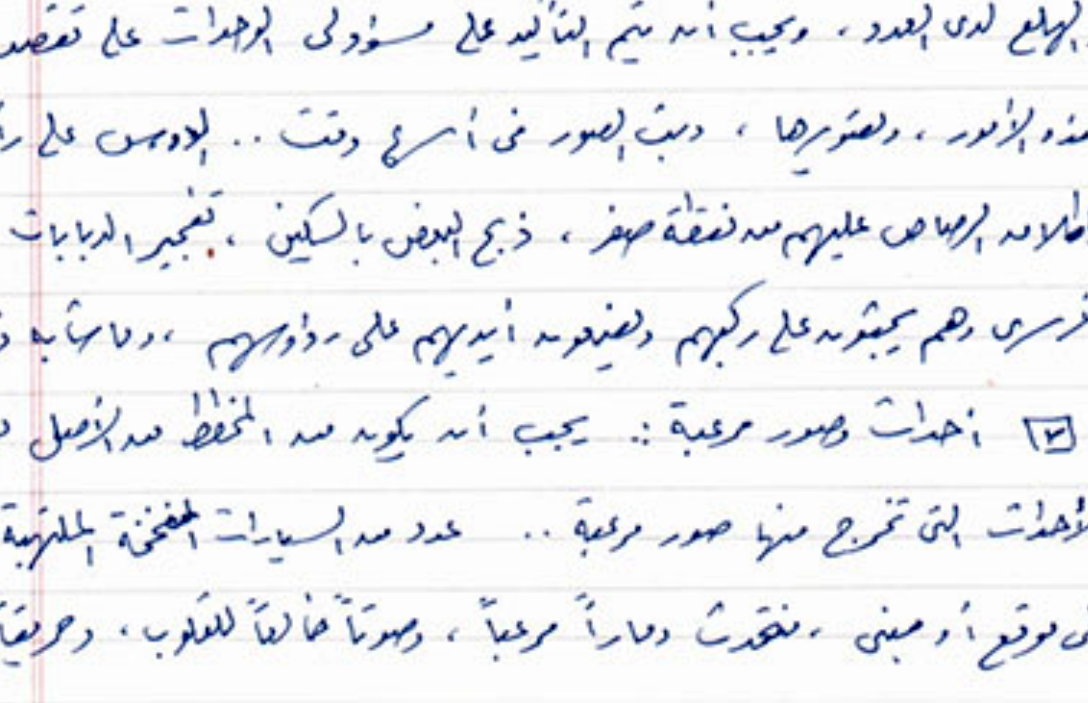È stato uno spettacolo surreale, quell’intervista rilasciata da Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, al giornalista Arad Nir di N12, il principale canale televisivo d’informazione israeliano. Il presidente dell’Autorità Palestinese, davanti alle telecamere, ha provato a indossare i panni dello statista, ma è apparso come un pugile suonato: con la guardia abbassata, gli occhi stanchi, incapace ormai di difendersi dai colpi della storia che lui stesso ha provocato. Ogni sua frase sembrava un tentativo di restare in piedi più che di dire qualcosa.
L’intervista lo ha mostrato per quello che è: un uomo logorato dal potere, mantenuto in vita solo dalla corruzione del sistema che lo circonda, prigioniero del disprezzo per il proprio popolo e della paura di perdere i privilegi che lo hanno reso intoccabile per vent’anni. Abu Mazen ha cercato di dipingersi come voce della moderazione, l’unico in grado di dialogare con Israele, ma sotto la patina di equilibrio si intravedeva solo l’inerzia.
Ha promesso di «lavorare per la riconciliazione» tra Hamas e Fatah, ma non ha detto come. Ha parlato di uno Stato palestinese «che viva accanto a Israele», ma senza nominare i massacri del 7 ottobre. Ha citato la «resistenza del popolo palestinese», ma non ha mai avuto il coraggio di condannare chi usa quella parola per giustificare il terrore. Ogni volta che gli è stato chiesto di assumersi responsabilità concrete, è scivolato nel linguaggio dell’ambiguità, dove tutto è possibile e nulla è vincolante.
Nel mondo occidentale c’è ancora chi lo considera un interlocutore indispensabile. In realtà, Abbas non governa: gestisce. Ramallah è da anni un labirinto di burocrazie, parentadi, stipendi gonfiati, incarichi distribuiti come ricompense di fedeltà. L’Autorità Palestinese non è uno Stato, è un sistema di sopravvivenza personale. Finché scorre il denaro dei donatori e il potere resta concentrato nel cerchio ristretto dei fedeli, il meccanismo continua a funzionare. È una macchina arrugginita che vive di inerzia e paura.
Abu Mazen sa che fuori da quel sistema non ha più nulla. Non ha consenso, non ha legittimità, non ha futuro. Le sue elezioni si sono trasformate in riti cancellati, i giovani palestinesi lo considerano un relitto, e perfino gli apparati di sicurezza non lo rispettano: lo tollerano. In un contesto simile, ogni sua apparizione televisiva diventa un esercizio di sopravvivenza politica.
Israele, da parte sua, non lo teme e non lo vuole davvero sostituire. Abbas serve proprio perché è debole: è l’interlocutore ideale di chi preferisce uno status quo gestibile a una leadership imprevedibile. Tenerlo al potere significa mantenere la situazione congelata. Il suo destino è quello dei tiranni minori: resistere abbastanza a lungo da non essere più percepiti come una minaccia, ma come un’abitudine.
Alla fine dell’intervista, il volto di Abu Mazen diceva tutto. Non c’era più convinzione, solo stanchezza. Parlava di pace con il tono di chi non ci crede più, evocava il futuro con le parole di chi ha paura del domani. Un pugile suonato che barcolla al centro del ring, tenuto in piedi non dal popolo che dice di rappresentare, ma dai guardiani di un potere che non sa più spegnere. Un uomo che non guida più nessuno, ma che nessuno osa ancora lasciare cadere.
Abu Mazen, il pugile suonato della politica mediorientale
Abu Mazen, il pugile suonato della politica mediorientale
Abu Mazen, il pugile suonato della politica mediorientale